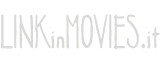Un affare di famiglia - Recensione
- Scritto da Francesco Siciliano
- Pubblicato in Asia
- Stampa
- Video
- Commenta per primo!
 Hirokazu Koreeda esplora le dinamiche di una famiglia indigente che vive di piccoli taccheggi, spostando il centro della sua attenzione dai legami di sangue a quelli elettivi. Trionfatore del Festival di Cannes 2018, Un affare di famiglia si prende molti rischi, ma con alcune lacune che non possono non instillare il dubbio di una Palma d’oro assegnata in modo un po’ generoso
Hirokazu Koreeda esplora le dinamiche di una famiglia indigente che vive di piccoli taccheggi, spostando il centro della sua attenzione dai legami di sangue a quelli elettivi. Trionfatore del Festival di Cannes 2018, Un affare di famiglia si prende molti rischi, ma con alcune lacune che non possono non instillare il dubbio di una Palma d’oro assegnata in modo un po’ generoso
La Palma d’oro allo scorso Festival di Cannes ha portato alla ribalta internazionale Hirozaku Koreeda. Il massimo riconoscimento della rassegna francese rischia però di trarre in inganno o forse di deludere le (troppe) aspettative per l’ultima fatica del regista. Perché il premio a Un affare di famiglia (ennesimo titolo potenzialmente fuorviante della nostra distribuzione: l’originale è Manbiki kazoku, ovvero letteralmente Famiglia taccheggiatori) è giustamente la consacrazione – magari tardiva – di quello che è a tutti gli effetti uno dei più grandi cineasti giapponesi viventi. Guai però a pensare al riconoscimento come a una medaglia al valore assoluto di un’opera rispetto ai lavori che l’hanno preceduta. In altre parole, Un affare di famiglia non è certo il miglior film di Koreeda, semmai forse quello più facile e accessibile da premiare tra i titoli che compongono la sua filmografia.
Sappiamo che il regista giapponese ha fatto dei rapporti famigliari la sua materia di studio, restringendo il campo, negli ultimi lavori, all’analisi di situazioni atipiche in cui la definizione di famiglia travalica i legami di sangue. Il tormento irriducibile in Father and Son di due coppie di coniugi che scoprono di aver cresciuto per sei anni un figlio che non è però il loro vero figlio biologico, la convivenza inaspettata in Little Sister di tre sorelle con una sorellastra lasciata in ‘eredità’ dal defunto padre che le aveva abbandonate in tenera età, il dramma trattenuto al centro di Ritratto di famiglia con tempesta di un uomo che deve reinventarsi come padre e come (ex) marito in seguito a una dolorosa separazione, mostravano i segni dell’interesse crescente di Koreeda per una condizione esistenziale in cui gli individui sono chiamati a costruirsi nuovi vincoli di fronte alla ridefinizione del proprio nucleo famigliare. Un affare di famiglia è l’estrema evoluzione dell’ultimo Koreeda: un film che tenta con ancora più forza rispetto ai lavori precedenti di esplorare i legami famigliari in un contesto di affetti non convenzionali.
In una vecchia casa fatiscente, un’abitazione in stile tradizionale giapponese come non se ne vedono più nella periferia tranquilla e residenziale di Tokyo, vivono una donna anziana, le sue due giovani nipoti, il compagno di una delle due e un adolescente senza padre né madre. Miseria e stenti scandiscono le giornate di uno strano quintetto familiare: la pensione sociale dell’anziana non basta per sfamare tutti, le due nipoti sbarcano il lunario come possono (una si esibisce in un peep-show, l’altra lavora come stiratrice in un’azienda in crisi), così a provvedere al sostentamento di tutti ci pensano spesso la destrezza e il sangue freddo dell’uomo e del ragazzino, esperti nell’organizzare e portare a termine con successo piccoli furti nei negozi da cui sottraggono cibo, bevande e prodotti per l’igiene personale. Una notte d’inverno rientrando a casa si accorgono della presenza per strada di una bambina che sembra essere stata maltrattata e abbandonata. Decidono di offrirle riparo dal freddo portandola nella loro abitazione. Ben presto quella che doveva essere una permanenza breve diventa una convivenza lunga, visto che la bambina si sente protetta e non ne vuole sapere di ritrovare i suoi genitori.
Mentre le giornate scorrono sullo schermo tra tante difficoltà quotidiane ma anche tra piccoli gesti che nascondono una grande umanità, lo spettatore si chiede: cosa ha indotto queste persone a vivere nell’indigenza e a stare tutte insieme sotto lo stesso tetto? Il mistero aleggia sulla storia, fino a quando un incidente non scatena una serie imprevista di eventi che rivelerà la vera natura dei rapporti tra i membri del nucleo familiare e il loro oscuro passato.
Attraverso una storia di forte impatto e con alcuni colpi di scena per nulla scontati, Koreeda tiene lo spettatore con gli occhi incollati allo schermo fino alla fine di un percorso in cui prende corpo un’utopia: l’idea di una dinamica famigliare in cui i legami elettivi possano sostituire quelli di sangue. I personaggi di Un affare di famiglia sono infatti individui che cercano una sorta di autodeterminazione famigliare: liberi da condizionamenti, membri di un nucleo senza figure di riferimento ingombranti come possono essere un padre o una madre, si bastano a se stessi per una precisa volontà che scopriremo solo strada facendo. Se la famiglia intesa come vincolo di sangue diventa inevitabilmente un fardello che condiziona le nostre esistenze o una fonte di un senso di profonda inadeguatezza, come ha declinato Koreeda in passato, esistono quindi altre variabili in grado di superarla e sostituirla? La risposta prende la forma di una ricerca dai contorni ambigui e indistinti di una verità che tarda ad arrivare e che non fornisce certezze, perché la natura umana fa sì che i legami, che siano essi di sangue, affettivi o elettivi, siano alla fin fine un groviglio dentro cui si nascondono in egual modo egoismi, tradimenti, fragilità, bassezze umane. Sotto questa luce acquista ancora più spessore il lavoro che ha preceduto Un affare di famiglia, quel The Third Murder che pareva un unicum nella filmografia del regista con la sua storia da classico legal drama, e che invece mostrava già le scaturigini di una sospensione di giudizio e di un’ambiguità di sguardo ormai propria di Koreeda che fa il paio con una presa di coscienza della dualità dei rapporti nella sfera degli affetti famigliari: della loro rappresentazione mai univoca, ma anzi ambivalente.
Rispetto però ai lavori precedenti, film in cui per lo più Koreeda raccontava in scioltezza storie in divenire che davano la sensazione di non avere un vero inizio né una vera conclusione, in Un affare di famiglia si perde un po’ di quella naturalezza, schiacciata sotto il peso programmatico dell’operazione condotta dal regista, dalla sua voglia di incastonare alla perfezione i singoli pezzi di un puzzle minuzioso, complesso, studiato nei minimi dettagli in funzione delle sorprese finali, con i personaggi trattati come l’enunciato di un teorema da dimostrare. Se lo stile della messa in scena non si discute, ennesimo lavoro di fino di regia di Koreeda che scandisce le emozioni del racconto attraverso un continuo gioco di distanze della macchina da presa dai corpi e dai volti, lascia invece perplessi la scarsa risolutezza sul piano della scrittura: la caratterizzazione non impeccabile dei personaggi (in primis quello di una delle due nipoti dell’anziana), i loro vuoti narrativi che nemmeno il ‘finale risolutore’ riesce a riscattare in pieno e alcune scorciatoie sentimentali che rischiano di svilire certi passaggi importanti. Imperfezioni che non sempre vengono compensate dai non pochi momenti di grande cinema che si scolpiscono nella memoria dello spettatore (le scene sulla spiaggia e la rincorsa dell’autobus sono tra quelle che restano più impresse).
Un affare di famiglia è sicuramente un buon film che si prende molti rischi, ma alcune lacune ne limitano la forza espressiva e ce lo fanno amare meno di altri titoli targati Koreeda (e qui il pensiero corre a Nessuno lo sa, altro film transitato a Cannes diversi anni fa, più misurato e sconvolgente, quello sì da Palma d’oro). Da menzionare la prova di Sakura Ando, che in una sequenza verso la fine, quando lascia finalmente sfogare le contraddizioni silenziose che albergano nell’animo del suo personaggio, dimostra di essere una delle più talentuose attrici in circolazione.
http://www.linkinmovies.it/cinema/asia/un-affare-di-famiglia-manbiki-kazoku-recensione#sigProIde43c82d16b