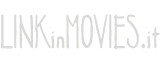Festival di Cannes 2019, promossi e bocciati: guida ai film
- Scritto da Antonio Termenini
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Commenta per primo!
 In occasione del 72esimo Festival di Cannes, ecco i giudizi del nostro inviato ai film visionati nelle varie sezioni. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 12 giorni
In occasione del 72esimo Festival di Cannes, ecco i giudizi del nostro inviato ai film visionati nelle varie sezioni. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 12 giorni
In concorso I morti non muoiono (The Dead Don't Die), di Jim Jarmusch (Stati Uniti, Svezia)
I morti non muoiono (The Dead Don't Die), di Jim Jarmusch (Stati Uniti, Svezia)![]()
A Centervile i morti non muoiono, come dice il titolo, e succedono tante altre cose bizzarre. Incontrollate. Volutamente. Perché prima di tutto, questa di Jarmusch, che ha inaugurato il 72esimo Festival di Cannes è un’operazione molto consapevole, studiata nei minimi dettagli. Il regista di Ghost Dog - Il codice del samurai riunisce vecchie e nuove glorie del suo immaginario, da Bill Murray ad Adam Driver, mette assieme in uno scatenato e, a tratti, irrisolto patchwork, le fonti dell’immaginario che più gli sono vicine, la cinefilia, la musica, il ritratto di un’America provinciale e nerd, scentrata, non riconciliata.
Jarmusch non sceglie un registro. La sua ultima opera intende essere la summa di tutto quanto fino ad ora realizzato ma anche amato, dalla musica punk rock al cinema horror di Carpenter a quello di Craven, fino a George Romero. Non gli interessa tanto seguire delle coordinate narrative, preferisce lasciare suggestioni, immagine forti, liriche, che sicuramente rimandano a Solo gli amanti sopravvivono ma anche alla comicità surreale di Daunbailò e al minimalismo poetico di Paterson. Forse Jarmusch mette troppa carne al fuoco, con tanti personaggi, piste narrative che si perdono e che si avvitano su se stesse, ma I morti non muoiono (in originale The Dead Don't Die) restituisce tutta la forza ipnotica e malinconica del suo cinema, la capacità di toccare abissi dell’anima che pochi cineasti contemporanei riescono solo a sfiorare.
A Cannes non cambiano quindi solo le modalità di accesso alle sale per accreditati e non, ma anche le scelte dei film che inaugurano la kermesse. Una volta film introduttivi, propedeutici a quello che avremmo visto nel prosieguo dei giorni. Da qualche edizione, film coraggiosi e, come questo di Jarmusch che, seppure (volutamente) imperfetti, lasciano il segno. Dolor y gloria, di Pedro Almodovar (Spagna)
Dolor y gloria, di Pedro Almodovar (Spagna)![]()
In fase di presentazione del programma, molti, io per primo, avevano storto il naso per la presenza in concorso di tanti registi 'cotti', un po’ 'arrivati'. Se è troppo presto per dire se così è (non abbiamo ancora visto le ultime opere dei Dardenne, Malick, ecc...) Almodovar era uno di quei nomi. Julieta era un buon film, ma i tempi di Tutto su mia madre e Parla con lei sembravano ormai irraggiungibili. Ed invece, il regista spagnolo con Dolor y gloria non solo realizza ad oggi il miglior film del festival, ma uno dei suoi migliori film in assoluto, un capolavoro da vedere e rivedere.
Dietro all’autobiografismo e al cinema nel cinema che si riflette nella storia di Salvador Mallo, regista ormai appartato, malato, eroinomane, ipocondriaco, Almodovar si guarda alle spalle, alla sua infanzia, alla vita, agli amori di un tempo che però non finiscono mai, al rapporto con la madre (certo ancora la madre), la scoperta dell’omosessualità, la miseria e la nobiltà dell’artista colto che vive in un appartamento che è un’opera d’arte.
Dolor y gloria riesce ad essere coinvolgente, commovente, ma allo stesso tempo controllato, con la splendida capacità di alternare e sovrapporre presente e passato, adombrando un futuro che lo spaventa ma che vuole percorrere fino alla fine. Un’opera definitiva, testamento, come se Almodovar non volesse fare più nulla dopo questo, come se volesse riassumere non solo lo stile, le storie, i personaggi di una vita, ma anche guardarsi allo specchio, come uomo e cineasta, per chiarire e chiarirsi le idee per sempre. Certo Banderas, perfetto nei panni del regista, Penelope Cruz, che sembra un’Anna Magnani uscita da un film italiano degli Anni ’50 o ’60, ma soprattutto Pedro, gli interni, i colori, gli sguardi, la vita e la morte. E naturalmente, il cinema. Quello con la C maiuscola. The Wild Goose Lake (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui), di Diao Yinan (Cina, Francia)
The Wild Goose Lake (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui), di Diao Yinan (Cina, Francia)![]()
Ci si aspettava molto di più da The Wild Goose Lake di Diao Yinan, il regista cinese della sesta generazione vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2014 con Fuochi d’artificio in pieno giorno.
Delude per due motivi su tutti: la vicenda narrata, quella della faida tra bande rivali per il controllo di una porzione di territorio è troppo cerebrale ed artefatta sin dalle prime inquadrature, con quella pioggia battente, i controluce, i formalismi, e i dialoghi significanti che ammantano tutta l’operazione di un gusto eccessivamente autoriale. A questo si aggiunge che l’intricatissima matassa narrativa che vuole intrecciare una decina di personaggi cercando di delinearli in tutta la loro tragicità, con un destino che li schiaccia e non permette loro di uscire dalla gabbia del crimine, si attorciglia eccessivamente su se stessa, lasciando troppo oscuri ed irrisolti alcuni passaggi fondamentali.
Diao cerca di mascherare evidenti falle di sceneggiatura con uno stile volutamente iperbolico, innaturale per lui, per la storia ed i personaggi che mette in scena. Esistenze sull’orlo dell’abisso, clima da apocalisse imminente. Diao spreca anche quel tanto talento attoriale che ha a disposizione. Un’occasione persa. Portrait de la jeune fille en feu, di Céline Sciamma (Francia)
Portrait de la jeune fille en feu, di Céline Sciamma (Francia)![]()
Ad oggi la vera delusione del festival. In questi ultimi anni Céline Sciamma, da Tomboy a Bande de filles, si era caratterizzata come una delle nuove voci del cinema francese, capace di raccontare le giovani generazioni spesso imprigionate da pregiudizi, sul loro modo di pensare, di agire, di amare.
Con Portrait de la jeune fille en feu Sciamma ci porta alla fine del Settecento, alle radici del romanticismo, pittorico e letterario per raccontarci la storia di un amore impossibile, oltraggioso e scandaloso tra una giovane pittrice, chiamata a ritrarre una ragazza appena uscita dal convento che non vuole sposarsi. La madre (interpretata da Valeria Golino) non riesce a frenarne gli impulsi ribelli, ma anche la sua fuga dal mondo, il suo ritrarsi in lunghi silenzi. Marianna comincia ad avvicinarsi a lei, la scruta, la studia e poi la ama. Heloise a sua volta, viene risucchiata dal vortice di una passione infinita che non ha, però, sbocchi razionali.
La Sciamma realizza un film pieno di luoghi comuni, anemico, eccessivamente lungo, ripetitivo e senz’anima. L’obbiettivo è quello di colpire al cuore con un melò fiammeggiante che vada alle radici dell’amore e del disagio. Purtroppo la staticità delle due protagoniste non aiuta, così come il ricorso ad una serie di luoghi comuni e di inutili estetismi che appesantiscono ulteriormente il film. Troppo ambizioso, troppo pensato, troppo. Ad eccezione dello splendido piano fisso finale, in cui vediamo, lentamente, Heloise, nel palco di un teatro, scoppiare in un fragoroso pianto. Le jeune Ahmed, di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne (Belgio, Francia)
Le jeune Ahmed, di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne (Belgio, Francia)![]()
I fratelli Dardenne tornano per l’ennesima volta in concorso al Festival di Cannes, ma come con il loro film precedente deludono, trasmettendo l’impressione di essere intrappolati in una formula di cinema che non riescono più a rinnovare, ormai cristallizzata, ripetitiva e spesso esangue.
Ahmed viene iniziato al fondamentalismo islamico da un Imam che gli suggerisce anche di punire una delle sue insegnanti, accusata di apostasia. Tema di grande attualità, quindi, che però i fratelli Dardenne affrontano con eccessiva ritrosia. Non prendono posizione, come era lecito e corretto attendersi, ma continuano ad allinearsi ad una certa medietà di tono che rende poco accattivante il loro cinema e i temi da loro affrontati. Il rigore assoluto, il pedinamento della realtà, quell’immediatezza che aveva permesso a loro di affrontare senza retorica e con grande efficacia i temi come il precariato del lavoro, il razzismo latente, i diritti sociali e civili, rimane annaccuato da una scrittura non rigorosa, ma solo corretta, piana, uniforme, anche nella descrizione dei personaggi.
Quindi, quello che era una fenomenologia del quotidiano spietata si è trasformata i una convenzionale narrazione dell’ovvio che non incide, cade spesso nello stereotipo, molto politically correct. A Hidden Life, di Terrence Malick (Germania, Stati Uniti)
A Hidden Life, di Terrence Malick (Germania, Stati Uniti)![]()
Alla vigilia del festival i critici si interrogavano se dopo nove anni di sperimentazioni, spesso fine a se stesse ed asfittiche, Terrence Malick sarebbe tornato alla narrazione classica, accompagnata dalle riflessioni metafisiche e filosofiche di La sottile linea rossa, The New World e The Tree of Life. La sinossi faceva tendere per un sì.
Nell’Austria del Nord, durante la seconda guerra mondiale, Franz e Fani si incontrano e si innamorano. Tutto procede bene, fino a quando Franz viene chiamato a combattere per i nazisti. Rifiutandosi viene processato.
Dopo aver visto il film, la risposta è ni. Da una parte il cineasta americano torna ad una narrazione più tradizionale e, in particolare ad una storia che sente sua, vicina, quella del dramma storico e dell’obiezione di coscienza. Come in The Tree of Life lunghe scene inneggiano alla bellezza abbacinante del creato, nella sua purezza, nella sua innocenza ed incontaminazione. La metafisica del creato, l’estetica del silenzio contro il rumore del conflitto, delle armi della guerra e della civiltà. Dall’altra, però, Malick non rinuncia ad alcuni insistiti estetismi e sperimentazioni che in questi anni avevano nuociuto alla sua immagine di grande regista. Inutili orpelli stilistici, fini a se stessi, velleitari, non funzionali al film e alla messa in scena. Momenti di puro lirismo, che fanno tornare in mente Badlands si alternano ad altri che appaiono scarti di montaggio affastellati senza alcuna logica. E nemmeno senza una volontà di sperimentare.
Il risultato finale è entusiasmante e straordinario per metà, deludente per l’altra metà. Parasite (Gisaengchung), di Bong Joon-ho (Corea del Sud)
Parasite (Gisaengchung), di Bong Joon-ho (Corea del Sud)![]()
Due anni fa, un po’ tutti erano rimasti delusi da Ojia, il film prodotto da Netflix che Bong Joon-ho aveva realizzato con Tilda Swinton protagonista. Con Parasite, il regista coreano torna a grandi livelli con una splendida black comedy.
Una famiglia che abita nei bassifondi di una grande città, escogita un elaborato e diabolico piano per entrare e lavorare, a vari livelli, per una famiglia dell’alta borghesia, facoltosa, che ostenta la propria ricchezza in stile di vita, comportamenti. Si inizia dai figli che diventano educatori dei figli della famiglia ricca, fino ai genitori, astutamente divenuti autista e governante. Il piano perfetto scricchiola quando qualcuno emerge dal basement della casa.
Ad un primo approccio, la trama di Parasite non si discosta troppo da Suburbicon di George Clooney, ma dove il film americano scopriva le sue carte immediatamente, Bong pianifica una straordinaria progressione drammaturgica (ma anche stilistica: pensate alla pioggia che invade tutta la città, dall’alto fino al basso) che si risolve in una spietata lotta di classe e in una sottile analisi sociale che non risparmia nessuno. Bong alimenta una dialettica alto/basso, ricco/povero di grande maestria, con improvvisi colpi di scena alternati a sapienti dialoghi che mettono in luce due debolezze: quelle della famiglia benestante e l’aridità della famiglia cresciuta nei bassifondi.
Uno dei migliori film del festival.  Il traditore, di Marco Bellocchio (Italia, Francia, Brasile, Germania)
Il traditore, di Marco Bellocchio (Italia, Francia, Brasile, Germania)![]()
L’ultimo capolavoro di Marco Bellocchio risale a dieci anni fa, Vincere, il fulminante ritratto della relazione segreta tra Mussolini e Ida Dalser. Un capolavoro che riprendeva e in un certo senso riassumeva tutto il meglio della poetica bellocchiana. Cosa abbia spinto il regista di Bobbio a realizzare un film su Tommaso Buscetta francamente non lo capisco.
All’inizio si poteva pensare ad una riflessione sul potere che lo avvicinasse a Buongiorno, notte, il film del 2003 sulla storia del rapimento Moro. No. Il traditore, purtroppo, di Bellocchio ha veramente poco. Pensato e girato come uno sceneggiato televisivo, Bellocchio segue la parabola del boss dei due Mondi in un ordine temporale, dai tempi brasiliani, quando si stava affermando la mafia vincente di Riina su quella perdente palermitana, fino alla morte negli Stati Uniti a 90 anni, passando, ovviamente, per il pentimento, il rapporto con Falcone, il maxi-processso, la nuova identità negli Stati Uniti. I cromatismi e i chiaroscuri non sono di Ciprì, e si vede, ma piuttosto una sciatta ed uniforme messa in scena che sprofonda nella lunghissima parte del maxi-processo, dove Buscetta appare come un paladino della libertà e della giustizia, (dopo aver siglato il patto d’onore che lo lega a Falcone) e gli accusati boss mafiosi una serie di figure caricaturali, appesantite da dialoghi pieni di luoghi comuni, da sceneggiato. Favino è poco credibile nella parte di Buscetta, non lascia trasparire alcun travaglio, alcuna sofferenza. Senza voler parlare poi, dei moltissimi, e spesso inutili, personaggi di contorno.
Siamo lontani anni luce dalla spietata riflessione sul potere di Buongiorno, notte e Vincere, come se Bellocchio non sentisse appieno la materia narrata, come se non gli appartenesse e avesse girato un film puramente su commissione. Alla fine della proiezione stampa timidi applausi, anche se tanta critica italiana ha elogiato Il traditore, forse perché un film di Bellocchio, l’ultimo dei nostri veri maestri rimasti, non si può discutere o mettere in discussione. Mektoub, My Love: Intermezzo, di Abdellatif Kechiche (Francia)
Mektoub, My Love: Intermezzo, di Abdellatif Kechiche (Francia)![]()
Sono molto tormentato nello scrivere a proposito di questo secondo capitolo, o spin off di Mektoub, My Love. Perché adoro il cinema di Kechiche, perché nel 2013 mi ha regalato con La vita di Adele una delle emozioni più forti al cinema di sempre, perché è un autentico outsider nel panorama del cinema francese. Ma Mektoub, My Love proprio no. Non riesco a guardarlo, non riesco a farlo rientrare nel suo sublime modo di far cinema, nella sua poetica.
L’impressione, forte, è che dopo le infinite ed inutili polemiche che hanno circondato le riprese di La vita di Adele, Kechiche abbia voluto ancora di più giocare il ruolo del guastafeste nel sistema francese, provocando tanto per il gusto di provocare, portando alle estreme conseguenze gli elementi disturbanti del suo cinema, azzerando la narrazione, abbandonandosi ad una messa in scena che vuole essere totalmente libera, scevra da ogni compromesso, ma che in realtà ad ogni passaggio si rivela finta, cerebrale, meccanica. In questo senso Intermezzo abbraccia la sperimentazione, con un’unica scena in discoteca di due ore e trenta minuti, un incipit e una scena finale, pretendendo di cogliere il reale, la bellezza, i corpi, la sensualità, la malinconia, la tristezza, ma poi, allo stesso tempo, cade in pasticci di montaggio, con la lunga scena di sesso orale che arriva e finisce nel nulla (quelle di La vita di Adele erano perfettamente funzionali al racconto), con continui stacchi che contraddicono l’idea di semplicità e autenticità.
Kechiche litiga ormai con tutti, in sala stampa con i fotografi, i giornalisti accusati di fargli domande perché il “film è già lì”, da vedere, come un’esperienza estatica, assoluta. Kechiche non ha proprio sopportato che Léa Seydoux, simbolo di quell’establishment dell’industria francese cinematografica, l’abbia violentemente attaccato dopo aver vinto una Palma d’Oro che rimarrà nella Storia. Quando se ne farà una ragione, tornerà ad essere un grande regista.
Un Certain Regard Jeanne, di Bruno Dumont (Francia)
Jeanne, di Bruno Dumont (Francia)![]()
1429, la guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra. Giovanna d’Arco, figura rivoluzionaria di quel periodo considerata eretica per il suo rapporto 'personale' e diretto con Dio e la sua contrapposizione rispetto alla gerarchia cattolica. Bruno Dumont ci racconta questa conosciutissima storia con il suo consueto approccio controverso, apparentemente respingente e provocatorio, ma estremamente efficace nell’evocare, come una sacra rappresentazione medioevale, la forza distruttiva dell’eroina, la sua carica rivoluzionaria. Prima di Jeanne c’era stato Jeanette, una sorta di opera rock in cui venivano cantate le gesta di Giovanna d’Arco. Questa volta vengono declamate, con l’azione che rimane sempre al confine, ai margini, non entra mai in campo. O vengono riprese nelle declamazioni del processo, magnifico momento di rappresentazione dove i prelati la vogliono condannare per eresia. Una messa in scena volutamente statica, cristallizzata, pensata per spiazzare e creare un perenne effetto di straniamento rispetto allo spettatore. Che non può che rimanere colpito da questo modo di far cinema così controverso, assolutamente unico nel panorama attuale. Un cinema che si ama o si odia, che anche laddove preferisce la declamazione e il parlato all’azione non si può definire teatrale nel senso tradizionale del termine. Nina Wu (Juo ren mi mi), di Midi Z (Taiwan)
Nina Wu (Juo ren mi mi), di Midi Z (Taiwan)![]()
Midi Z, regista burmese ormai trasferitosi in pianta stabile a Taiwan, con Nina Wu ribalta completamente le coordinate del suo cinema, che da un rigoroso e pauperistico realismo, si converte ad un metafisico illusionismo e gioco di specchi alla Lynch. In precedenza, infatti, con opere come The Road to Mandalay Midi Z era il cantore dell’eterno esilio birmano, di un’intera popolazione costretta a lasciare il proprio Paese a causa della feroce dittatura che lo ha sigillato per oltre cinquant’anni. Questa volta il cineasta concentra il suo sguardo sulla parabola di una giovane attrice di provincia che viene catapultata verso un inaspettato successo per aver accettato un ruolo particolarmente scabroso.
Gioco di scatole cinesi, di realtà sovrapponibili, di continui scarti temporali, Nina Wu è sicuramente un bel ritratto femminile, ma Midi Z, non a suo agio con registri onirici, sgambetta più volte alla ricerca del senso, del significato ultimo all’interno della scena o di una particolare situazione. Non si accontenta di dipingere il ritratto di una donna tormentata, dall’improvviso successo, da un passato scomodo, ma non soddisfatto, nella parte finale, apre ulteriori tunnel dell’animo dove si discute di sessualità, di perversioni, del mestiere dell’attore.
In un festival che ha presentato molti film nel film, Nina Wu non è quello che si è fatto apprezzare di più e contiamo quanto prima di rivedere Midi Z a contatto con la dura realtà.
Semaine de la Critique Tu mérites un amour, di Hafsia Herzi (Francia)
Tu mérites un amour, di Hafsia Herzi (Francia)![]()
Come si fa a non simpatizzare con questo riuscito esordio di Hafsia Herzi, musa di Kechiche da tempi di Cous Cous fino a Mektoub, che viene proprio evocato in uno dei dialoghi del film?
Lila, giovane donna inquieta non riesce a sostenere i tradimenti del fidanzato Remi (interpretato da Jeremie Laheurte, già in La vita di Adele). Lo vuole lasciare, ma ne è ossessionata. Lo segue, fa pedinare la nuova fidanzata, si rivolge ad un vate che le possa predire il futuro. Tormenti amorosi che si accavallano con nuovi flirt, alla ricerca di un amore, di qualcuno da amare ed essere amati.
Hafsia ha imparato bene la lezione del suo maestro. Tu mérites un amour è kechichiano dall’inizio alla fine, con quella camera a mano che liberamente segue i personaggi, colti nella loro quotidianità, nella loro banalità, anche nei momenti più intensi. Uno stile informale, che vuole cogliere l’autenticità del vivere, gli abissi dell’animo. Lila, proprio come un personaggio di Kechiche, ama guardare il cibo, prepararlo e vederlo preparare, si tormenta senza voler trovare una soluzione ai suoi tormenti d’animo.
Forse si poteva fare qualcosa di meglio a livello di dialoghi, che a tratti appaiono artefatti e che cozzano con la libertà del girare con la macchina da presa. Ma Tu mérites un amour è un bell’esordio che Charles Tesson ha fatto bene a selezionare per la Semaine de la Critique, a prescindere dalla notorietà della sua attrice-regista.
Quinzaine des realisateurs First Love (Hatsukoi), di Takashi Miike (Giappone, Regno Unito)
First Love (Hatsukoi), di Takashi Miike (Giappone, Regno Unito)![]()
L’ultimo film di Takashi Miike, First Love viene presentato nella Quinzaine des realisateurs, dove il mitico cineasta giapponese era già stato in precedenza.
Leo, giovane boxeur e Monica si incontrano casualmente nella notte di Tokyo, al centro di vendette incrociate tra triadi cinesi, yakuza, poliziotti infiltrati per il possesso del territorio.
In particolare nella prima parte troviamo Miike al suo meglio, tra atmosfere cupe, dark, scene d’azione impeccabili, i personaggi, molti, che si avvicendano bene nonostante la narrazione complicata e quasi mai lineare. Poi, come spesso accade a Miike, soprattutto al Miike degli ultimi quindici anni, First Love appare girato troppo velocemente, lo splatter, l’ironia e il grottesco, volontario o meno, prevalgono sul senso dell’onore, i codici morali e il rigore interno alle associazioni criminali. Non a caso i personaggi più centrati sono proprio quelli di Leo, e della tossicodipendente Monica, che, loro malgrado, si trovano inghiottiti in spirali di violenza senza fine. Presentandolo al pubblico, Miike ha detto che il suo film si tratta di una storia d’amore molto pura e semplice. Non emerge molto, se non nella bella scena finale. In ogni caso, il suo film migliore degli ultimi anni, ad eccezione di Blade of the Immortal. Une fille facile (An Easy Girl), di Rebecca Zlotowski (Francia)
Une fille facile (An Easy Girl), di Rebecca Zlotowski (Francia) ![]()
Imbarazzante il film di Rebecca Zlotowsky. Uno scult di proporzioni inaudite. In scenari paradisiaci la regista francese racconta un coming of age di una ragazza di sedici anni, all’ombra di una ventenne procace, specializzata nell’accalappiare, in qualsiasi situazioni, ricconi pronti a portarsela a letto in cambio di sontuosi regali. Interpretazioni inesistenti, dialoghi ridicoli. Ci si chiede come un film del genere possa essere stato scelto a Cannes, alla Quinzaine. To Live To Sing, di Johnny Ma (Cina, Francia)
To Live To Sing, di Johnny Ma (Cina, Francia)![]()
Il tema non è nuovissimo, ed è ormai al centro, in modo più o meno evidente, in gran parte del cinema cinese contemporaneo: il doloroso passaggio alla modernità in vaste parti della Cina più rurale ed arretrata, quella legata alle tradizioni, popolata da anziani legati ad una serie di ritualità. Una di queste l’assistere all’opera, spettacolo per eccellenza della secolare tradizione cinese.
Un gruppo canta e suona da trent’anni ma molti teatri e luoghi di rappresentazione stanno per essere demoliti, per lasciare spazio a nuovi grattacieli e punti di ritrovo per giovani. Antico e moderno, tradizione e contemporaneità. Nulla di nuovo, ma Johnny Ma, regista di Hong Kong, che come tanti, lavora ora in Cina, è però particolarmente bravo nella descrizione di un mondo che sta scomparendo lentamente, che soffre nel passaggio ad una vita più agiata. Il confronto generazionale è ben rappresentato dalla contrapposizione tra la giovane e bella cantante che vorrebbe cambiare e fuggire per trasferirsi in una delle metropoli moderne del paese, e la direttrice dell’opera che l’ha cresciuta come una figlia e che vede nella sua partenza la fine di un’era e della sua vita.
Il gioco e la retorica sono molto scoperti, poche le sfumature, eppure To Live To Sing è un grido di allarme sincero ed autentico, nostalgico, forse troppo (in particolare nel finale) ma che riesce a toccare le corde giuste, senza mai cadere nel facile patetismo o nella retorica del passato. Tutti bravissimi gli attori.