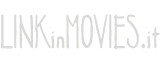Intervista a Kim Longinotto
- Scritto da Fabio Canessa
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Commenta per primo!
 La realtà attraverso lo sguardo di Kim Longinotto, documentarista inglese che ha girato il mondo per raccontare storie di donne vittime di oppressione, di ribelli che lottano contro pregiudizi. Un cinema di osservazione ed empatia del quale ha discusso all’Accademia di Belle Arti di Sassari
La realtà attraverso lo sguardo di Kim Longinotto, documentarista inglese che ha girato il mondo per raccontare storie di donne vittime di oppressione, di ribelli che lottano contro pregiudizi. Un cinema di osservazione ed empatia del quale ha discusso all’Accademia di Belle Arti di Sassari
Se una delle qualità di chi fa documentari dev’essere quella di riuscire a entrare facilmente in relazione con gli altri, creare un’immediata simpatia e fiducia, non è difficile capire perché Kim Longinotto fa questo mestiere e con grandi risultati. La regista inglese ha una capacità naturale di mettere a proprio agio le persone e lo ha dimostrato anche a Sassari, protagonista di una masterclass all’Accademia di Belle Arti inserita in un ciclo di incontri internazionali con i più grandi documentaristi voluti dal direttore Antonio Bisaccia.
Sguardo curioso, sorriso dolce, attenzione sincera agli altri. Appare davvero dispiaciuta con gli studenti che non capiscono bene l’inglese per non saper parlare l’italiano. Anche se ha origini italiane, come si può intuire dal cognome. Ereditato da un padre con il quale Kim Longinotto, racconta, non ha avuto un grande rapporto. "Aveva cambiato il cognome in Landseer e quando ho scoperto che era una bugia, mi ha detto che veniva da Firenze. Ma non sono sicura sia vero. Aveva molti pregiudizi". Pregiudizi, barriere che la regista combatte con i suoi film. Raccontando storie di transgender giapponesi, Shinjuku Boys, o di donne iraniane decise nel far valere i loro diritti, Divorce Iranian Style, per citare due suoi documentari. Una ventina quelli realizzati nel corso della carriera. Diversi di questi hanno anche vinto premi importanti, come Rough Aunties e il più recente Dreamcatcher che hanno ottenuto riconoscimenti a un festival prestigioso come il Sundance. Nel 2009 il Moma di New York ha dedicato anche una retrospettiva ai suoi documentari.
Lavori che generalizzando possiamo dire hanno in comune il raccontare storie di donne vittime di oppressione, violenza e discriminazione in varie parti del mondo?
Io preferisco indicare come focus del mio lavoro non espressamente i diritti delle donne, ma quelli dei ribelli. Racconto storie di ribelli, che la maggior delle volte sono donne perché il potere è in mano agli uomini. E poi non mi piace pensare a film sulle vittime, ma a storie di persone che non si sono fatte abbattere e lottano.
È sempre stato così da quando ha iniziato a fare questo mestiere?
Il mio modo di concepire un film è sempre lo stesso. E probabilmente un po’ deriva da quello che ho vissuto. Sono cresciuta in un istituto in cui non potevi chiedere il perché delle cose e subito ho sentito un senso di solidarietà verso quelli che si ribellano, che non accettano regole. Quando poi ho studiato cinema e ho realizzato il mio primo lavoro, Pride of Place (1976), ho cercato di mostrare il punto di vista degli studenti sull’atteggiamento repressivo di quel collegio draconiano. Che venne chiuso dopo l’uscita del film.
Da lì inizia la sua carriera caratterizzata da documentari in stile osservazionale. Perché questa scelta?
Sin dall’inizio non ho voluto fare film per fare informazione, ma per raccontare delle storie. E da questo punto di vista sono contenta di come sia cambiata la percezione del documentario oggi. Più considerato come cinema, come mezzo per raccontare storie. Per le informazioni poi adesso è facile, basta andare su Internet e in un motore di ricerca. Ognuno trova le informazioni che vuole. Allo spettatore non interessano dati. C’è la richiesta di una storia.
Osservazione però, soprattutto nel suo caso, non vuol dire distanza. Il suo sguardo appare carico di empatia.
Per lo stile osservazionale molti usano la definizione fly-on-the-wall: essere come una mosca sul muro, come a dire agli altri fate come se non ci fossi. Un’espressione che trovo orribile. Io voglio che il pubblico sia coinvolto nella storia, si senta come se fosse lì accanto a me con i personaggi. Il documentario che mi interessa è un film in cui l’osservazione diventa empatia e lo spettatore si identifica con i personaggi della storia raccontata.
Tutto parte da un grande rispetto della realtà e lei sembra incarnare un modo femminile, meno controllato rispetto a un approccio maschile.
Il mondo del documentario è forse più adatto alle donne di quello della fiction, dove hai a che fare con tante persone e il regista cerca sempre di mostrare la sua autorità per comandare, gestire il potere. Anche se tutti abbiamo delle insicurezze. Ma c’è un valore maschile per cui devi nascondere l’insicurezza e un valore femminile per cui tu puoi condividerla.
No. A parte le differenze di budget, la realtà è sempre più forte, pazza, sorprendente.

Fabio Canessa
Viaggio continuamente nel tempo e nello spazio per placare un'irresistibile sete di film. Con la voglia di raccontare qualche tappa di questo dolce naufragar nel mare della settima arte.