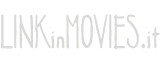The Last Dance: focus sulla docuserie dedicata a Michael Jordan
- Scritto da Fabio Canessa
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Video
- Commenta per primo!
 Michael Jordan: vita in dieci capitoli. Partendo dal racconto dell’ultima stagione nei Chicago Bulls, la docuserie The Last Dance ripercorre le gesta del più grande giocatore di basket di tutti i tempi. Lo sport diventa narrazione epica in 500 minuti appassionanti. Disponibile su Netflix
Michael Jordan: vita in dieci capitoli. Partendo dal racconto dell’ultima stagione nei Chicago Bulls, la docuserie The Last Dance ripercorre le gesta del più grande giocatore di basket di tutti i tempi. Lo sport diventa narrazione epica in 500 minuti appassionanti. Disponibile su Netflix
Salt Lake City, 14 giugno 1998. Al Delta Center, il palazzetto degli Utah Jazz, si gioca gara 6 della finale Nba tra i padroni di casa e i Chicago Bulls. I Tori sono in vantaggio nella serie 3-2, ma la squadra della premiata ditta Stockton-Malone ha vinto la partita precedente e pareggiando sa che si giocherebbe il titolo in una sfida decisiva sempre tra le mura amiche. A un minuto dalla fine, dopo due tiri liberi di Michael Jordan, la situazione è pari: 83-83. Palla ai Jazz. Con una bella azione viene liberato dall’arco Stockton: tripla. Mancano adesso soltanto 41.9 secondi. Utah è di nuovo in vantaggio, si profila all’orizzonte un’altra partita. Jordan, però, ha altre idee. I suoi Bulls nelle cinque finali precedenti non hanno mai permesso agli avversari di portare la serie a gara 7. E il 23 con la canotta rossa non lo permetterà anche questa volta, sublimando la sua inimitabile carriera con tre giocate straordinarie in pochi attimi. La prima è quasi facile per uno come lui: riceve dalla rimessa, penetra e appoggia al vetro. Chicago è ora sotto di un punto, però il possesso è dei Jazz che come prevedibile decidono di giocare su Karl Malone. Improvvisamente Jordan raddoppia su di lui, già ben marcato da Dennis Rodman, e gli soffia la palla senza fallo. Il cronometro segna ancora 20 secondi. Il capitano dei Bulls ha tra le mani quello che può essere il tiro della vittoria. Percorre tutto il campo e si porta sul lato sinistro. Su di lui c’è Bryon Russell. Lo attacca andando verso la lunetta, lo sbilancia con una finta, palleggio, arresto e tiro. È the last shot, il sigillo di una leggenda, forse il canestro più famoso della storia del basket. I 5 secondi che restano, con Stockton che ci prova ma prende solo il ferro, nessuno li ricorda. L’immagine che resta, iconica è quell’ultimo tiro di Jordan. Due punti (dei 45 firmati in quella magica serata) e sorpasso: 87-86 per Chicago. Sesto anello Nba come indica il campione a mani alzate subito dopo il suono della sirena. Conclusione dell’annata 1997-98 che segna la fine dell’incredibile ciclo vincente dei Bulls con l’annunciato smembramento della squadra e il ritiro di Jordan. The Last Dance, l’ultimo ballo, definizione coniata dall’allenatore Phil Jackson per quella stagione e utilizzata come titolo della docuserie targata Espn e disponibile su Netflix.
Produzione evento, con la regia di Jason Hehir, The Last Dance si avvale di immagini inedite realizzate in quei mesi. All’inizio della preparazione per la stagione i Bulls concedono infatti l’accesso esclusivo a una troupe cinematografica che per tutto l’anno potrà seguire costantemente la squadra, anche in quelle situazioni normalmente off limits per le telecamere. Dopo oltre vent’anni quel girato è diventato la base per un’opera monumentale. Al sentiero principale tracciato da queste immagini, forse anche sottoutilizzate, si aggiungono quelle di tanto materiale d’archivio per raccontare gli anni precedenti e molte interviste. Così da formare tre grandi linee temporali – la stagione 1997-1998, lunghi flashback e il 'presente' con le parole di Jordan e delle altre persone intervistate per la costruzione del documentario – gestite in modo eccellente, con un andirivieni chiaro e dinamico. Un lavoro di montaggio dal perfetto ritmo accompagna così una storia sportiva dal sapore leggendario, con un eroe magnetico da ascoltare e ovviamente da vedere/rivedere in azione: tiri in fadeaway, schiacciate, canestri galleggiando in aria. Gesti atletici che lasciano a bocca aperta, arte sul parquet. A ribadire che sul più grande di tutti i tempi nel basket non c’è discussione. Con buona pace di LeBron James e dei suoi giovani tifosi che l’epoca Jordan non l’hanno vissuta. Per conoscerla nei dettagli, e gustarla come mai è stata raccontata, ci sono adesso i dieci episodi di The Last Dance.
 EPISODIO 1. “Parlai con i giocatori di quanto fosse importante restare uniti nella nostra ultima avventura insieme. Perciò la chiamai The Last Dance”. Così coach Phil Jackson ricorda la riunione con la squadra e il nome dato alla stagione 1997-1998 alla vigilia dell’inizio del campionato. Sarebbe stato l’ultimo insieme. Bisognava goderselo. E vincere, ancora una volta. Anche se il futuro della dinastia era incerto, per non dire segnato. La colpa? Della dirigenza. Il conflitto è un aspetto centrale nella narrazione, ogni storia ha bisogno di un cattivo. The Last Dance lo trova nel general manager Jerry Krause, arrivato a Chicago a metà degli anni Ottanta per costruire intorno a Jordan una squadra vincente. E non si possono dimenticare i suoi meriti. Su tutti la scelta di puntare su Scottie Pippen nel draft del 1987 e la promozione di Jackson da assistente a capo allenatore due anni dopo. Ironia della sorte proprio gli attriti tra Krause e l’ala piccola e tra il general manager e il coach sono i problemi principali che, tornando alla stagione raccontata, minano la serenità all’interno dei Bulls. Il primo insoddisfatto del trattamento economico, il secondo con contratto a termine qualsiasi cosa succeda. Parola di Krause che vuole rifondare la squadra, con nuovi giocatori e un nuovo allenatore. Solo che a Jordan la cosa non piace ed è pronto a smettere se il piano di smantellamento sarà confermato. Prima però c’è da conquistare il sesto anello, anche se la situazione all’interno della società è tesa. L’episodio introduce così la storia, tra immagini di un torneo preseason a Parigi e un tuffo nel passato di Jordan ai tempi dell’Università della Carolina del Nord, dove guida la squadra alla vittoria del campionato Ncaa nel 1982 con il tiro decisivo (segno del destino), e al suo primo anno in Nba (vince, manco a dirlo, il premio come Rookie of the Year) con rivelazioni choc su festini dei compagni di squadra di allora.
EPISODIO 1. “Parlai con i giocatori di quanto fosse importante restare uniti nella nostra ultima avventura insieme. Perciò la chiamai The Last Dance”. Così coach Phil Jackson ricorda la riunione con la squadra e il nome dato alla stagione 1997-1998 alla vigilia dell’inizio del campionato. Sarebbe stato l’ultimo insieme. Bisognava goderselo. E vincere, ancora una volta. Anche se il futuro della dinastia era incerto, per non dire segnato. La colpa? Della dirigenza. Il conflitto è un aspetto centrale nella narrazione, ogni storia ha bisogno di un cattivo. The Last Dance lo trova nel general manager Jerry Krause, arrivato a Chicago a metà degli anni Ottanta per costruire intorno a Jordan una squadra vincente. E non si possono dimenticare i suoi meriti. Su tutti la scelta di puntare su Scottie Pippen nel draft del 1987 e la promozione di Jackson da assistente a capo allenatore due anni dopo. Ironia della sorte proprio gli attriti tra Krause e l’ala piccola e tra il general manager e il coach sono i problemi principali che, tornando alla stagione raccontata, minano la serenità all’interno dei Bulls. Il primo insoddisfatto del trattamento economico, il secondo con contratto a termine qualsiasi cosa succeda. Parola di Krause che vuole rifondare la squadra, con nuovi giocatori e un nuovo allenatore. Solo che a Jordan la cosa non piace ed è pronto a smettere se il piano di smantellamento sarà confermato. Prima però c’è da conquistare il sesto anello, anche se la situazione all’interno della società è tesa. L’episodio introduce così la storia, tra immagini di un torneo preseason a Parigi e un tuffo nel passato di Jordan ai tempi dell’Università della Carolina del Nord, dove guida la squadra alla vittoria del campionato Ncaa nel 1982 con il tiro decisivo (segno del destino), e al suo primo anno in Nba (vince, manco a dirlo, il premio come Rookie of the Year) con rivelazioni choc su festini dei compagni di squadra di allora.
 EPISODIO 2. “Quello non era Michael Jordan. Era Dio travestito da Michael Jordan”. Una frase storica di Larry Bird che riporta al 20 aprile 1986. Gara 2 del primo turno dei playoff tra Chicago e Boston. MJ non riesce a evitare la sconfitta dei suoi Bulls contro quei fortissimi Celtics, ma inizia a scrivere la sua leggenda: segna 63 punti, record ancora oggi imbattuto per quanto riguarda la postseason. Quell’incredibile partita viene rievocata nel secondo episodio che si spinge ancora più indietro nel tempo, all’infanzia e all’adolescenza di Jordan. Sottolineando tra le altre cose la rivalità con i fratelli che fa crescere il suo spirito agonistico. Una costante del suo carattere, molla per continuare a migliorarsi sempre come giocatore. Ma The Last Dance non è solo Jordan, anche se il grande protagonista è ovviamente lui. Per metà abbondante della puntata il focus è su Pippen, secondo violino dei Bulls. “Se dici Michael Jordan, devi aggiungere Scottie Pippen”. Non ha problemi ad ammetterlo il campionissimo, evidenziando così la fondamentale importanza del suo migliore compagno di squadra per i successi di Chicago. Certo Jordan delle vittorie, un’ossessione, ha sempre voluto averne il merito (cosa tra l’altro indiscutibile). Ma da vero leader mette davanti il noi e non dimentica chi gli è stato a fianco nei trionfi. A cominciare da Pippen di cui oltre l’insistenza sui problemi con la dirigenza, per via di un lungo contratto firmato anni prima risultava sottopagato rispetto al valore espresso, viene tracciato un ritratto dell’infanzia in Arkansas. La famiglia numerosa, le difficoltà con il padre colpito da un ictus e costretto sulla sedia a rotelle, il trauma della paralisi anche di uno dei fratelli causata da un incidente durante una lezione di wrestling, il riscatto attraverso il basket.
EPISODIO 2. “Quello non era Michael Jordan. Era Dio travestito da Michael Jordan”. Una frase storica di Larry Bird che riporta al 20 aprile 1986. Gara 2 del primo turno dei playoff tra Chicago e Boston. MJ non riesce a evitare la sconfitta dei suoi Bulls contro quei fortissimi Celtics, ma inizia a scrivere la sua leggenda: segna 63 punti, record ancora oggi imbattuto per quanto riguarda la postseason. Quell’incredibile partita viene rievocata nel secondo episodio che si spinge ancora più indietro nel tempo, all’infanzia e all’adolescenza di Jordan. Sottolineando tra le altre cose la rivalità con i fratelli che fa crescere il suo spirito agonistico. Una costante del suo carattere, molla per continuare a migliorarsi sempre come giocatore. Ma The Last Dance non è solo Jordan, anche se il grande protagonista è ovviamente lui. Per metà abbondante della puntata il focus è su Pippen, secondo violino dei Bulls. “Se dici Michael Jordan, devi aggiungere Scottie Pippen”. Non ha problemi ad ammetterlo il campionissimo, evidenziando così la fondamentale importanza del suo migliore compagno di squadra per i successi di Chicago. Certo Jordan delle vittorie, un’ossessione, ha sempre voluto averne il merito (cosa tra l’altro indiscutibile). Ma da vero leader mette davanti il noi e non dimentica chi gli è stato a fianco nei trionfi. A cominciare da Pippen di cui oltre l’insistenza sui problemi con la dirigenza, per via di un lungo contratto firmato anni prima risultava sottopagato rispetto al valore espresso, viene tracciato un ritratto dell’infanzia in Arkansas. La famiglia numerosa, le difficoltà con il padre colpito da un ictus e costretto sulla sedia a rotelle, il trauma della paralisi anche di uno dei fratelli causata da un incidente durante una lezione di wrestling, il riscatto attraverso il basket.
 EPISODIO 3. “Potevo finire in galera o morire. Però mi sono fatto il culo per arrivare qui”. Inizia con queste parole di Dennis Rodman il terzo episodio, incentrato sul giocatore più esuberante della storia dell’Nba. Pazzo sì, ma anche un campione. Difensore straordinario, rimbalzista senza eguali, The Worm (il suo soprannome) arriva a Chicago nel 1996 e diventa il terzo grande tenore nel secondo three peat (tre titoli consecutivi) dei Bulls. Più che per i risultati sportivi, con altri due anelli vinti in precedenza con la maglia dei Detroit Pistons, e per le sue eccezionali doti a rimbalzo, molto interessante il racconto della sua tecnica di allenamento per migliorare in questo fondamentale, Rodman viene ricordato soprattutto perché personaggio eccentrico e fuori dagli schemi. Una fama conquistata non semplicemente per i capelli colorati, i piercing, i tatuaggi, il look a dir poco stravagante. Meriterebbe una serie a parte per le sue bizzarrie. Certo la vita non è sempre stata in discesa per lui. Cacciato di casa a 18 anni, vive per strada per diverso tempo. “Non so come mai non entrai nel giro della droga” dice lo stesso Rodman. Per fortuna inizia a giocare a basket e nel 1986 riesce ad arrivare in Nba. Tra gli episodi ricordati in The Last Dance quella volta che, scomparso, viene trovato in auto con un fucile, la relazione con la regina del pop Madonna e la leggendaria 'vacanza' a Las Vegas proprio nella stagione al centro della docuserie. Un permesso di due giorni concesso dal coach per soddisfare la sua esigenza di libertà: 48 ore che si trasformano in 88. A recuperarlo lo stesso Jordan, come racconta Carmen Electra, compagna ed ex moglie (per un breve periodo) di Rodman, nella coda del focus su The Worm all’inizio della quarta puntata.
EPISODIO 3. “Potevo finire in galera o morire. Però mi sono fatto il culo per arrivare qui”. Inizia con queste parole di Dennis Rodman il terzo episodio, incentrato sul giocatore più esuberante della storia dell’Nba. Pazzo sì, ma anche un campione. Difensore straordinario, rimbalzista senza eguali, The Worm (il suo soprannome) arriva a Chicago nel 1996 e diventa il terzo grande tenore nel secondo three peat (tre titoli consecutivi) dei Bulls. Più che per i risultati sportivi, con altri due anelli vinti in precedenza con la maglia dei Detroit Pistons, e per le sue eccezionali doti a rimbalzo, molto interessante il racconto della sua tecnica di allenamento per migliorare in questo fondamentale, Rodman viene ricordato soprattutto perché personaggio eccentrico e fuori dagli schemi. Una fama conquistata non semplicemente per i capelli colorati, i piercing, i tatuaggi, il look a dir poco stravagante. Meriterebbe una serie a parte per le sue bizzarrie. Certo la vita non è sempre stata in discesa per lui. Cacciato di casa a 18 anni, vive per strada per diverso tempo. “Non so come mai non entrai nel giro della droga” dice lo stesso Rodman. Per fortuna inizia a giocare a basket e nel 1986 riesce ad arrivare in Nba. Tra gli episodi ricordati in The Last Dance quella volta che, scomparso, viene trovato in auto con un fucile, la relazione con la regina del pop Madonna e la leggendaria 'vacanza' a Las Vegas proprio nella stagione al centro della docuserie. Un permesso di due giorni concesso dal coach per soddisfare la sua esigenza di libertà: 48 ore che si trasformano in 88. A recuperarlo lo stesso Jordan, come racconta Carmen Electra, compagna ed ex moglie (per un breve periodo) di Rodman, nella coda del focus su The Worm all’inizio della quarta puntata.
 EPISODIO 4. “Iniziai a concentrarmi sui miei compagni, per farli brillare”. Giocare insieme a Michael Jordan non deve essere stato facile. C’è tutta una letteratura sul suo atteggiamento duro, aggressivo, anche sgradevole, nei confronti dei compagni. Atteggiamento che alla vigilia della stagione 1990-1991 si fa ancora più pressante. Sente, dopo la nuova delusione in finale di Conference contro gli odiati Pistons, che è arrivato il momento di vincere. E sarà così. Chicago questa volta spazzerà via la concorrenza di Detroit a Est prima di sconfiggere i Lakers di Magic Johnson nella finalissima. Ma per ottenere un obiettivo così bisogna sudare. “Michael ci stava addosso. Non si poteva sbagliare” ricorda Pippen. “Se facevi un errore, ti urlava contro, ti denigrava” aggiunge Horace Grant. La richiesta della perfezione. Dagli altri, certo, ma ancora prima da se stesso. A fare da collante in una situazione così potenzialmente esplosiva per lo spogliatoio, ovviamente Phil Jackson. Il coach zen. Su di lui verte buona parte dell’episodio. Viene quindi presentata la sua carriera da giocatore, due titoli di campione Nba vinti con i New York Knicks anche se non proprio da attore protagonista, la gavetta come allenatore a Portorico e nella Cba, il ruolo da assistente di Doug Collins ai Bulls, la promozione a head coach, la collaborazione con il vice Tex Winter al quale si deve il famoso attacco triangolo: qualche tiro in meno per Jordan e un gioco più collettivo che darà i suoi frutti. A completare il ritratto alcuni aspetti della vita privata, dal passato da hippie alla passione per la cultura dei nativi americani condivisa, curiosamente, con Rodman. Forse anche per questa sensibilità comune nessuno lo ha capito come lui.
EPISODIO 4. “Iniziai a concentrarmi sui miei compagni, per farli brillare”. Giocare insieme a Michael Jordan non deve essere stato facile. C’è tutta una letteratura sul suo atteggiamento duro, aggressivo, anche sgradevole, nei confronti dei compagni. Atteggiamento che alla vigilia della stagione 1990-1991 si fa ancora più pressante. Sente, dopo la nuova delusione in finale di Conference contro gli odiati Pistons, che è arrivato il momento di vincere. E sarà così. Chicago questa volta spazzerà via la concorrenza di Detroit a Est prima di sconfiggere i Lakers di Magic Johnson nella finalissima. Ma per ottenere un obiettivo così bisogna sudare. “Michael ci stava addosso. Non si poteva sbagliare” ricorda Pippen. “Se facevi un errore, ti urlava contro, ti denigrava” aggiunge Horace Grant. La richiesta della perfezione. Dagli altri, certo, ma ancora prima da se stesso. A fare da collante in una situazione così potenzialmente esplosiva per lo spogliatoio, ovviamente Phil Jackson. Il coach zen. Su di lui verte buona parte dell’episodio. Viene quindi presentata la sua carriera da giocatore, due titoli di campione Nba vinti con i New York Knicks anche se non proprio da attore protagonista, la gavetta come allenatore a Portorico e nella Cba, il ruolo da assistente di Doug Collins ai Bulls, la promozione a head coach, la collaborazione con il vice Tex Winter al quale si deve il famoso attacco triangolo: qualche tiro in meno per Jordan e un gioco più collettivo che darà i suoi frutti. A completare il ritratto alcuni aspetti della vita privata, dal passato da hippie alla passione per la cultura dei nativi americani condivisa, curiosamente, con Rodman. Forse anche per questa sensibilità comune nessuno lo ha capito come lui.
 EPISODIO 5. “In loving memory of Kobe Bryant”. La dedica che introduce la puntata è una stretta al cuore, per la tragica scomparsa pochi mesi fa dell’ex campione dei Lakers. Il giocatore più vicino a Jordan per spirito competitivo, etica del lavoro e modo di giocare: “Ciò che facevo l’avevo imparato da lui” dice lo stesso Kobe mentre scorrono le immagini dell’All-Star Game del 1998 con loro in campo. Avevano instaurato un rapporto speciale (come ricordato anche da Jordan, in lacrime, al funerale di quello che considerava un fratello minore). Come in ogni episodio poi si fa un viaggio indietro nel tempo: ecco quindi il secondo anello vinto in finale contro Portland nel 1992 e nello stesso anno l’avventura alle Olimpiadi di Barcellona con il Dream Team. Occasione per parlare anche di, e con, Toni Kukoc. L’asso croato che vestirà poi la maglia di Bulls, ma allora già scelto da Jerry Krause e per questo ai Giochi preso di mira dai suoi futuri compagni, soprattutto da Pippen. Altri aspetti toccati in questi cinquanta minuti sono il matrimonio con la Nike, con Jordan indeciso e convinto dalla madre a sposare quel marchio (la mamma ha sempre ragione), e legato proprio all’aspetto commerciale una famosa e controversa frase che gli venne attribuita per spiegare lo scarso attivismo politico e sociale: “Anche i repubblicani comprano le scarpe”. In particolare l’episodio fa riferimento al mancato supporto, richiesto dalla comunità afro-americana, ad Harvey Gantt nella corsa a un posto al senato per lo stato della Carolina del Nord nel 1990. Una delusione per chi si aspettava che Jordan potesse seguire l’esempio di campione impegnato come Muhammad Ali.
EPISODIO 5. “In loving memory of Kobe Bryant”. La dedica che introduce la puntata è una stretta al cuore, per la tragica scomparsa pochi mesi fa dell’ex campione dei Lakers. Il giocatore più vicino a Jordan per spirito competitivo, etica del lavoro e modo di giocare: “Ciò che facevo l’avevo imparato da lui” dice lo stesso Kobe mentre scorrono le immagini dell’All-Star Game del 1998 con loro in campo. Avevano instaurato un rapporto speciale (come ricordato anche da Jordan, in lacrime, al funerale di quello che considerava un fratello minore). Come in ogni episodio poi si fa un viaggio indietro nel tempo: ecco quindi il secondo anello vinto in finale contro Portland nel 1992 e nello stesso anno l’avventura alle Olimpiadi di Barcellona con il Dream Team. Occasione per parlare anche di, e con, Toni Kukoc. L’asso croato che vestirà poi la maglia di Bulls, ma allora già scelto da Jerry Krause e per questo ai Giochi preso di mira dai suoi futuri compagni, soprattutto da Pippen. Altri aspetti toccati in questi cinquanta minuti sono il matrimonio con la Nike, con Jordan indeciso e convinto dalla madre a sposare quel marchio (la mamma ha sempre ragione), e legato proprio all’aspetto commerciale una famosa e controversa frase che gli venne attribuita per spiegare lo scarso attivismo politico e sociale: “Anche i repubblicani comprano le scarpe”. In particolare l’episodio fa riferimento al mancato supporto, richiesto dalla comunità afro-americana, ad Harvey Gantt nella corsa a un posto al senato per lo stato della Carolina del Nord nel 1990. Una delusione per chi si aspettava che Jordan potesse seguire l’esempio di campione impegnato come Muhammad Ali.
 EPISODIO 6. “Molti vorrebbero essere Michael Jordan per un giorno o una settimana, ma non capiscono che non è così divertente”. Dalla prima scena si capisce che l’episodio andrà a scavare oltre il giocatore di basket, tirando fuori lati oscuri che non mancano anche se per gli appassionati parliamo dell’essere umano più vicino a una divinità. La vita di una star dello sport, successo e ricchezza. Il sogno di tutti. Certo stare costantemente sotto i riflettori può non essere una cosa facile. Reggere lo stress di stare al centro di un circo mediatico che è pronto a sottolineare i tuoi errori e non si fa problemi a buttarti giù dal piedistallo. A minare in parte la reputazione di Jordan, ci racconta l’episodio, contribuisce la pubblicazione di un libro del giornalista Sam Smith che insiste sul suo egoismo e la durezza verso i compagni, ma soprattutto la scoperta della sua passione (Ossessione? Problema?) per il gioco d’azzardo. Partite a carte e a golf i campi dove soddisfare il piacere delle scommesse. Cifre importanti, ma non così tanto rispetto ai guadagni di Jordan che non accetta lo si venga dipinto come ludopatico. Ad alimentare il polverone ci si mette anche la cattiva scelta di una gita al casinò di Atlantic City alla vigilia di gara 2 delle finali di Conference del 1993 contro i New York, partita vinta poi dai Knicks. Le critiche però non abbattono il Jordan giocatore, anzi lo caricano. L’obiettivo è vincere il terzo titolo consecutivo, entrare così nella storia. Chicago, grazie a lui, ribalta la serie dopo le prime due gare perse e nella finalissima per il titolo supera Phoenix guidata da Charles Barkley. Intanto il racconto della stagione 1997-1998 è arrivato a un momento importante: si è conclusa la regular season. Dopo l’inizio difficile, normale considerando le tensioni interne e anche la lunga assenza per infortunio di Pippen, i Bulls si sono comunque ripresi. Hanno il miglior record a Est, lo stesso dei Jazz a Ovest.
EPISODIO 6. “Molti vorrebbero essere Michael Jordan per un giorno o una settimana, ma non capiscono che non è così divertente”. Dalla prima scena si capisce che l’episodio andrà a scavare oltre il giocatore di basket, tirando fuori lati oscuri che non mancano anche se per gli appassionati parliamo dell’essere umano più vicino a una divinità. La vita di una star dello sport, successo e ricchezza. Il sogno di tutti. Certo stare costantemente sotto i riflettori può non essere una cosa facile. Reggere lo stress di stare al centro di un circo mediatico che è pronto a sottolineare i tuoi errori e non si fa problemi a buttarti giù dal piedistallo. A minare in parte la reputazione di Jordan, ci racconta l’episodio, contribuisce la pubblicazione di un libro del giornalista Sam Smith che insiste sul suo egoismo e la durezza verso i compagni, ma soprattutto la scoperta della sua passione (Ossessione? Problema?) per il gioco d’azzardo. Partite a carte e a golf i campi dove soddisfare il piacere delle scommesse. Cifre importanti, ma non così tanto rispetto ai guadagni di Jordan che non accetta lo si venga dipinto come ludopatico. Ad alimentare il polverone ci si mette anche la cattiva scelta di una gita al casinò di Atlantic City alla vigilia di gara 2 delle finali di Conference del 1993 contro i New York, partita vinta poi dai Knicks. Le critiche però non abbattono il Jordan giocatore, anzi lo caricano. L’obiettivo è vincere il terzo titolo consecutivo, entrare così nella storia. Chicago, grazie a lui, ribalta la serie dopo le prime due gare perse e nella finalissima per il titolo supera Phoenix guidata da Charles Barkley. Intanto il racconto della stagione 1997-1998 è arrivato a un momento importante: si è conclusa la regular season. Dopo l’inizio difficile, normale considerando le tensioni interne e anche la lunga assenza per infortunio di Pippen, i Bulls si sono comunque ripresi. Hanno il miglior record a Est, lo stesso dei Jazz a Ovest.
 EPISODIO 7. “Lui era la mia roccia. Eravamo molto uniti”. Già provato nonostante un altro titolo Nba, come visto nell’episodio precedente, Jordan vive nell’estate del 1993 un terribile dolore: la morte del padre, ucciso da due balordi che volevano rapinarlo. Da lì a poco annuncia di abbandonare il basket (si fa anche accenno alla presunta, mai provata sospensione legata al vizio per le scommesse) e inizia poi a dedicarsi al baseball, di cui era grande appassionato il genitore. Viene quindi raccontata l’avventura in questo sport, l’impegno negli allenamenti e i risultati (modesti) raggiunti. Un periodo ricordato comunque con piacere per come gli permise di staccare dalla sua ossessione per la palla a spicchi, di prendersi una vacanza dal basket che durerà un anno e mezzo. Ne esce fuori un Jordan più umano. Ben diverso da quello duro, dispotico, ricordato ancora dai suoi compagni nei Bulls: “Dopo una brutta partita, temevamo Michael” racconta Toni Kukoc. “In allenamento ci insultava, se la prendeva con tutti” rivela Steve Kerr. “Incuteva timore, era tangibile” aggiunge Will Perdue. Pur non nascondendo come più volte abbia superato il limite, gli stessi compagni riconoscono però che quell’atteggiamento sia servito a spronare tutti a migliorare. Certo senza Jordan Chicago sembra affrontare la stagione 1993-1994 in clima più disteso e i Bulls dimostrano di poter giocare un’ottima pallacanestro anche senza il loro re. Non abbastanza, però, per raggiungere lo stesso risultato: vincere. Solo quello conta per MJ e pazienza se per arrivarci sono necessari i suoi metodi che non lo rendono proprio simpatico.
EPISODIO 7. “Lui era la mia roccia. Eravamo molto uniti”. Già provato nonostante un altro titolo Nba, come visto nell’episodio precedente, Jordan vive nell’estate del 1993 un terribile dolore: la morte del padre, ucciso da due balordi che volevano rapinarlo. Da lì a poco annuncia di abbandonare il basket (si fa anche accenno alla presunta, mai provata sospensione legata al vizio per le scommesse) e inizia poi a dedicarsi al baseball, di cui era grande appassionato il genitore. Viene quindi raccontata l’avventura in questo sport, l’impegno negli allenamenti e i risultati (modesti) raggiunti. Un periodo ricordato comunque con piacere per come gli permise di staccare dalla sua ossessione per la palla a spicchi, di prendersi una vacanza dal basket che durerà un anno e mezzo. Ne esce fuori un Jordan più umano. Ben diverso da quello duro, dispotico, ricordato ancora dai suoi compagni nei Bulls: “Dopo una brutta partita, temevamo Michael” racconta Toni Kukoc. “In allenamento ci insultava, se la prendeva con tutti” rivela Steve Kerr. “Incuteva timore, era tangibile” aggiunge Will Perdue. Pur non nascondendo come più volte abbia superato il limite, gli stessi compagni riconoscono però che quell’atteggiamento sia servito a spronare tutti a migliorare. Certo senza Jordan Chicago sembra affrontare la stagione 1993-1994 in clima più disteso e i Bulls dimostrano di poter giocare un’ottima pallacanestro anche senza il loro re. Non abbastanza, però, per raggiungere lo stesso risultato: vincere. Solo quello conta per MJ e pazienza se per arrivarci sono necessari i suoi metodi che non lo rendono proprio simpatico.
 EPISODIO 8. “I’m Back”. Se è vero, come dice l’agente, che la frase secca per annunciare il ritorno alla pallacanestro nel febbraio del 1995 è una sua idea, Jordan è anche un genio della comunicazione. Sono tornato. Un semplice, brevissimo quanto efficace messaggio per un comunicato stampa diventato iconico. E allora rieccolo a stagione regolare quasi finita tornare sul parquet. Comprensibilmente arrugginito, dopo la lunga pausa dal basket, ci mette qualche partita a tornare a far vedere al mondo le sue magie. I Bulls non andranno comunque oltre le semifinali di Conference, eliminati ai playoff dagli Orlando Magic. Una grande delusione per Jordan. Passerà l’estate ad allenarsi per tornare in piena forma nella stagione successiva che sarà una cavalcata trionfale per Chicago con il record di vittorie in regular season e la vittoria finale contro Seattle. Ovviamente per tornare sulla vetta del mondo costringe anche i compagni a una dura preparazione. Un refrain che torna in tanti episodi quello della sua durezza con la squadra, così come quello di non provarci con lui a fare trash talking o a mancargli di rispetto: perché la partita dopo ti umilierà con una delle sue prestazioni spaziali. A farne le spese in allenamento è in particolare Steve Kerr che colpisce con un pugno nell’occhio. Un brutto episodio, di cui Jordan si vergogna, dopo il quale si cementa il rapporto tra i due. E nel mezzo di quell’estate trova anche il tempo di girare il simpatico film Space Jam, dove interagisce con i Looney Tunes, continuando ad allenarsi forte ogni giorno al termine delle riprese in una struttura messa a disposizione per lui. Molto interessante il racconto, e le immagini, delle partitelle con amici-colleghi invitati per l’occasione: grandi giocatori come Reggie Miller che ha uno spazio importante nella puntata seguente.
EPISODIO 8. “I’m Back”. Se è vero, come dice l’agente, che la frase secca per annunciare il ritorno alla pallacanestro nel febbraio del 1995 è una sua idea, Jordan è anche un genio della comunicazione. Sono tornato. Un semplice, brevissimo quanto efficace messaggio per un comunicato stampa diventato iconico. E allora rieccolo a stagione regolare quasi finita tornare sul parquet. Comprensibilmente arrugginito, dopo la lunga pausa dal basket, ci mette qualche partita a tornare a far vedere al mondo le sue magie. I Bulls non andranno comunque oltre le semifinali di Conference, eliminati ai playoff dagli Orlando Magic. Una grande delusione per Jordan. Passerà l’estate ad allenarsi per tornare in piena forma nella stagione successiva che sarà una cavalcata trionfale per Chicago con il record di vittorie in regular season e la vittoria finale contro Seattle. Ovviamente per tornare sulla vetta del mondo costringe anche i compagni a una dura preparazione. Un refrain che torna in tanti episodi quello della sua durezza con la squadra, così come quello di non provarci con lui a fare trash talking o a mancargli di rispetto: perché la partita dopo ti umilierà con una delle sue prestazioni spaziali. A farne le spese in allenamento è in particolare Steve Kerr che colpisce con un pugno nell’occhio. Un brutto episodio, di cui Jordan si vergogna, dopo il quale si cementa il rapporto tra i due. E nel mezzo di quell’estate trova anche il tempo di girare il simpatico film Space Jam, dove interagisce con i Looney Tunes, continuando ad allenarsi forte ogni giorno al termine delle riprese in una struttura messa a disposizione per lui. Molto interessante il racconto, e le immagini, delle partitelle con amici-colleghi invitati per l’occasione: grandi giocatori come Reggie Miller che ha uno spazio importante nella puntata seguente.
 EPISODIO 9. “Non osare più provocare Black Jesus”. Parole di Jordan a Miller, ricordate dalla forte guardia tiratrice che ha legato tutta la sua carriera agli Indiana Pacers. Contro la stessa squadra, allenata da Larry Bird, nel 1998 i Bulls giocano una delle serie più dure mai affrontate. Una finale di Conference, risolta soltanto alla settima partita, sulla quale si concentra metà dell’episodio dedicato anche a Gus Lett, storico capo della security di Jordan e per lui quasi un secondo padre. Come sempre la struttura è completata da flashback. Questa volta sulle finali contro i Jazz del 1997, quelle che portano a Chicago il quinto titolo Nba. Mai sazio di vittorie, Jordan come sempre alimenta il suo fuoco interiore con altre motivazioni: tra queste il mancato trofeo di miglior giocatore della stagione, assegnato quell’anno alla stella di Utah Karl Malone e non a lui. Serie combattuta di cui si ricorda in particolare gara 5. In parità, sul 2-2, si gioca in casa dei Jazz. La sera prima della partita, Jordan ha fame. È già tardi, niente servizio in camera. Viene così ordinata una pizza. Con una consegna sospetta secondo le parole, a posteriori, del suo personal trainer. Fatto sta che di notte si sente male, vomita l’anima. Intossicazione alimentare, più che influenza come indicato dalla partita che giocherà in precarie condizioni. Quella ricordata come the flu game: 38 punti in una gara che considerando cosa gli era successo non avrebbe dovuto, potuto giocare. Nella sfida decisiva Chicago si prenderà il titolo, ma questa volta gli onori se li prenderà Steve Kerr al quale Jordan lascia saggiamente il tiro decisivo. A Kerr, diventato poi un grande allenatore (ha vinto da coach tre volte il campionato alla guida dei Golden State Warriors), è dedicato un ritratto personale. Con il ricordo del padre, studioso del Medio Oriente, ucciso a Beirut quando lui aveva 19 anni.
EPISODIO 9. “Non osare più provocare Black Jesus”. Parole di Jordan a Miller, ricordate dalla forte guardia tiratrice che ha legato tutta la sua carriera agli Indiana Pacers. Contro la stessa squadra, allenata da Larry Bird, nel 1998 i Bulls giocano una delle serie più dure mai affrontate. Una finale di Conference, risolta soltanto alla settima partita, sulla quale si concentra metà dell’episodio dedicato anche a Gus Lett, storico capo della security di Jordan e per lui quasi un secondo padre. Come sempre la struttura è completata da flashback. Questa volta sulle finali contro i Jazz del 1997, quelle che portano a Chicago il quinto titolo Nba. Mai sazio di vittorie, Jordan come sempre alimenta il suo fuoco interiore con altre motivazioni: tra queste il mancato trofeo di miglior giocatore della stagione, assegnato quell’anno alla stella di Utah Karl Malone e non a lui. Serie combattuta di cui si ricorda in particolare gara 5. In parità, sul 2-2, si gioca in casa dei Jazz. La sera prima della partita, Jordan ha fame. È già tardi, niente servizio in camera. Viene così ordinata una pizza. Con una consegna sospetta secondo le parole, a posteriori, del suo personal trainer. Fatto sta che di notte si sente male, vomita l’anima. Intossicazione alimentare, più che influenza come indicato dalla partita che giocherà in precarie condizioni. Quella ricordata come the flu game: 38 punti in una gara che considerando cosa gli era successo non avrebbe dovuto, potuto giocare. Nella sfida decisiva Chicago si prenderà il titolo, ma questa volta gli onori se li prenderà Steve Kerr al quale Jordan lascia saggiamente il tiro decisivo. A Kerr, diventato poi un grande allenatore (ha vinto da coach tre volte il campionato alla guida dei Golden State Warriors), è dedicato un ritratto personale. Con il ricordo del padre, studioso del Medio Oriente, ucciso a Beirut quando lui aveva 19 anni.
 EPISODIO 10. “A fine partita, non lo si può lasciar tirare. È infallibile” sottolinea il cronista dopo quello straordinario canestro. The last shot, i due punti che portano alla vittoria del sesto titolo i Bulls. Il fermo immagine della ripresa da dietro, con Jordan in sospensione, palla ormai partita dalle mani, il muro dei tifosi di Jazz che sembra pregare perché non entri, è come un quadro di un grande pittore. Meraviglioso. Fine di una serie sulla quale è naturalmente incentrato l’ultimo episodio. Tra gli episodi riportati una nuova fuga di Rodman nel mezzo delle finali, per un impegno su un ring di wrestling al fianco di Hulk Hogan, e momenti delle varie partite sino all’epilogo in gara 6 con quell’ultimo minuto raccontato anche all’inizio di questo pezzo. E poi la festa per il sesto anello, ma anche il rammarico MJ di non aver potuto tentare l’assalto a un nuovo titolo Nba per via dello smantellamento della squadra e la rifondazione voluta da proprietà e dirigenza. Via Pippen, via Rodman, via Phil Jackson. Jordan si ritirerà, per la seconda volta. Anche in questo caso l’abbandono non sarà definitivo, tornerà a giocare tra il 2001 e il 2003 con la maglia però dei Washington Wizards. Ma questa è un’altra storia e anche se non sarà un periodo entusiasmante come il resto della sua carriera (con buoni numeri personali comunque e alcune prestazioni strepitose considerando l’età), questo certo non toglie nulla al suo percorso da giocatore. Aveva già scritto la sua leggenda con i Bulls.
EPISODIO 10. “A fine partita, non lo si può lasciar tirare. È infallibile” sottolinea il cronista dopo quello straordinario canestro. The last shot, i due punti che portano alla vittoria del sesto titolo i Bulls. Il fermo immagine della ripresa da dietro, con Jordan in sospensione, palla ormai partita dalle mani, il muro dei tifosi di Jazz che sembra pregare perché non entri, è come un quadro di un grande pittore. Meraviglioso. Fine di una serie sulla quale è naturalmente incentrato l’ultimo episodio. Tra gli episodi riportati una nuova fuga di Rodman nel mezzo delle finali, per un impegno su un ring di wrestling al fianco di Hulk Hogan, e momenti delle varie partite sino all’epilogo in gara 6 con quell’ultimo minuto raccontato anche all’inizio di questo pezzo. E poi la festa per il sesto anello, ma anche il rammarico MJ di non aver potuto tentare l’assalto a un nuovo titolo Nba per via dello smantellamento della squadra e la rifondazione voluta da proprietà e dirigenza. Via Pippen, via Rodman, via Phil Jackson. Jordan si ritirerà, per la seconda volta. Anche in questo caso l’abbandono non sarà definitivo, tornerà a giocare tra il 2001 e il 2003 con la maglia però dei Washington Wizards. Ma questa è un’altra storia e anche se non sarà un periodo entusiasmante come il resto della sua carriera (con buoni numeri personali comunque e alcune prestazioni strepitose considerando l’età), questo certo non toglie nulla al suo percorso da giocatore. Aveva già scritto la sua leggenda con i Bulls.
Arrivati alla fine, ancora qualche considerazione. Chi scrive ha passato gli anni da teenager proprio nell’epoca d’oro dei Chicago Bulls, seguendo l’Nba tra partite e riviste (come si poteva allora) e passando molti pomeriggi a giocare su un campo in cemento cercando di imitare le movenze di Michael Jordan. Come sicuramente per tanti altri appassionati della stessa generazione, The Last Dance ha in questo senso anche il fascino del viaggio nel tempo che permette di fare agli spettatori. Almeno quelli che amano il basket. Per gli altri questo aspetto magari verrà meno, ma a vantaggio del piacere della scoperta della storia che ovviamente a chi segue questo sport è nota. E, va detto, non presenta nel racconto chissà cosa di inedito. Un documentario appassionante al di là dei limiti che bisogna tenere in conto per il taglio agiografico, per non dire da biografia autorizzata. Si erige un monumento a Jordan, con gli altri protagonisti di quegli anni un po’ relegati a figure di contorno che ruotano attore al re sole. Un monumento giustificato, considerato quello che ha mostrato sui campi da basket. Il più grande cestista, e forse atleta in assoluto, della storia: “The best there ever was. The best there ever will be”.
Video

Fabio Canessa
Viaggio continuamente nel tempo e nello spazio per placare un'irresistibile sete di film. Con la voglia di raccontare qualche tappa di questo dolce naufragar nel mare della settima arte.