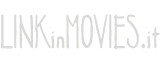Venezia 75, promossi e bocciati: guida ai film
- Scritto da Francesco Siciliano, Davide Parpinel, Fabio Canessa
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Commenta per primo!
 I giudizi a tutti i film visionati dai nostri inviati nelle varie sezioni della Mostra del Cinema di Venezia 2018. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 11 giorni. A cura di Francesco Siciliano, Davide Parpinel, Simone Tricarico, Fabio Canessa
I giudizi a tutti i film visionati dai nostri inviati nelle varie sezioni della Mostra del Cinema di Venezia 2018. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 11 giorni. A cura di Francesco Siciliano, Davide Parpinel, Simone Tricarico, Fabio Canessa
Venezia 75 - In concorso
 First Man, di Damien Chazelle (Stati Uniti)
First Man, di Damien Chazelle (Stati Uniti)![]()
Ryan Gosling veste i taciturni panni di Neil Armstrong nel racconto della missione spaziale che permise all’astronauta più celebre della Storia di essere il primo uomo a sbarcare sulla Luna. Dopo aver tentato di dare nuova linfa all’immaginario del musical con La La Land, Damien Chazelle prova al terzo film a ricalibrare le suggestioni di un’avventura epica spaziale di cui Hollywood si è già fatta carico in passato, senza particolari fortune. Impresa riuscita a metà per il regista, ma godibile: se è indubbio il talento di Chazelle nel racconto per immagini (impressionante il senso claustrofobico che riesce a imprimere alle scene della missione spaziale), lasciano invece ancora un po’ perplessi i suoi limiti in termini drammaturgici nello sviluppo delle psicologie dei personaggi. First Man è tante cose insieme, forse troppe: un’elaborazione di un lutto attraverso una conquista inimmaginabile (nel cuore di Armstrong il viaggio verso la Luna diventa un mezzo per consegnare alla vastità dello spazio il vivo ricordo della figlia scomparsa in tenera età per un male incurabile), una sfida al progresso dell’uomo in un’epoca in cui nessuno credeva al giovamento di un approdo sulla Luna (un richiamo all’oggi, a una politica ripiegata su se stessa che ha perso il gusto per la sfida), un tentativo di rappresentare al cinema il mito attraverso le piccole cose del quotidiano degli astronauti. Un film godibile sul piano dell’intrattenimento, ma in alcuni tratti inespresso. (Francesco Siciliano)
 The Mountain, di Rick Alverson (Stati Uniti)
The Mountain, di Rick Alverson (Stati Uniti)![]()
Stati Uniti, anni Cinquanta. Rimasto solo in seguito alla morte del padre, un ragazzo della profonda provincia americana decide di andare via di casa per unirsi come assistente a un medico che promuove cure di elettroshock presso vari ospedali psichiatrici sparsi nell’Ovest del Paese. Il giovane ha la madre rinchiusa in un ospedale psichiatrico: la scelta di partire nasconde forse la speranza di avere l’opportunità di saperne di più sulle condizioni del genitore, ma ben presto il contatto con i pazienti del dottore scatenano in lui un’instabilità mentale ed emotiva. Delude le aspettative il nuovo lavoro di uno dei nomi più attesi alla Mostra. Autore di Entertaiment e The Comedy, film indie che avevano riscosso apprezzamento nel circuito dei festival, Alverson non è un regista ‘facile’ per via delle traiettorie respingenti delle sue storie. Questa volta chiede troppo allo spettatore: messa in scena rigorosa, ricca di riferimenti alle geometrie kubrickiane e lynchiane, ma il film, che sembra sempre sul punto di esplodere, di rivelarsi, è falsamente autoriale, risultando pretestuoso e criptico oltre ogni soglia di tolleranza. The Mountain finisce così per essere uno di quei lavori che restano imprigionati nella mente del suo regista, tanto si fatica a trovare il bandolo della matassa. (F.S.)
![]()
Una giovane ballerina americana riesce a farsi ammettere a una prestigiosa accademia di danza nella Berlino del 1977. Non sa che una presenza oscura si muove tra le pareti della scuola: presto la ragazza si ritroverà risucchiata in un incubo ad occhi aperti fatto di forze invisibili, sparizioni improvvise, visioni allucinate che avranno un impatto sulla sua attività artistica e sulla sua vita. Remake più o meno fedele del cult di Dario Argento, il Suspiria di Luca Guadagnino è un horror d’autore, ben diretto ed interpretato (come sempre impeccabile Tilda Swinton nei panni della temutissima insegnante a capo dell’accademia), avvincente quando vuole veicolare inquietudine in chi guarda, ma con il grosso difetto di caricarsi di troppi significati mal amalgamati tra loro. È come se Guadagnino cercasse continuamente di nobilitare il genere con cui si è confrontato per la prima volta infarcendolo sotto traccia di temi alti come la colpa e la vergogna per un passato sanguinoso (il nazismo) o come il limite labile che separa l’arte da ciò che può trasformarsi in una ostentazione di vanità. Si fatica a districarsi tra i vari spunti narrativi, ma per fortuna a intrattenerci ci sono le musiche ipnotiche di Thom Yorke. (F.S.)
 The Sisters Brothers, di Jacques Audiard (Francia, Belgio, Romania, Spagna)
The Sisters Brothers, di Jacques Audiard (Francia, Belgio, Romania, Spagna) ![]()
Fare i killer nel vecchio west è un mestiere per pochi. Charlie Sisters è sicuramente nato per uccidere, mentre suo fratello maggiore Eli Sisters ha dei forti dubbi e una moralità che lo tormenta. Un giorno il Commodoro della città, loro datore di lavoro, gli commissiona di trovare e uccidere l'uomo che ha inventato un metodo pratico e veloce, ma molto pericoloso, di rintracciare l'oro nei fiumi della California, perché vuole impossessarsene. I due montano a cavallo e nella lunga marcia verso l'Ovest capiscono quanto sono diversi. Sono però, fratelli e non possono tradirsi né lasciarsi, nemmeno per tutto l'oro trovato. Da Jacques Audiard è doveroso attendersi una storia graffiante. Le atmosfere western, infatti, ci sono tutte; la sporcizia e la polvere sui volti di John C. Reilly e Joaquin Phoenix è profonda; le pistole fumano e i dialoghi sono crudi e taglienti nelle poche parole utilizzate dai Sisters brother per raccontarsi. A ciò il regista francese associa, inoltre, un buonismo famigliare rimarchevole, un calore umano appiccicato che per come è ritratto soprattutto nel finale (luci avvolgenti, sorrisi teneri e quella ipocrita calma armoniosa regina dalla case) fa crollare il film. È apprezzabile la volontà di Audiard di raccontare un briciolo di umanità in un contesto spietato come quello del west, ma non di stemperarla e sfaldarla in questo modo. (Davide Parpinel) The Favourite, di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti)
The Favourite, di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti)![]()
Sfruttando la fragilità emotiva e fisica di Sua Maestà la Regina Anna, due dame manipolatrici e ambiziose, una temuta e rispettata, l’altra intenta a liberarsi di un passato disonorevole, sono in competizione per ingraziarsi le simpatie della sovrana e tentare così la scalata ai vertici della corte d’Inghilterra del XVIII secolo, nel mezzo di una guerra con la Francia che sta dissanguando le finanze del regno. Colpi bassi, menzogne e malignità incrociate per conquistare il cuore della sovrana, le cui pulsioni saffiche non sono un segreto per le due donne. Il cinema di Yorgos Lanthimos ha perso un po’ di smalto da quando le produzioni internazionali hanno messo gli occhi su di lui. Al terzo film in lingua inglese, il primo con una sceneggiatura che non porta la sua firma o quella del suo fido collaboratore Efthymis Filippou, il regista imbastisce un film in costume che vanta un mix accattivante di commedia, grottesco e ricostruzione storica, ma sono lontani i tempi di Kynodontas e Alps, quando Lanthimos metteva in discussione le convenzioni narrative e registiche con storie più personali. (F.S.) Roma, di Alfonso Cuaron (Messico)
Roma, di Alfonso Cuaron (Messico)![]()
Racconto famigliare autobiografico in bianco e nero, ambientato in un quartiere borghese (Roma del titolo) nel Messico dei primi anni Settanta. Prodotto da Netflix, è un film carico di ricordi di Alfonso Cuaron (i personaggi e le location sono ispirati minuziosamente al passato familiare del regista) che per fortuna non si trasforma in un’operazione nostalgico-compiaciuta. Emerge al contrario il ritratto misurato e toccante di un microcosmo al femminile che unisce due donne infelici appartenenti a ceti diversi, Sofia, biochimica madre di quattro bambini, e Cleo, la sua domestica di origini mixteche. La prima abbandonata dal marito, un medico fedifrago, la seconda dal fidanzato, un ragazzo appassionato di arti marziali che non ne vuole sapere di riconoscere il bambino che lei porta in grembo. Ma Roma è anche uno spaccato dei sommovimenti che attraversavano la società messicana dell’epoca (in una sequenza intravediamo i fatti di sangue che passarono alla Storia come il Massacro del Corpus Christi). Un’opera in equilibrio tra privato e pubblico, dunque, che mette a nudo cicatrici familiari e sociali, con uno stile distaccato e dilatato ma carico di umanità che ricorda i grandi maestri asiatici. (F.S.)
 What You Gonna Do When the World's On Fire, di Roberto Minervini (Italia, Stati Uniti, Francia)
What You Gonna Do When the World's On Fire, di Roberto Minervini (Italia, Stati Uniti, Francia)![]()
Cosa fare, quindi, se il mondo è in fiamme? Ribellarsi, reagire, protestare, contare solo sulle proprie forze? Oppure uscire e camminare sul mondo con l'innocenza e il disincanto di un ragazzino o con la forza di un adulto che non ci sta. Roberto Minervini si dimostra in questo nuovo lavoro What you gonna do when the world's on fire? un attento indagatore dell'altra America. La sua macchina da presa si insinua dentro le esistenze degli emarginati afro americani del Sud, per restituirne la voce. Questa è quella di chi cerca di sopravvivere coltivando il proprio sogno americano, cioè aprire un bar; ci sono poi gli occhi e il volto di un ragazzino alle prese con una sana voglia di scoprire e indagare il mondo, seppur gli evidenti problemi scolastici (non del tutto a causa della sua negligenza)lo costringano a casa. Poi c'è la voce dei membri delle Black Panthers, movimento di ribellione afroamericano, che a seguito della morte di Alton Sterling nel 2016 e dopo le devastanti conseguenze dell'uragano Katrina girano casa per casa per sensibilizzare gli altri afro americani sulla situazione di crisi e sulle ritorsioni della polizia. Minervini affresca questa situazione inquadrando i volti, oltre che le parole, e montando il suo documentario restituendo al pubblico il filo di indagine alla base di esistenze tra loro diverse, ma accomunate dalla medesima forza. Così raggiungono la superficie anche le loro contraddizioni e quella confusione che caratterizza i movimenti di pancia e non di riflessione. C'è poca empatia, però anche in questo risiede la cifra del regista italiano il cui scopo e testimoniare e documentare il reale e solo dopo emozionare. (D.P.)
 Sunset, di Laszlo Nemes (Ungheria)
Sunset, di Laszlo Nemes (Ungheria)![]()
Ungheria, 1910 circa. Giunge a Budapest dopo anni di assenza la giovane Irisz Leiter. Ha vissuto la sua vita a Trieste, ma ora desidera lavorare come modista nel negozio di capelli che fu dei suoi genitori. L'attuale proprietario del negozio, però, rifiuta la sua candidatura, perché il suo cognome è scomodo soprattutto a causa di suo fratello. Sembra quasi che la ragazza scopra in questo momento di avere un fratello e quindi, spinta dalla curiosità si mette alla sua ricerca. Mentre lo rincorre e poi lo raggiunge scopre la realtà sociale di Budaspet divisa tra i sudditi degli austriaci e un movimento anarchico intento a sabotare e distruggere questo ancien régime. Il 1914 e la guerra di trincea è alle porte e il tramonto è vicino. Prosegue l'indagine storica sull'Ungheria del fortunato Laszlo Nemes che dal tema dell'Olocausto affrontato ne Il figlio di Saul si sposta alla Budapest precedente lo scoppio del Primo conflitto mondiale. I piani narrativi in questo nuovo lavoro sono due: il primo riguarda la ragazza protagonista che cerca suo fratello e la sua famiglia. Il secondo riguarda appunto l'Ungheria e la polveriera sociale insita nel vasto Impero Austro-ungarico. Il regista conduce così la doppia indagine, seguendo con la camera a meno il volto della protagonista, che si diviene unica nel momento in cui la ragazza rintraccia il fratello. La scena finale, l'ultimo fotogramma, però, generano un po' di confusione. La giovane Irisz Leiter si trova in trincea a combattere, presumibilmente, in difesa della sua nazione. Ma come? Irisz non è venuta a Budapest per cercare la sua famiglia? Quali riprese o passaggi narrativi indicano nel corso del film che questa si possa avvicinare agli interessi politici dell'Ungheria? Sembra piuttosto che la ragazza si schieri da un certo momento in avanti dalla parte degli anarchici. Quesiti questi che trovano molteplici risposte proprio a causa dello stile registico di Nemes. La camera a mano, la visione limitata, i dialoghi rarefatti e costruiti spesso su domande precise e risposte evasive non permettono di capire le sotto connessioni della storia (quale passato hanno i genitori; il fratello chi è, ma soprattutto Budapest è da distruggere o liberare?). Rimane così lo stile di Nemes (personale, innovativo, ragionato come anche la scelta di girare in 35 mm), ma non la narrazione cinematografica. (D.P.) Doubles vies (Non-Fiction), di Olivier Assayas (Francia)
Doubles vies (Non-Fiction), di Olivier Assayas (Francia)![]()
Alain è un uomo di mezza età ai vertici di una casa editrice in cui è in atto una trasformazione per rimanere al passo con i tempi di un mercato sempre più slegato dalla carta stampata. Leonard, suo amico, è uno scrittore che ha l’abitudine di sfruttare le sue esperienze di vita vissuta per ricavarne dei romanzi, un’inclinazione che gli ha attirato le ire di un’ex fiamma cui non è piaciuto di finire sulle sue pagine. Quando Alain comunica a Leonard di non avere intenzione di pubblicare il suo nuovo romanzo, lo scrittore inizia a perdere fiducia in se stesso. Doubles vies (Non-Fiction) ha i connotati di un gradevole film-saggio in cui un gruppo di personaggi legati al mondo dell’editoria disquisiscono sulla crisi della carta stampata nell’epoca dei social network, tra bevute di vino, citazioni letterarie e tresche amorose tenute celate. Puro cinema francese che non si prende troppo sul serio ma che sa amalgamare ironia, sarcasmo ed una estrema lucidità nella riflessione del presente. (F.S.)
 The Ballad of Buster Scruggs, di Joel e Ethan Coen (Stati Uniti)
The Ballad of Buster Scruggs, di Joel e Ethan Coen (Stati Uniti)![]()
Diviso in sei parti, un film antologico che narra, a mo’ di brevi parabole, storie diverse, per stile, modalità di racconto e temi affrontati, tutte accomunate dall’ambientazione western. I fratelli Coen dicono di essersi ispirati ai film a episodi italiani degli anni Settanta che mettevano insieme opere brevi di genere diverso su uno stesso tema. The Ballad of Buster Scruggs paga una certa discontinuità: su tutto aleggia quel fatalismo maligno che come al solito i personaggi dei Coen si ritrovano a combattere, con alcuni capitoli che risultano più riusciti di altri. Esperimento comunque godibile: un divertissement colto e ironico seppur non sempre ispiratissimo. (F.S.)
 At Eternity's Gate, di Julian Schnabel (USA)
At Eternity's Gate, di Julian Schnabel (USA)![]()
La tormentata, depressa, emarginata vita di Vincent Van Gogh. Questo analizza Julian Schnabel in At Eternity’s Gate che però, non intende raccontare passo dopo passo dall'infanzia alla morte l'esistenza del pittore olandese. L’attenzione registica è sull'artista e le sue opere. Ogni scena del film, infatti, è un quadro di Van Gogh o per meglio dire ogni scena nasce dalla tela del pittore, per poi mescolarsi visivamente nel volto di Willem Defoe che lo interpreta. La fotografia per questo motivo è virata verso i colori predominanti la pittura dell'olandese, il giallo e il blu, e la macchina da presa scandaglia ogni singolo pigmento che compone la spessa materia degli oli. At Eternity's Gate è soprattutto un film sulla relazione tra Van Gogh e la natura che lo inebriava e appagava, tanto quanto l'amore di suo fratello Theo, e gli permetteva di superare la depressione, le sconfitte, l'indifferenza, i soprusi, l'alone di morte che spesso lo attanagliavano. Il regista riflette, così, chiaramente sul significato dell'essere artista, sulla nascita e sviluppo della sua coscienza poetica, fermandosi sulle espressioni di Defoe, ponendo l'accento sui contesti e sui dettagli verbali come ad esempio le inquadrature in cui Defoe è letteralmente immerso nella natura. Alla fine rimane un ritratto commosso che spiega Van Gogh che prende forma anche grazie alla sua voce fuori campo. (D.P.)
 Acusada, di Gonzalo Tobal (Messico)
Acusada, di Gonzalo Tobal (Messico)
![]()
Quante volte nei telegiornali o sulla carta stampata sono rimbalzate notizie di cronaca nera, di omicidi efferati che al termine del processo non hanno un colpevole? Qualcuno muore e non si capisce chi sia stato. Dolores è una ragazzina, figlia di un'agiata borghesia, accusata dell'omicidio di una sua coetanea. Passano due anni e inizia il processo. In questo lasso di tempo i genitori hanno tenuto la figlia al riparo dai media e dal rimbombo mediatico della vicenda, fino a impedirle di navigare in Rete. Il processo inizia dentro e fuori l'aula di tribunale e la pressione attorno a Dolores è sempre più forte. Opera seconda per il messicano Gonzalo Tobal, il quale dimostra ancora di dover crescere. I piani di analisi nel film sono molteplici. Spaziano dal dramma della ragazza accusata, al dolore della sua famiglia, ai media e la loro ricerca dello scoop. Queste le frecce nella faretra del regista che scaglia i suoi dardi verso il bersaglio con pochissima forza e molta superficalità, tanto da smorzare la loro forza a metà del percorso. La scelta del regista è infatti di legare insieme questi punti di analisi con scene madri drammatiche e strappa lacrime e una musica pretestuosa e altisonante che permettono con molta difficoltà allo spettatore di comprendere quale dovrebbe essere lo scopo di Acusada: dimostrare il fascino subito dalle persone per la cronoca nera grazie al malsano uso delle notizie da parte dei media. A indirizzare l'attenzione dello spettatore verso questo obiettivo non bastano i titoli dei giornali letti dai protagonisti, la folla giudicante che cinge la casa di Dolores, né tantomeno i dibattiti in tv in cui la ragazza è invitata. Lo spunto del film, in conclusione, potrebbe essere buono, la messa in scena da rivedere, il film da ricostruire da capo. (D.P.)
 Never Look Away, di Florian Henckel von Donnersmarck (Germania)
Never Look Away, di Florian Henckel von Donnersmarck (Germania)![]()
Una giovane coppia di studenti iscritti alle Belle Arti - lui pittore, lei stilista - stringono un’appassionata relazione sentimentale che si ritrova a doversi misurare con le difficoltà dei cambiamenti della Germania, dal tramonto del Nazismo al Muro di Berlino. Il loro amore è anche ostacolato dal di lei padre, un ginecologo dell’alta borghesia per nulla entusiasta delle umili origini del ragazzo e il cui passato macchiato da atroci crimini commessi durante il Nazismo rischia di minare la felicità della coppia. Smaltito l’imbarazzante battesimo a Hollywood con il dimenticabile The Tourist, Florian Henckel von Donnersmarck torna a una dimensione europea affrontando la Storia recente della Germania come aveva fatto con il suo interessante esordio, Le vite degli altri. Al regista non sta a cuore tanto riproporre il passato della Germania in un affresco alla Heimat (sebbene l’ampiezza temporale in cui si svolge il film lo lascerebbe pensare), quanto una riflessione sul ruolo dell’artista e dei suoi strumenti espressivi nella rappresentazione di una società soggiogata dagli assolutismi della Storia. Pur se la messa in scena paga qualche forzatura e ridondanza romanzata di troppo che rischia di far sprofondare il racconto in una fiction di alta fattura, il film si dimostra genuino e acuto nel suo dilemma (è possibile trasformare in arte i traumi della Storia?), restando fedele al suo titolo (che tradotto sarebbe Opera senza autore): prendere o lasciare. (F.S.)
 Vox Lux, di Brady Borbet (Stati Uniti)
Vox Lux, di Brady Borbet (Stati Uniti)
![]()
Ritorna al Lido e alla Mostra del Cinema Brady Corbet, dopo la vittoria del premio per la miglior Regia nella sezione Orizzonti e il Premio Opera Prima Luigi de Laurentis del 2015 con L'infanzia di un capo. Torna al Lido, però, con un filo di arroganza. Vox Lux, suo nuovo lavoro, si propone con grandi scene di impatto visivo, un forte linguaggio pop in una cornice di indagine ultra-contemporanea. Al centro c'è Celeste, che da ragazzina è sopravvissuta alla strage compiuta da un suo compagno di classe. Per reazione scrive una canzone la quale le conferisce in pochissimo tempo il successo internazionale e le spalanca le porte del regno del pop. La ragazza cresce, ha una figlia, e soprattutto cammina spedita sulla strada dell'autodisturzione a causa di droga, eccessi e una forte incapacità di relazionarsi. Corbet, quindi, sembra dire che la storia di Celeste rappresenta la perdita dell'innocenza dell'America di oggi che nell'arco temporale di analisi, dal 1999 al 2017, dal massacro alla scuola Columbine a oggi, passando per l'11 settembre 2001, vede distruggersi i suoi più privati sentimenti a discapito dell'immagine pubblica. È proprio in ciò che risiede l'arroganza del regista. Si erge a pensatore dell'oggi, nonostante la sua breve carriere artistica. Vox Lux è, infatti, molto generico e poco indagatore su motivazioni, conseguenze, reazioni al tema principale, per invece accontentarsi del forte impatto visivo delle scene. Vedere Celeste-Natalie Portman che litiga con fervore o osservare la pressione che la circonda da ragazzina e da adulta quando gira un video o parla con i suoi discografici, rendono il film scorrevole nella visione, ma non lasciano traccia di riflessione nello spettatore. Può bastare lo stile da video musicale per raccontare i giorni nostri? Forse no, come non è necessario girare la pellicola in 35 mm, come ha scelto di fare Corbet, per conferire alla pellicola un alone di storicità, quando invece il digitale è sicuramente più adatto per parlare di ultra contemporanietà. Apprezzabile, infine, l'interpretazione di tutti gli attori protagonisti, Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy e Stacey Martin. (D.P.)
 Our Time, di Carlos Reygadas (Messico)
Our Time, di Carlos Reygadas (Messico)
![]()
Amore, felicità, scontri-incontri, incomprensioni e accordi nella vita di una coppia adulta ai giorni nostri. Questo sembra essere l'ambito di indagine di Our Time, diretto dal fortunato regista Carlos Reygadas. Il luogo della scena è la campagna messicana in cui vivono un noto poeta, anche allevatore di tori, sua moglie Esther (interpretati dallo stesso regista e dalla compagna Natalia Lòpez) e i figli. Sono una coppia aperta e sono chiari e onesti tra loro, ma quando la donna risulta evasiva e misteriosa sulla relazione con un giovane allevatore di cavalli, il loro rapporto scricchiola. In un percorso naturalistico a partire dalla visione di alcuni bambini intenti a giocare in un fiume fangoso, per arrivare alla quotidianità della coppia, passando per la visione dei comportamenti in gregge dei tori, Reygadas si limita a osservare con uno pizzico di opportunismo. Se la riflessione della pellicola si focalizza sulla reale esistenza dell'amore e sul concetto di felicità in una coppia di oggi, qualcosa manca. È infatti, assente l'indagine psicologica dei personaggi che avrebbe potuto portare all'emersione più chiara della tesi del film. Sullo schermo invece trova spazio il voyerismo del marito e una disperazione costante della donna, ma per quale motivo? Forse è innamorata del suo amante e non riesce a confessarlo nemmeno a sé stessa? Non è dato saperlo, proprio perché Reygadas non pone a perno della pellicola la donna. Il personaggio di Esther appare, infatti, solo un burattino tra le mani del marito il cui scopo non è mai del tutto chiaro. Oltre che narrativamente, infine, anche registicamente Reygadas è latitante se non fosse per l'accuratezza con cui descrive i comportamenti in branco dei tori, metafora abbozzata che non trova una vera sponda con la vicenda dei protagonisti. (D.P.)
![]()
Il 22 luglio 2011 un doppio attentato terroristico per mano di un estremista di destra gettò nel caos la Norvegia: prima con un’autobomba a due passi dagli uffici governativi a Oslo, poi con un massacro a colpi di arma da fuoco in un’isola poco lontano dalla capitale, dove era in corso un campeggio di giovani attivisti riuniti per discutere di accoglienza e integrazione. Settantasette morti e duecento feriti che nelle intenzioni dell’attentatore erano l’obiettivo di una dichiarazione di guerra contro il multiculturalismo della Norvegia e dell’intera Europa. July 22 è la cronaca minuziosa e realistica di come il rigurgito xenofobo che attanaglia sempre di più il presente del Vecchio Continente si sia trasformato in un folle ma lucido piano di eliminazione e destabilizzazione di un’idea di accoglienza e tolleranza e delle persone che la rappresentano. Paul Greengrass, lo conosciamo, filma tutto come se l’azione si svolgesse in presa diretta, con uno stile che non vuole mai prescindere da una forte componente realistica. Il che può essere a volte un pregio o un limite, ma in questo caso ciò che sembrerebbe una rappresentazione piatta ed anodina di un evento sanguinoso, assurge invece a sorta di kammerspiel intimo di uno scontro prima fisico e poi psicologico tra vittime e carnefice, ovvero tra due visioni della società che potrebbero decidere i nostri destini nei prossimi anni. Senza retorica e senza scorciatoie, ma anche senza vie di fuga dalla realtà. (F.S.)
 The Nightingale, di Jennifer Kent (Australia)
The Nightingale, di Jennifer Kent (Australia)
![]()
Il messaggio del film è: in un modo brutale, in cui vige la prevaricazione e la violenza, l'unica arma è la gentilezza, il rispetto e l'educazione che possono ferire più di uno schiaffo. Se fosse davvero così, però, The Nightingale, secondo lungometraggio della regista australiana Jennifer Kent, non dovrebbe avere il finale visto. Per intenderci, dopo la scena in cui la protagonista Clare raggiunge il tenente, autore di atroci violenze nei confronti suoi e della sua famiglia, e di fronte ai suoi superiori gli manifesta tutto il suo disprezzo, cantando con la dolcezza dell'usignolo, poteva calare il sipario sul film. Invece c'è una scena in più, anzi due che smentiscono il fine proposto sopra. La prima è una scena brutale, di vendetta; la seconda conferma che lo scopo del film è un altro. Tasmania inzio Ottocento. Gli inglesi "liberano" la terra dagli aborigeni segregandoli e uccidendoli, in più qui detengono a torto o a ragione i prigionieri irlandesi, come Clare, suo marito e la loro bambina. La donna è soggetta a troppe attenzioni da parte del tenente che governa la zona. Una sera il marito della ragazza si ribella ai sopprusi e succede l'irreparabile. Da questo momento scatta la vendetta di Clare, la quale accompagnata da Billy, aborigeno progioniero, attraversa la Tansmania alla ricerca del tenente, intanto trasferito in un'altra zona. In questo percorso i dialoghi tra Clare e Billy, disperati ed emarginati, virano il senso della pellicola nella contemplazione della regista del passato malvagio dell'Australia. La Kent abbandona, quindi, il personaggio di Clare, mostrandola in preda a deliri mistici e a un'indecisione nel perseguire la sua vendetta che stemperano improvvisamente il suo fervore inziale. Emerge la figura e la disperazione di Billy, che si erge così, a unico protagonista. The Nightingale è, quindi, un film molto confuso con personaggi caratterizzati con l'accetta, in cui l'immagine vuole più stupire che gettare un seme di riflessione.
 Capri-Revolution, di Mario Martone (Italia)
Capri-Revolution, di Mario Martone (Italia)
![]()
Capri all'inizio del Novecento era un'isola laboratorio. Da una parte la vita contadina, fatta di tradizioni, onori famigliari e differenze sociali marcate; dall'altro lato una comunità gestita da un pittore inglese che sperimentava la vita, creando una micro società democratica, senza regole, e si lasciava ispirare artisticamente dalla splendida natura di Capri. Questa la cornice del nuovo film di Mario Martone. La protagonista è Lucia, Marianna Fontana, giovane contadina. Quando osserva i comportamenti della comunità del pittore inglese, ne rimane affascinata e decide di unirsi a loro, perdendo così il legame con la sua famiglia. A contorno c'è un altro personaggio, un giovane medico con idee progressiste che parlano di popolo e di scontro tra nuovo e vecchio mondo. A breve l'Italia entrerà nella Prima guerra mondiale. Questi i tratti di Capri - Revolution, ma qual è l'urgenza di Martone? Dopo Noi credevamo in cui racconta le basi della nascita della nazione Italia e Il giovane favoloso in cui analizza il pensiero moderno e ancora attuale di Giacomo Leopardi, cosa ha voluto proporre con questo nuovo film? Forse una rivoluzione culturale e di pensiero in un'Italia alla ricerca di sé stessa che però si perde in un'evanescenza e un'inconsistenza narrativa inaspettata per Martone. Non si sente lui, la sua necessità di racconto, lo spunto di un autore di cinema. Il suo unico impegno di regista, infatti, è osservare i dibattiti verbosi tra il pittore e il medico, tra Lucia e la sua famiglia o la ragazza e il giovane medico, che non aiutano la storia a svilupparsi.
 Zan (Killing), di Shinya Tsukamoto (Giappone)
Zan (Killing), di Shinya Tsukamoto (Giappone)![]()
Giappone, seconda metà dell’Ottocento. Lo shogunato Tokugawa è dilaniato da lotte intestine e molti samurai vivono in condizioni di povertà. Mokunoshin è un giovane e abile ronin, samurai senza padrone, che ha deciso di vivere in un villaggio di campagna insieme a una famiglia di contadini offrendo loro protezione in cambio di vitto e alloggio. Le sue abilità con la spada hanno attirato l’attenzione di Jirozaemon, un altro ronin, temuto e rispettato, giunto nel villaggio per reclutare samurai con cui andare a Kyoto ed Edo a combattere per difendere lo shogunato dai suoi nemici. L’arrivo nel villaggio di un gruppo di temibili banditi sconvolge i piani di Jirozaemon e costringe Mokushin a fare i conti con un segreto che mette in discussione il suo essere un uomo di spada. Shinya Tsukamoto chiude il Concorso di Venezia 75 con uno dei film più stimolanti e intensi della selezione. Con mezzi limitati (il regista ha dovuto autoprodursi il film) ma un cast di prima grandezza (al fianco dello stesso Tsukamoto ci sono Yu Aoi e Sosuke Ikematsu), Killing possiede l’impeto visivo dei migliori lavori dell’autore di Tetsuo, nella sua abbacinante e progressiva deflagrazione di una disamina sul concetto di Yu (Eroico coraggio) del Bushido. Il samurai di Tsukamoto è un ‘ossimoro’: un guerriero valoroso che non riesce ad adoperare il suo strumento di morte - la spada - per privare della vita i suoi avversari. Dietro questa figura quasi inedita nella cinematografia giapponese, Tsukamoto condensa le sue ossessioni per la natura umana e i suoi labirinti interiori, regalandoci così un film prezioso e unico. (F.S.)
Fuori Concorso - Fiction
 La quietud, di Pablo Trapero (Argentina)
La quietud, di Pablo Trapero (Argentina)![]()
Sullo sfondo c'è La Quietad, residenza sontuosa, immersa dentro la pampa argentina. Qui abitano i genitori anziani di Mia e Eugenia, due sorelle profondamente simili, ma che da molti anni vivono separate a causa del trasferimento di quest'ultima a Parigi. L'improvvisa malattia del padre, però, riporta a casa Eugenia che così può nuovamente instaurare il suo speciale e simbiotico rapporto con Mia. In questa loro rinnovata armonia si pongono gelosie reciproche, uomini contesi, bugie e un passato famigliare che forse era meglio tenere celato. Il legame che le unisce è, però, capace di riemergere da tutto questo e consoldiarsi sempre più. La nuova pellicola di Pablo Trapero inizia con un orgasmo condiviso tra le due sorelle e finisce con una maternità divisa a metà sempre tra le due donne. Se il regista avesse indagato maggiormente questa simbiosi morbosa e potenzialmente pericolosa, La Quietud sarebbe stato, forse, un film più convincente. Il regista argentino invece non osa. Spinge, infatti, la sua macchina da presa e la sua penna (è anche infatti lo sceneggiatore) verso il facile racconto di emozioni fortissime, di urla e pianti, di sorrisi e abbracci stucchevoli innestati in dialoghi famigliari infiniti. In più l'aggancio al passato dell'Argentina dei Generali è davvero pretestuoso e superficiale anche se a ben guardare, conferisce almeno un briciolo di dimensione narrativa completamente latente per una buona ora del film. (D.P.)

![]()
L’ultimo film a cui aveva lavorato Orson Welles dal 1970 al 1976, caduto nel dimenticatoio a causa di problemi produttivi, fino alla scoperta di più di mille rulli di pellicola in un deposito di Parigi nel 2017, ed ultimato dal produttore Frank Marshall con l’aiuto di Peter Bogdanovich. Aspettative altissime ben ripagate per uno dei titoli più attesi della Mostra 2018 e della stagione cinematografica. Pur pagando un certo prezzo in termini di disorganicità (il film è stato terminato sulla base di un girato in stato molto avanzato ma disarticolato e di alcuni appunti lasciati dal regista), The Other Side of the Wind sa regalare sprazzi di grande cinema come solo Orson Welles sapeva fare. Al centro del film la figura di un regista di culto che decide di riunire la sua troupe in una villa per mostrare e commentare il suo ultimo lavoro. Una sorta di 8 1/2 wellesiano, dunque, cupo, labirintico, difficile da decifrare in tutte le sue sfumature tra piani narrativi intrecciati (in filigrana emerge una satira del sistema degli studios ancora in voga agli inizi degli anni Settanta), ma tecnicamente ardito e incredibilmente moderno. Uno spettacolo per gli occhi, se si accetta di scendere a patti con la natura di un film che sembra un work in progress a cui un montaggio postumo ha cercato di dare una forma compiuta. Prodotto e distribuito da Netflix. (F.S.)
Fuori Concorso - Non Fiction
 Ni de lian (Your Face), di Tsai Ming-liang (Taiwan)
Ni de lian (Your Face), di Tsai Ming-liang (Taiwan)![]()
Tsai Ming-liang non ve vuole sapere di appendere la macchina da presa al chiodo: dopo aver proclamato l’addio al lungometraggio di finzione con Stray Dogs proprio alcuni anni fa a Venezia, eccolo ritornare per la terza volta al Lido negli ultimi tre anni con un lavoro inclassificabile, né documentario, né cinema di finzione: una camera fissa inquadra in primissimo piano i volti appartenenti a persone comuni (con l’unica eccezione del fido attore Lee Kang-sheng nell’ultima parte), in una galleria di ritratti in chiaroscuro che alterna silenzi e confessioni con alle spalle un’immensa sala vuota appartenente a un edificio di cui avevano preso possesso i gerarchi giapponesi durante l’occupazione. Come nella miglior tradizione del cinema di Tsai, si ripete la magia di un’osservazione entomologica di corpi in uno spazio definito che diventa un magnifico viaggio nello scorrere del tempo e nell’attraversamento di luoghi passati e presenti. L’ultima, splendida inquadratura-piano sequenza (la stanza vuota ripresa con una luce intermittente) mostra quanto ancora questo regista possa dare tanto al cinema e soprattutto al suo pubblico. (F.S.)
Orizzonti Anons (The Announcement), di Mahmut Fazil Coskun (Turchia)
Anons (The Announcement), di Mahmut Fazil Coskun (Turchia)![]()
Turchia, la terra dei golpe. Anno 1963. Insoddisfatti della situazione politica e sociale esistente nel paese, alcuni ufficiali dell’esercito progettano un colpo di Stato per rovesciare il governo di Ankara. Nel frattempo a Istanbul un colonnello ha il compito con altri militari di occupare la stazione radio nazionale e di annunciare formalmente il golpe. Ma non tutto va secondo i piani. Gioca con la storia contemporanea del paese, segnata da colpi di Stato, e i generi il regista turco sorprendendo lo spettatore con un film che parte con toni noir e finisce per assumere un registro farsesco. A rimanere costante è la confezione, la scelta formale di procedere sempre con la camera fissa che riprende quasi sempre i personaggi frontalmente e ritaglia in modo impeccabile l'ambiente nei quali si svolgono i fatti raccontati. Funziona anche grazie alla gestione degli interpreti, a un preciso lavoro di sottrazione nei dialoghi e nelle espressioni che si sposa bene con l'evoluzione della narrazione e la rigorosa messinscena. (F.C.)
Venezia Classici Friedkin Uncut, di Francesco Zippel (Italia)
Friedkin Uncut, di Francesco Zippel (Italia)![]()
Dice che vorrebbe essere ricordato per Il salario della paura, che considera il suo lavoro più importante, ma tutti pensano a lui prima di tutto per L’esorcista. Inizia facendo riferimento al film con il quale ha rivoluzionato l’horror il documentario sul regista di Chicago. Dall’infanzia nella sua città al lavoro per la televisione prima di iniziare la carriera come regista. Un viaggio che parte con The People vs. Paul Crump e arriva sino al più recente The Devil and Father Amorth passando per i suoi capolavori come Il braccio violento della legge. Tante curiosità sui film, sul modo di intendere il mestiere e quello girare. Un maestro celebrato da tanti attori che hanno lavorato con lui, da colleghi della stessa generazione e registi più giovani. Sono numerose le testimonianze (McConaughey, Coppola, Tarantino per citarne solo tre) che arricchiscono questo appassionante ritratto di Friedkin a tutto tondo. Un grande artigiano del cinema, un uomo dai mille interessi, anticonformista e con grande senso dell’ironia. (Fabio Canessa)
 Woman Make Film: A New Road Movie Through Cinema, di Mark Cousins (Parte 1)
Woman Make Film: A New Road Movie Through Cinema, di Mark Cousins (Parte 1)![]()
Una scuola di cinema con insegnanti soltanto donne: ecco un altro grande progetto documentario dell’autore irlandese che percorre una nuova strada nella storia della settima arte, un sentiero tracciato con film diretti esclusivamente da registe. È solo l’inizio quello visto a Venezia, ma il viaggio si presenta subito come qualcosa destinato a lasciare il segno per la capacità di offrire uno sguardo inedito e globale sulla produzione cinematografica al femminile, spesso limitata ai pochi, soliti nomi di registe occidentali affermate. Accanto a quelle più famose, Cousins ci fa conoscere donne di cui anche gran parte dei cinefili non hanno mai sentito parlare. Registe di tutto il mondo, del presente e del passato. Lo fa con un racconto avvincente, una narrazione non enciclopedica e cronologica ma basata sulle grandi domande che pone la realizzazione di un film: come si può girare una sequenza di apertura o si possono presentare i personaggi per limitarsi a due argomenti affrontati in questa primissima parte di un progetto che nella sua interezza si sviluppa per sedici ore. Le risposte arrivano, ovviamente, solo attraverso l’analisi di spezzoni di film diretti da donne. Un lavoro, al quale Cousins ha dedicato anni, che permette di vedere sotto un’altra luce la storia del cinema. (F.C.)
Giornate degli Autori
 José, di Li Cheng (Guatemala)
José, di Li Cheng (Guatemala)![]()
Il giovane José vive con la madre in uno dei paesi più religiosi ma allo stesso tempo più pericolosi e violenti al mondo: il Guatamela. Lavora per un ristorante con il compito di accalappiare clienti lungo la strada e servirli quando consumano i pasti direttamente in auto. Ma ha anche un’altra vita, fatta di incontri occasionali con altri ragazzi perché è omosessuale. Semplice sesso, frettoloso. Finché non incontra Luis, operaio edile più o meno della stessa età, con il quale scoppia la vera passione. La felicità sembra a portata di mano, ma acchiapparla richiede un passo decisivo che José forse non è pronto a fare. Perché non è facile uscire da una vita adagiata sulla rassegnazione, schiacciata da una realtà sociale difficile e anche contraddittoria come quella del paese latino americano dove il machismo, la morale cattolica, la violenza segnano la comunità. Questo sembra voler dire il regista di origini cinesi con questo suo film che funziona come ritratto antropologico, ma non convince tanto nella costruzione narrativa. Nel racconto del percorso del protagonista e delle relazioni con gli altri personaggi, esclusa la madre tutti poco incisivi. (F.C.)
- Mostra del Cinema di Venezia 2018
- Suspiria
- Your Face
- José
- First Man
- The Mountain
- The Sisters Brothers
- La quietud
- Friedkin Uncut
- The Favourite
- Sunset
- What You Gonna Do When the World’s on Fire
- roma
- Doubles vies
- The Ballad of Buster Scruggs
- Acusada
- At Eternity's Gate
- The Other Side of the Wind
- Never Look Away
- Vox Lux
- Woman Make Film: A New Road Movie Through Cinema
- Zan (Killing)
- 22 July
- The Announcement
- Our Time
- CapriRevolution
- The Nightingale