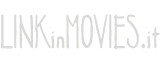Festival di Cannes 2024, promossi e bocciati: guida ai film
- Scritto da Antonio Termenini
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Commenta per primo!
 In occasione del 77esimo Festival di Cannes, ecco i giudizi del nostro inviato ai film visionati nelle varie sezioni. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 12 giorni
In occasione del 77esimo Festival di Cannes, ecco i giudizi del nostro inviato ai film visionati nelle varie sezioni. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 12 giorni
IN CONCORSO
MEGALOPOLIS, di Francis Ford Coppola![]()
L’attesissimo Megalopolis, presentato in concorso al Festival di Cannes, non è un film inutile. Anzi, per molti versi è in perfetta linea con la carriera bigger than life del suo regista, Francis Ford Coppola. E’ proprio nel tentativo, non riuscito, di afferrare tanti temi cruciali dell’esistenza, dal Tempo alla Seduzione, dall’Amore all’Avidità, dal Potere alla Politica, dal senso della Democrazia ai Rapporti famigliari, di afferrare quello che rimane nella vita di uno dei più grandi cineasti degli ultimi sessant’anni, l’aspetto più interessante, affascinante, intrigante di questo film futuristico che però guarda alla vita e al passato, più che al futuro. Ma che inciampa continuamente e non tanto perché tutto il tono è volutamente sopra le righe, caricaturale, a partire da alcuni personaggi, dai riferimenti alla Roma antica, ma perché mancano i tempi giusti, perché alcune parti risultano poco sopportabili per la dilatazione temporale, per l’inutilità quasi compiaciuta di alcune situazioni, perché i personaggi rimangono troppo in superficie e perché lo stesso riflettere sul valore del Tempo, sul valore e significato della Democrazia oggi avrebbe meritato meno superficialità. Coppola si è fatto inghiottire dalla voglia e dal desiderio di raccontare tutto, di afferrare la vita che sta scivolando via. In questo modo, non ha centrato quasi nulla in questo sogno lungo un giorno, o forse, una vita intera.

![]()
Dopo Povere creature, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos è diviso in tre capitoli: stessi attori ed attrici, ruoli diversi, ma assunto e conclusioni non troppo diverse passando dall’inizio alla fine. Nel primo, un uomo di cui non si conosce bene né l’identità né l’impiego vive in perenne sottomissione rispetto ad altro uomo che gli ha dato tutto, soldi, fiducia, persino una moglie. Questa volta, però, decide di ribellarsi. Nel secondo, un poliziotto in crisi di identità soffre per la mancanza della moglie che torna improvvisamente da un’isola deserta. Lui è convinto che non sia la sua vera moglie. Inizia così una pericolosa parabola depressiva e paranoide che metterà a serio rischio tutti i suoi rapporti, con amici, colleghi, familiari. Nel terzo, una donna che ha lasciato il marito e la figlia vuole a tutti costi affidarsi ad un santone che le apra le vie della suprema verità. Alienazione, frustrazione, apparizioni e sparizioni, eccentricità sessuale, (scambismo, rapporti a tre, rapporti di vario genere) sottomissione, potere, manipolazione sono alla base dei tre episodi che rappresentano bene l’ultimo corso del cinema di Lanthimos. Un cinema tutto di testa , cerebrale e volutamente provocatorio nei temi, altamente compiaciuto, autoreferenziale. Ottimo il primo episodio, teso, nervoso, con il ritratto del protagonista che trasmette angoscia, ansia da controllo, paranoia allo stato puro. Buone alcune delle intuizioni del secondo, in particolare ancora il tema dell’allucinazione della quotidianità, riflessa attraverso una serie di filtri mentali. Disastroso il terzo, senza capo né coda, in cui il gusto per l’eccentrico e la narrazione barocca finiscono per collassare come uno dei protagonisti. Un film che piacerà molto ai tanti estimatori del regista greco. Nota di redazione: per approfondire il cinema di Yorgos Lanthimos, ascoltate la puntata del nostro podcast La Luce del Cinema, cliccando qui.

![]()
Ci aspettavamo molto di più da Paul Schrader grande maestro del cinema mondiale che negli ultimi anni si era cimentato alla regia con un’assiduità quasi mai vista nella sua lunga carriera. Leonard Fife, grande documentarista, aggredito da una severa forma di cancro sta morendo. Una troupe lo vuole intervistare per l’ultima volta. L’espediente narrativo consente a Schrader una carrellata nel tempo, dagli anni in cui Fife inizia la sua carriera di documentarista, dalle proteste nei confronti della guerra del Vietnam alle innumerevoli storie d’amore occasionali con donne molte diverse, per estrazione sociale e per età. Fino ad Emma (Uma Thurman) che lo accompagnerà sul letto di morte, ma che sarà anche la produttrice di molti suoi documentari. Oh, Canada rimbalza da un’epoca all’altra per ritrarre un’anticonformista, un ribelle, refrattario alle regole, di qualsiasi tipo, che vede nel Canada una terra di libertà. Di espressione, ma che di libertà di opinione. E che non teme, anche davanti ad una camera che ne raccoglie le ultime confessioni e le ultime ore di vita, di raccontare anche gli amori controversi e quelli rifiutati. Schrader rimane però nella superficie ed il film apprezzabile nel suo complesso, è un po’ troppo compassato, “diligente” e di maniera. Senza sussulti. Nota di redazione: per approfondire il cinema di Paul Schrader, ascoltate la puntata del nostro podcast La Luce del Cinema, cliccando qui.

![]()
Dopo sei anni di assenza, Jia Zhang-ke torna a dirigere un film, Caught By The Tides. Un film in Cina, sulla Cina. Con una prima parte che spiazza perché senza filo conduttore, completamente franta in mille frammenti. Da una Cina, come il personaggio interpretato da Zhao Tao, stordita, dall’assenza di punti di riferimento (quel quadro di Mao a cui non si riesce a trovare una collocazione), dalla vittoria per l’assegnazione delle Olimpiadi di Pechino 2008, dalle prime discoteche, dall’ingresso nel WTO, dall’arrivo della modernizzazione. Si passa poi al 2006, alle prime grandi opere infrastrutturali, ma anche alle condanne per corruzione, alle speculazioni. Qiaoqiao e Bin, che la donna rincorre in un viaggio a ritroso che diventa sempre più dolente, è stordita, frastornata, ma è anche testimone di quanto accade. Anche della pandemia da Covid 19 che sconvolge usi ed abitudini. Jia in questo suo ultimo film non prosegue in quello stile nervoso, in quell’estetica iperrealista, mutuata in parte dal miglior cinema di Hong Kong ma neppure ritorna al realismo rigoroso di Pickpocket, di Still life. Cerca una terza via, affascinante, a volte disorientata e disorientante ma proprio perché la Cina di oggi è esattamente così. Nota di redazione: per approfondire il cinema di Jia Zhang-ke, ascoltate la puntata del nostro podcast La Luce del Cinema, cliccando qui.

![]()
Attendavamo molto Emilia Perez, ultima fatica di Jacques Audiard, uno dei migliori cineasti contemporanei. Abbiamo amato anche il sottovalutato e passato qui in sordina Les Olympiades vibrante ritratto di una Parigi multietnica. Eppure facciamo davvero fatica a difendere Emilia Perez, ritratto di un leader dei narcotraffico messicano Manitas che vuole diventare donna anche per sottrarsi alla stretta soffocante di sangue e violenza che ha creato. Lo aiuterà l’avvocato Rita, abile, astuta, rapida nel mutare identità, posizione, nel porsi da mediatrice non solo per la vita pubblica di Manitas/Emilia, ma anche tra lui/lei, la moglie (interpretata da una sorprendente Selena Gomez) e i figli dirottati per un periodo a Losanna. Londra, Bangkok, Tel Aviv, Mexico City. Il film di Audiard si nutre, bulimicamente di tante location, personaggi, situazioni narrative, in un’esuberanza e frenesia (a partire dalle parti musical) che sicuramente non lascia indifferenti che ma trasmettono un’incapacità di fare sintesi. A tratti emoziona, ma non conquista mai, teso in una parabola dove dannazione e santità vanno di pari passo. Manitas/Emilia Perez è un personaggio bigger than life che prima decima sanguinosamente i sui avversari, poi sente il rimorso e fonda una ONG per aiutare le decine di migliaia di desaperecidos sparsi nel paese.

![]()
Materia su cui era facilissimo scivolare. Male. Perché The Apprentice di Ali Abbasi è la biografia del “primo” Donald Trump, quello meno conosciuto dal grande pubblico. Il film abbraccia un arco temporale che va dal impeachment di Nixon nel 1974 fino ai primi anni ’90 quando viene scritta la prima celebre biografia trumpiana, “The art of the deal”: E quindi, il rapporto con il padre, il costruttore Fred, con il fratello maggiore che poi morirà, l’ascesa nel mondo del real estate newyorkese, la Trump Tower, il flop ad Atlantic City, l’amore per Ivana. Ma soprattutto, il rapporto con l’avvocato Roy Cohn, celebre difensore dei Rosenberg e di altri personaggi famosi come Bloomberg. Cohn è uno dei mentori di Trump, se non il vero ispiratore di tutti i suoi primi traguardi. Lo inizia alle trattative politiche, necessarie per ogni deal nel real estate, ma è anche maestro di vita, dalla relazione con Ivana, a come porsi nei confronti di amici ed avversari. The Apprentice nome del celebre contesto televisivo ideato da Trump per la NBC negli anni ’90, ricostruisce con meticolosità quel mondo, la New York degli anni ’80 con una fotografia sporca, che restituisce bene atmosfere ed ambienti dell’epoca. Era facile cadere nella retorica, nella caricatura, nel ritratto di un mostro senza cuore che distruggerà il mondo e metterà a repentaglio le sue sorti. Il Trump di Abbasi non è altro invece che uno dei tanti tycoon di epoche più o meno recenti; grezzo, con manie di grandezza, lontano da qualsiasi tipo di mediazione e di compromesso, sempre alla ricerca di un’assoluta gloria. Abbasi cerca di conciliare la medietà del tono con le manie di grandezza del personaggio, la megalomania con la quotidianità. E ci riesce in modo esemplare, proprio perché il cuore del film è nel rapporto tra Trump e Cohn. Due facce della stessa medaglia, due uomini pronti a tutto pur di raggiungere i propri obbiettivi, ma anche due figure fragili, deboli, attaccabili.

![]()
Thierry Fremaux ha voluto dimostrare che anche il concorso del Festival di Cannes può ospitare un horror, un horror puro, che non teme di ricorrere a tutti gli ingredienti del genere. The Substance della regista Coralie Fargeat è quindi horror puro con vari riferimenti a Cronenberg, forse Kubrick e anche come ha detto la regista stessa in conferenza stampa, a Paul Verhoveen. Ma è soprattutto un forte atto d’accusa nei confronti della dittatura del corpo e dell’apparenza come unica forma di riconoscimento per una donna dello spettacolo. Elizabeth Sparkle è ritenuta troppo “vecchia” per poter continuare negli show che l’hanno resa famosa. Viena attirata della mirabolante offerta di una sostanza che possa mostrare “il miglior lato di sé”. La decisione si rivela un incubo. Il suo clone giovane, Sue, non riesce a controllare le trasformazioni che esigono sempre un bilanciamento, ed il piano perfetto frana rovinosamente. La giovane regista non si trae indietro nel mostrare corpi, e la loro progressiva mutazione, sangue, e si sbilancia volutamente in un tono narrativo e in scelte estetiche iperrealiste e sopra le righe. Il suo è un film manifesto, femminista e radicale. Non sempre i meccanismi dell’horror sono dosati al punto giusto, e l’atto d0accusa può risultare spesso prevedibile e anche fastidioso. Un film comunque divertente e ben interpretato che divertirà gli spettatori.
PARTHENOPE, di Paolo Sorrentino
![]()
Parthenope nasce nel 1950, in mare, contemporaneamente all’arrivo di una carrozza, accompagnata da un capitano. Cresce in una famiglia borghese, attira su dì sé tutte le attenzioni. Semplicemente perché è bella, attraente, sfuggente, scostante, riflessiva, intellettuale. La prima parte di Parthenope, decimo lungometraggio di Paolo Sorrentino è questo, l’osservazione della bellezza un po’ come aveva fatto Bernardo Bertolucci quasi trent’anni fa con Io ballo da sola che ruotava attorno al corpo e alla personalità di Liv Tyler. Ma Parthenope, evidentemente rappresenta qualcosa di più, una città che pulsa, che vibra, che vive anche nei suoi sotterranei, in un rapporto di osmosi con i suoi cittadini. Sempre nella prima parte Sorrentino inserisce alcuni personaggi inutili, in particolare lo scrittore americano depresso interpretato da Gary Oldman e alcuni frequentatori delle feste della costa amalfitana. Nella seconda parte il regista abbandona i toni da estetismo felliniano per abbracciare un passo più sentito, empatico. Abbraccia i suoi personaggi, il professore di antropologia che spingerà Parthenope alle scelte decisive della vita e il vescovo di Napoli, inebriato dalla bellezza pura della ragazza, come si trattasse di una reliquia religiosa pulsante. Gli ultimi quaranta minuti del film sono sublimi in un crescendo di consapevolezza, struggimento, nostos, passione ma allo stesso tempo malinconia per quello che è stato e non sarà mai più. Nota di redazione: per approfondire il cinema di Paolo Sorrentino, ascoltate la puntata del nostro podcast La Luce del Cinema, cliccando qui.

![]()
Come ha scritto qualcuno, il guilty pleasure del festival. Secondo molti il peggior film del concorso. Eppure, il caotico, da tutti i punti di vista, narrativo, estetico, produttivo, film di Gilles Lellouche, intriga, affascina, nonostante le sue quasi tre ore. Questo romanzo criminale inizia con la storia d’amore, all’inizio degli anni Ottanta tra Clotaire e Jacqualine, entrambi provenienti da famiglie disfunzionali, il primo nato e cresciuto nella violenza, tra soprusi e prevaricazioni, la seconda senza una madre. Un amore sognato, puro, senza mediazioni. Come senza mediazioni è lo stile scelto per raccontarla da Lellouche. Piani sequenza, esplosioni improvvise di violenza, dialoghi da sitcom, di tutto e di più anche quando l’azione, dopo i tredici anni di carcere scontati da Cretien si sposta quasi ai giorni nostri. Cretien rimane perennemente attratto dalla violenza e dal pericolo; è la sua risposta a quanto la vita gli ha sottratto. E anche Jacqualine non riesce a fare a meno di lui. A costo della sua personale incolumità. Un film con grandi potenziali in parte mancate che non merita comunque il rifiuto della critica internazionale.
THE SHOURDS, di David Cronenberg
![]()
Così si può dire di questo ultimo Cronenberg? The Shrouds dovrebbe ragionare sulla perdita, sulla morte, sui simulacri della morte. Sulla (ancora) mutazione del corpo. Karsh ha infatti perso la moglie a causa di una brutta firma di tumore. Per ricordarla, ma anche per allontanare il dolore dà vita a nuove forme di tumulazione. Che diventa un business chiamato Grave tech. Confuso, bolso come il suo protagonista Vincent Cassel, The Shrouds si avvita continuamente su sé stesso, con personaggi che scompaiono e riappaiono senza alcuna motivazione, con improbabili hacker cinesi e russi che dovrebbero contendersi il nuovo business. E con Karsh che si consola tra la sorella della moglie, un architetto ungherese ed un’ologramma creato dall’intelligenza artificiale. Dove è finito il cinema di Cronenberg, le sue provocazioni intellettuali? Le riflessioni sulle mutazioni del corpo? Qui solo infiniti dialoghi (scritti anche male) ed una noia mortale. Imbarazzante.

![]()
Bailey è una ragazza di dodici anni che vive nel nord del Kent al quale il padre dedica poche attenzioni. Bailey cerca di vendicarsi, ritagliandosi una propria autonomia, passando tempo con gli amici, sfuggendo a qualsiasi tipo di controllo. Chi avesse visto altri film di Andre Arnold, da Red Road a Fish Tank sa cosa aspettarsi; impegno sociale, realismo a tratti magico o comunque filtrato dagli occhi di un adolescente e distante anni luce dalla lezione di Ken Loach. Bird è quindi un film immediatamente riconoscibile fin dalle prime inquadrature, dai primi dialoghi, con quello slang che può apparire incomprensibile, con la macchina a mano che pedina Bailey e altri adolescenti in un contesto urbano degradato, marginale, per certi versi senza speranza. Sicuramente non un film originale, ma altrettanto sicuramente sincero. Nelle intenzioni e nei risultati, pur con molti limiti.

![]()
Miguel Gomes è uno dei grandi cineasti contemporanei. Finalmente riconosciuti anche in un festival come Cannes. Il suo Grand Tour è anche l’immaginifico tour di Edward, funzionario della Birmania coloniale britannica che il giorno del matrimonio con Molly sparisce per un tour appunto, che lo porta nelle grandi città dell’Estremo Oriente da Osaka a Saigon, da Shanghai a Bangkok. Un viaggio della mente, in barca, in nave. Un viaggio con contorni indefiniti, un viaggio dell’animo, rapsodico, senza margini. Un viaggio dove Gomes sprigiona tutto il suo talento visionario, lisergico, rapsodico. Grand Tour non concede mediazioni, mezzi toni. La sua enciclopedica narrazione fuori campo o la si ama o la si rifiuta. Amiamo il cinema di Miguel Gomes.
UN CERTAIN REGARD

![]()
La storia di My Sunshine è ambientata in un'isola a nord del Giappone, un luogo dove il tempo scorre lentamente e la vita degli abitanti, così come le loro attività, è scandita dal susseguirsi delle stagioni. Qui vive Takuya, un ragazzino piuttosto timido ma vivace che, come tutti i suoi coetanei, passa da uno sport all'altro e, con il giungere della prima neve che sancisce l'incedere dell'inverno, ecco che arriva il momento per l'hockey. Il giovane, al contrario dei suoi compagni, non ha molto interesse per questo sport e, svogliato, partecipa alle partite e agli allenamenti quotidiani. Un giorno, però, rimane affascinato da Sakura, una ragazzina che si allena nel pattinaggio artistico. I movimenti leggeri, le giravolte e le coreografie lo conquistano e così, mentre prova a replicare quelle mosse, fa la conoscenza dell'allenatore della pattinatrice, il coach Arakawa che, toccato dalla passione che Takuya mette nel pattinaggio, decide di allenarlo per farlo gareggiare in coppia con Sakura. Nel raccontare tutto questo Okuyama sceglie di non andare troppo a fondo, approcciando alle vite dei protagonisti in punta di piedi: racconta i fatti dal punto di vista dello spettatore lasciando a lui l'interpretazione dei comportamenti e delle espressioni dei personaggi. Nell'optare per questo approccio poco invasivo però, lascia la storia la se stessa: avremmo preferito conoscere di più del passato e delle vicende di Arakawa per partecipare ed empatizzare con il suo sentire, i suoi timori e disillusioni.

![]()
In festival come quello di Cannes capita di imbattersi in sorprese vere e proprie, gradite, inaspettate perché si possono scoprire nuovi talenti che diventeranno poi i nomi del cinema del futuro. September Says è uno di quei casi. Piccolo film, sostenuto dalla BBC, diretto da Ariene Labed, September Says racconta la storia di due sorelle, September e July, scontrose, asociali, introverse, con un carattere spigoloso che viene anche dalle traversie della single mother Sheela che le cresce come può, con mezzi economici limitati. Tra le due scorre una latente tensione, un’incapacità ad amalgamarsi con altre ragazze e ragazzi della loro età, a rapportarsi con la sessualità. Spesso la violenza irrompe come momento di naturale evoluzione di questa tensione. La tragedia è sempre dietro l’angolo e potrebbe esplodere da un momento all’altro. Labed opta per un realismo cupo, che vira in ambientazioni sinistre e questo esordio dove il sottotesto è così importante ricorda la radicalità di Sweetie di Jane Campion che proprio a Cannes, in concorso, fece scalpore per i suoi contenuti ritenuti estremi.
VIET AND NAM, di Troung Minh Quý
![]()
Titolo profetico quello scelto daTroung Minh Quý per il suo film d’esordio. I due protagonisti sono due minatori, abituati ad una vita oscura, sottoterra, nascosta, esposta al pericolo, dove le notizie, anche quelle epocali (l’attacco alle Torri Gemelle a New York l’11 settembre) filtrano solo grazie al passaparola. Viet e Nam si amano, in modo altrettanto oscuro e nascosto ovviamente. La vicenda è ambientata agli inizi degli anni Duemila, in un paese, il Vietnam, ancora fortemente arretrato, rurale, lontano dal mirabolante progresso che l’ha conosciuto nei decenni successivi. Il padre di Nam è un ex soldato che ha combattuto la guerra con gli Stati Uniti. Tutte le sue conversazioni sono incentrate su quell’argomento, dal ricordo agli incubi degli attacchi, delle trappole del nemico, fino alla visita ai monumenti che ricordano il conflitto. Con un padre bloccato nel passato, Nam è invece proiettato ad un futuro con il suo amante. Un’unione che al di là delle tradizionali difficoltà, sconta anche problemi legati ai confini che i due vorrebbero attraversare, lasciando per sempre la Terra da cui provengono. Il regista rifugge un facile sentimentalismo optando per una messa in scena rigorosa, anche ostica per lo spettatore filtrando le sensazioni provate dai due protagonisti.

![]()
In un ventoso villaggio somalo, un padre un figlio piccolo ed una comunità ristretta ma ricca di contraddizioni cerca di sopravvivere. E quanto racconta Mo Arawe in questo suo film d’esordio, teso, dolente, che restituisce ansie tensioni, paure, angosce di esseri umani lasciati al loro destino, che tentano di sopravvivere come possono, chi, come il protagonista, assicurando una degna sepoltura a quanti muoiono attaccati dal lancio dei droni verso una popolazione inerme, musulmana, ritenuta un pericolo per l’occidente e per gli equilibri dell’area africana. Scarno, essenziale, straziante per le conclusioni a cui arriva in un territorio aspro ed insidioso.
NIKI, di Céline Sallette
![]()
Céline Sallette, attrice francese nota al pubblico del suo paese per alcune interpretazioni, racconta nel suo film d’esordio, Niki, la storia dell’artista omonima che negli anni Cinquanta era salita alla ribalta della cronaca per l’originalità delle sue opere, per l matrimonio con uno scrittore americano e per i suoi ripetuti ricoveri in ospedali psichiatrici. Niki ha subito una terribile violenza da parte del padre quando era ancora adolescente e questo segnerà la sua esistenza per sempre. Biopic corretto, senza sbavature, senza colpi d’ala, ben recitato.
QUINZAINE DES CINÉASTES
DESERT OF NAMIBIA, di Yôko Yamanaka
![]()
Yôko Yamanaka è una giovane regista giapponese, al suo secondo lungometraggio. Desert of Namibia, presentato alla Quinzaine dea cinéastes segue le tribolazioni della poco più che ventenne Kana, indecisa tra una relazione amorosa e l’altra, ribelle, oggetto del desiderio per la sua bellezza algida e sfuggente ma che fatica a trovare il suo posto in una società troppo complessa e stratificata per poterla assorbire fino in fondo. Yamamaka pedina da vicino Kana, dal suo lavoro in un centro di depilazioni, alle sue notti nei club, dalla profonda depressione in cui cade in seguito ad un improvviso aborto fino alle travagliate relazioni con due fidanzati. Si conosce la capacità del cinema giapponese di raccontare l’adolescenza, i suoi traumi, le disfunzioni, le esplosioni di gioia, amore, erotismo, ma anche le paure, le ansie, l’angoscia per il futuro. Yamamaka ci riesce solo in parte, a tratti. Alcune parti del suo film catturano l’essenza del carattere di Kana, il milieu che la circonda, ma si dilunga troppo nella quasi due ore e mezza di durata, con dialoghi spesso inutili, con una narrazione che ripete episodi senza l’urgenza della necessità.

![]()
In una remota area montuosa di Taiwan, l’immigrato clandestino thailandese Oom lavora come cargiver per disabili. Si occupa anche di altri immigrati clandestini, filippini e del sud est asiatico per garantire loro una vita dignitosa. Il giovane regista Chiang Wei Liang ha dedicato tutta la sua carriera al tema dei disabili e degli immigrati clandestini, a partire dai suoi cortometraggi fino a questo film d’esordio. Film molto lento, che può ricordare l’osservazione del reale e del dolore di Hou Hsiao-hsien e, più in generale, della new wave taiwanese degli anni Ottanta e Novanta, ma in realtà si impantana sin dall’inizio in una serie di luoghi comuni sia sul tema della disabilità che su quello dell’immigrazione. I suoi personaggi sono ombre poste al confine tra legalità ed illegalità tra dolore e compassione.
SEMAINE DE LA CRITIQUE
LOCUST, di Keff
![]()
Nel presentare la sua opera d’esordio alla Semaine de la critique, Keff, regista esordiente di Taiwan, ha sottolineato diverse volte come il suo Locust sia un film su Taiwan fatto da taiwanesi. Una frase manifesto per un film che infatti non contempla mai le mezze misure. Racconta le vicende del ventenne Zhong Han che di giorno lavora in una piccolo food store ma che di notte si accompagna a pericolosi gangster che metteranno a repentaglio le sua relazione sentimentale con una ragazza e con i gestori stesso del food store. Keff realizza un film militante che dipinge la realtà taiwanese sull’orlo del collasso, non solo per le continue ingerenze cinesi sull’sola, ma anche a causa di un’economia decadente, di una politica sempre più corrotta e sempre meno attento ai bisogni dei cittadini. Simpatizza con i movimenti di protesta di Hong Kong, facendo intendere che a breve sarà proprio il turno di Taiwan nel perdere la propria libertà ed autonomia. Nessun mezzo tono, nessuna sfumatura, tanta retorica, luoghi comuni nella descrizione dei personaggi e dei luoghi che li circondano. Anche la faida tra le contrapposte bande di gangster rimane solo confusa e piena di zone d’ombra. Un’opera prima ingenua che beneficia unicamente di una bella colonna sonora e di alcune ambientazioni di buon impatto visivo.

![]()
Julie gioca bene a tennis, è disciplinata, una brava studentessa in una scuola esclusiva in Belgio. L’accademia per cui si allena e gioca viene improvvisamente colpita da un lutto: una giovane giocatrice altrettanto promettente si toglie improvvisamente la vita. Ombre iniziano ad accerchiare l’allenatore Jeremy che allena anche Julie. La ragazza perde la serenità, litiga con le compagne, è meno motivata in allenamento e a scuola. Forse nasconde un segreto proprio sulla morte della giovane amica. Interessante vedere Julie keeps quite nello stesso periodo di Challengers di Luca Guadagnino. Come là, anche qui il tennis è un pretesto per raccontare la solitudine di tanti adolescenti nell’era post covid e per continuare in modo discreto i temi cari al movimento #metoo.
CANNES PREMIERE

![]()
Rithy Pahn prosegue la dolorosa indagine nel passato tormentato del suo paese, la Cambogia, con un capitolo di grande interesse, Rendez vous avec Pol Pot, di grande interesse perché unisce documentario e fiction in una vicenda del 1978 che porta all’attenzione l’inchiesta di tre reporter francesi (uno dei quali ha studiato a Parigi proprio con Pol Pot) nel tentativo di capire quanto sta accadendo veramente in quel paese, cosa significa la rivoluzione khmer, cosa si cela dietro al mistero di Brother N.1. Rithy Panh, allontanandosi anche da quel leggero manicheismo e dal semplicismo di alcune sue opere che si limitavano a condannare la strage dei khmer rossi e il loro regine, con questa sua ultima opera, proprio nell’incontro ravvicinato con il leader carismatico, tenta di andare alle radici della violenza, della follia, della dittatura, articolata e spiegata proprio da Pol Pot. Altrettanto incisivo il ritratto femminile della reporter giornalista interpretata da Irene Jacob, la più ribelle dei tre, che con le sue domande scomode spesso mette in difficoltà la vulgata del regime e chi la racconta.
SPECIAL SCREENINGS
SPECTATEURS!, di Arnaud Desplechin
![]()
Arnaud Desplechin fa grande cinema ma è anche un grande amante del cinema, com’è nella migliore tradizione della nouvelle vague francese di cui è degno erede. Spectateurs! non è né documentario né fiction. E’ un atto d’amore, incondizionato, nei confronti del cinema, della sala cinematografica. Un amore che filtra attraverso carrellate nella Storia del Cinema, interviste, testimonianze di spettatori, registi, cinefili. Il cinema come pratica di vita, la sala cinematografica come luogo sacro., come luogo di culto, dove consumare le prime infatuazioni amorose, dove battersi per un autore, per un film. Un’opera appassionata questa di Despleschin, dove il regista francese abbandona, per una volta, un certo cerebralismo, per affidarsi ad un sentimento di amore incondizionato.
- Festival di Cannes 2024
- Megalopolis
- Francis Ford Coppola
- Keff
- Rithy Panh
- Yorgos Lanthimos
- kinds ok kindness
- Paul Schrader
- oh canada
- andre arnold
- yoko yamanaka
- Jacques Audiard
- Jia Zhangke
- Ali Abbasi
- The apprentice
- Coralie Fargeat
- Chiang Wei Liang
- David Cronenberg
- paolo sorrentino
- Parthenope
- Hiroshi Okuyama
- Mo Arawe
- Ariane Labed
- Miguel Gomes
- Troung Minh Quy
- Celine Sallette
- Leonardo Van Dijl
- Arnaud Desplechin
- Gilles lellouche