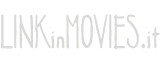Festa del Cinema di Roma 2017: la nostra guida ai film
- Scritto da Francesco Siciliano, Massimo Volpe
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Commenta per primo!
 In occasione della Festa del Cinema di Roma, ecco i giudizi degli inviati a tutti i film visionati alla 12esima edizione. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 11 giorni
In occasione della Festa del Cinema di Roma, ecco i giudizi degli inviati a tutti i film visionati alla 12esima edizione. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 11 giorni
Selezione ufficiale
 Hostiles, di Scott Cooper (Stati Uniti)
Hostiles, di Scott Cooper (Stati Uniti)![]()
Film scelto per aprire la dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (ex Festival), Hostiles di Scott Cooper delimita da subito quelli che sono i contorni della rassegna diretta da Antonio Monda: il lavoro del regista americano de Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace è un western atipico travestito da epopea e ricco di una epicità ben poco sostanziale ma dai sicuri connotati che avviluppano il pubblico. Attraverso il racconto del viaggio intrapreso dal capitano Joe, eroe delle sanguinose guerre contro le tribù indiane ed ora ridimensionato nel ruolo di cacciatore di indiani recalcitranti a rimanere nelle riserve, dal New Mexico al Montana come scorta per un vecchio capo indiano moribondo che fu uno dei suoi più veri avversari, riportato a casa per morire nella sua terra, Scott ci offre la sua versione più cruda degli ultimi anni del XIX secolo. Accettato l’incarico con grande tormento personale, il lungo viaggio diventa un rapido e repentino processo di catarsi e redenzione all’insegna dell’integrazione tra nativi e bianchi. Raccontato in maniera piuttosto cruenta ponendo almeno all’inizio al centro del racconto la figura del capitano ormai sul viale del tramonto e dei suoi commilitoni ex eroi di una sporchissima guerra, con l’aggregarsi al gruppo di viaggiatori di una giovane donna scampata al massacro della sua famiglia da parte degli indiani, ben presto Hostiles cede il passo al racconto che con una certa fretta e con ben poca convinzione trasforma i protagonisti di una guerra feroce in antesignani della tolleranza e della convivenza. Western crepuscolare quindi che, tranne in rarissime occasioni, evita con cura i capisaldi del genere classico per diventare, ahimè, la consueta ricerca della catarsi di una civiltà (quella americana) di fronte ad una delle sue pagine storiche più oscure. Ben fotografato, con momenti senza dubbio affascinanti anche grazie alla prova degli attori protagonisti (Christian Bale e Rosamund Pike) Hostiles è lavoro che piacerà al grande pubblico: a noi francamente è sembrato più uno degli innumerevoli tentativi di affrontare un passato collettivo che pesa sulla storia degli States, un film che tralascia un po’ troppo colpevolmente lo sviluppo più puramente cinematografico e narrativo della storia. (Massimo Volpe)
 Detroit, di Kathryn Bigelow (Stati Uniti)
Detroit, di Kathryn Bigelow (Stati Uniti)![]()
Detroit, estate del 1967. La città è sconvolta da una sanguinosa rivolta della comunità afroamericana che decide di mettere a ferro e fuoco le strade per ribellarsi allo stato di emarginazione a cui le istituzioni sembrano averla condannata e ai continui soprusi subiti dalle forze dell’ordine. Saccheggi, edifici in fiamme, sparatorie, uccisioni sono all’ordine del giorno in una città sprofondata nel caos. È in questo clima da guerra civile che un gruppo di adolescenti afroamericani in compagnia di due ragazze bianche si troverà a vivere sulla proprie pelle la tragedia di quella sanguinosa estate. Kathryn Bigelow riporta indietro le lancette dell’orologio raccontando il massacro dell’Algiers Motel, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, quando la polizia di Detroit abusò del proprio potere per estorcere informazioni sulla possibile presenza di un sovversivo all’interno della struttura, compiendo violenze fisiche e psicologiche, finendo per uccidere a bruciapelo tre ragazzi di colore che si trovavano lì solo per passare una bella serata. Lo sguardo della regista inquadra il passato ma è rivolto all’oggi (all’escalation degli ultimi anni di neri uccisi dalle forze dell’ordine), ma senza la tentazione di trasformare il film in un mero manifesto politico: mescolando materiale d’archivio e finzione cinematografica, Detroit funziona non solo per la sua denuncia ma anche e soprattutto come film di grande presa emotiva. Quasi due ore e mezza senza tregua, immersive, angoscianti in cui la Bigelow dosa sapientemente la tensione ritagliandosi uno spazio per assestare un duro colpo alla coscienza smarrita dell’America (nessuno dei poliziotti pagherà mai per i crimini commessi). Tutto terribilmente vero, tanto che nei momenti di maggior violenza verrebbe voglia di distogliere lo sguardo dallo schermo. (Francesco Siciliano) Stronger, di David Gordon Green (Stati Uniti)
Stronger, di David Gordon Green (Stati Uniti)![]()
David Gordon Green è uno tra i registi più schizofrenici ed altalenanti del panorama americano: nella sua carriera di regista ha alternato commedie per il box office (titoli non proprio memorabili come Strafumati, Lo Spaventapassere, Sua Maestà) a lavori più personali focalizzati sullo studio degli outsider (pensiamo a George Washington, Joe, Manglehorn). Purtroppo la sua ultima fatica Stronger cede alle lusinghe di Hollywood: pur senza abbandonare una certa predilezione per i personaggi alla ricerca di un riscatto, il regista confeziona il classico biopic a stelle e strisce che ha i connotati del film da Oscar per il grande pubblico. Una storia vera (quella del giovane Jeff Bauman e della sua difficoltosa riabilitazione dopo aver perso le gambe nell’attentato terroristico alla maratona di Boston nel 2013), un personaggio in cui specchiarsi da eleggere a simbolo di forza e speranza di fronte alle avversità del nostro tempo, un’interpretazione da manuale dell’Actor’s Studio (Jake Gyllenhaal in una prova di incredibile immedesimazione), una messa in scena che non si vergogna di commuovere: nessuna sbavatura, tutto procede sui binari di un calvario scandito da una collaudata enfasi drammatica. Anche se alla fine non si può restare del tutto indifferenti dinanzi alla parabola di un uomo che cerca di riprendersi da un’immane tragedia, resta forte l’impressione che il film cerchi la lacrima facile e non abbia il coraggio di esplorare strade meno battute nell’approccio e nell’analisi di un percorso di rinascita. (F.S.) Cuernavaca, di Alejandro Andrade Pease (Messico)
Cuernavaca, di Alejandro Andrade Pease (Messico) ![]()
In seguito all’uccisione della madre davanti ai suoi occhi durante una rapina in una tavola calda, il piccolo Andy si ritrova senza nessuno che possa prendersi cura di lui. Il padre che si era allontanato da lui dopo il divorzio dalla madre non è rintracciabile e così al bambino non rimane altra scelta che quella di trasferirsi nella casa della nonna paterna, una signora dell’alta borghesia messicana che manda avanti con ferreo piglio matriarcale una villa immersa in un podere, la quale vorrebbe sbarazzarsi presto del nipote per mandarlo in Canada a vivere con la sorella del padre. Spaesato e ancora traumatizzato dalla perdita della madre, Andy cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con il padre, l’unica persona che vorrebbe avere al suo fianco in un momento così difficile della sua vita. Al suo primo film, Alejandro Andrade Pease porta sullo schermo un dramma ad altezza di bambino attraverso cui osservare lo sfaldarsi di una famiglia soggiogata da una matriarca, una sorta di allegoria di una borghesia messicana rinchiusa nel suo piccolo mondo e incurante dell’inquietudine che la circonda. La storia e i personaggi non hanno un vero sviluppo narrativo e le situazioni sembrano tagliate con l’accetta. Succede poco o nulla durante la visione e alla fine dei conti il film non riesce a incidere né come dramma infantile né come sguardo sulla società messicana dilaniata da forti contrasti. (F.S.) Logan Lucky, di Steven Soderbergh (Stati Uniti)
Logan Lucky, di Steven Soderbergh (Stati Uniti)![]()
Chi si aspetta il brio, l’ironia e l’eleganza della saga di Ocean’s resterà un po’ deluso. L’ultima fatica dal redivivo Steven Soderbergh (che aveva annunciato l’addio alla macchina da presa) segna l’atteso ritorno del regista agli heist-movie (i film che ruotano attorno a una rapina), strizzando l’occhio – anche direttamente in maniera autoreferenziale – al fortunato trittico con protagonista George Clooney. Se la saga di Ocean’s era un gioco di prestigio in mano a un regista in stato di grazia, un divertissement che era puro piacere della visione, Logan Lucky è tutto il contrario, appesantito com’è da una storia troppo aggrovigliata da situazioni ad incastro che risultano inverosimili, da uno humour scontato nelle sue derive grottesche e da una regia scolastica nelle fasi salienti della rapina al centro del racconto, ordita da un manipolo di outsider capitanati da una ex promessa del football che decide di riprendersi la sua rivincita su una vita di fallimenti (l’uomo è divorziato e disoccupato) portando via i guadagni delle attività commerciali di un enorme circuito motoristico dal caveau dove vengono conservati gli incassi della giornata, durante una delle competizioni più importanti dell’anno. Anche il team all star di rapinatori protagonisti (Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig) non riesce a eguagliare la splendida alchimia della comitiva di Ocean’s formata da Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Peccato. (F.S.) And Then There Was a Light (Hikari), di Tatsushi Omori (Giappone)
And Then There Was a Light (Hikari), di Tatsushi Omori (Giappone)![]()
Nobuyuki, Mika e Tasuku sono tre amici scampati alla furia di uno tsunami che ha devastato la loro terra natia, Mihama, un’isola al largo della costa di Tokyo, quando erano adolescenti. A distanza di venticinque anni da quell’evento tragico le loro vite da adulti hanno preso strade diverse: Mika è diventata una famosa attrice, Nobuyuki un impiegato comunale sposato con una donna infedele da cui ha avuto una bambina e Tasuku un operaio che sbarca il lunario con lavori saltuari per evitare l’assoluta indigenza. Il loro passato che si porta dietro cicatrici che non si sono mai rimarginate, torna a galla quando Tasuku, con la complicità del padre, un alcolizzato che abusa di lui fin da quando era piccolo, decide di ricattare Nobuyuki e Mika per un vecchio fatto di sangue di cui i due amici sono stati artefici quando avevano una relazione ai tempi in cui vivevano a Mihama. Portando sullo schermo per la terza volta un’opera letteraria della scrittrice Shion Miura, Tatsushi Omori continua il suo personalissimo percorso di esplorazione dei rapporti di reciproca dipendenza che si instaurano tra le persone. Non siamo ai livelli del precedente A Crowd of Three, altro film che come And Then There Was a Light metteva in scena la subalternità di due ragazzi e una ragazza, ma ci troviamo di fronte comunque a un lavoro non convenzionale nel linguaggio, estremo, oscuro che guarda al cuore di tenebra di un’umanità che deve fare i conti con pulsioni estreme dietro una facciata di rispettabilità. Omori esagera nel mescolare troppi piani narrativi che non raggiungono quasi mai una sintesi compiuta e nelle troppe metafore nascoste a briglia sciolta, ma è innegabile il fascino dell’uso che fa del regista dello sguardo sulla natura come cassa di risonanza dei sentimenti più nascosti dei personaggi. Tutto sommato il film è una piacevole 'scheggia impazzita' nella prevedibilità di una selezione che da troppi anni premia il convenzionale e il consolatorio. (F.S.) Birds Without Names, di Kazuya Shiraishi (Giappone)
Birds Without Names, di Kazuya Shiraishi (Giappone)![]()
Towako è una ragazza che condivide il suo appartamento con Jinji, un uomo 15 anni più grande di lei. Tra i due si è instaurato un rapporto ambiguo in cui l’uomo sembra avere il compito di proteggere in maniera ossessiva la donna. Non sono una vera coppia, anzi lei detesta l’uomo che in effetti brilla per rozzezza e goffaggine, ma soprattutto Towako, che sembra un po’ il prototipo della donna scontrosa sempre sull’orlo di una crisi isterica, vive ancora dei ricordi della sua storia d’amore con Kurosaki, terminata ormai otto anni prima. Quando incontra Mizushima, un uomo che le ricorda il suo amore mai dimenticato, Towako instaura con lui una relazione che ben presto però si rivelerà destinata al fallimento. Quando poi la donna si accorge che Jinji la pedina e la tiene sotto controllo, qualcosa si mette in moto nella sua mente, soprattutto nel momento in cui viene a sapere che il suo ex fidanzato Kurosaki è scomparso da cinque anni senza lasciare traccia. Riuscitissimo lavoro del regista giapponese Kazuya Shiraishi, Birds Without Names è film che mette sotto la sua lente di ingrandimento alcune tematiche che permeano la società giapponese e di conseguenza la cinematografia di quel Paese: la solitudine e la paura che essa genera, la complessità dei rapporti interpersonali improntati alla dipendenza reciproca, l’amore malato e le sue forme patologiche. La storia che da racconto drammatico scivola lentamente nel thriller rifulge per una regia elegante ma contenuta e sostanziale, per alcuni momenti di grande impatto cinematografico, per le tematiche tutt’altro che rassicuranti che i personaggi, tutti più o meno dei perdenti cronici, rappresentano e che creano un certo disagio e caricano il film di una cupezza dolorosa. Non fosse per un finale un po’ troppo prolisso e ridondante, potremmo definire il film di Shiraishi uno dei più belli dell’anno: nonostante ciò Birds Without Names risulta di certo il miglior lavoro visto alla Rassegna Festaiola di Roma (ci voleva poco a dire il vero…) dove le storie rassicuranti e a lieto fine sempre e comunque pullulano, anche grazie alle eccellenti interpretazioni di Yu Aoi e Sadao Abe. (M.V.) Borg McEnroe, di Janus Metz (Svezia, Danimarca, Finlandia)
Borg McEnroe, di Janus Metz (Svezia, Danimarca, Finlandia)![]()
Uno dei match più avvincenti della storia del tennis approda sul grande schermo per mano del regista danese Janus Metz (qualcuno lo ricorderà per il bel documentario Armandillo, girato nel 2010). Borg McEnroe, come suggerisce il titolo, è lo scontro tra due titani della racchetta: il taciturno e granitico Björn Borg vs l’estroverso e irrequieto John McEnroe sul campo di Wimbledon, durante la finale che vide trionfare il primo sul secondo, nel 1980. Prima di arrivare al confronto sul prato verde – cinque intensissimi set che restano una pietra miliare dell’intrattenimento sportivo – il film ci racconta il background dei due campioni, dalla loro infanzia alle prime vittorie professionali, delineando due personalità speculari, apparentemente agli antipodi, ma in fondo molto simili per temperamento e caparbietà. Borg McEnroe offre una ricostruzione credibile e coinvolgente, soprattutto grazie ai due attori protagonisti Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf, che svolgono un lavoro egregio nell’impersonare i due campioni dentro e fuori dai campi di tennis. C’è però un grande neo, come per quasi tutti i film a tematica sportiva sul calcio, il football, ecc.., ossia le riprese dei movimenti in un rettangolo delimitato: Metz, come molti suoi colleghi prima di lui, non riesce ad evitare quell’effetto televisivo dell’azione sul campo da gioco. Borg McEnroe è un biopic che vive dunque esclusivamente del ricordo di due mostri sacri, senza un particolare afflato cinematografico: piacerà a chi ama le storie di sport, meno agli altri. (F.S.) The Place, di Paolo Genovese (Italia)
The Place, di Paolo Genovese (Italia)![]()
Un misterioso uomo trascorre le sue giornate seduto sempre allo stesso tavolo in un ristorante-bar chiamato The Place. Come una specie di confessore lo vediamo giorno e notte ascoltare e prendere nota dei più svariati problemi delle persone comuni che, non si sa bene per quale ragione, si rivolgono a lui nella speranza di vedere esauditi desideri e bisogni inconfessabili. C'è chi gli chiede di trovare il modo di salvare il proprio figlio da un tumore, chi va da lui perché vorrebbe trascorrere una notte di sesso con una bellissima modella che ha posato nuda per un calendario, chi lo incontra per capire come ritrovare la Fede in Dio. L'uomo è una sorta di faccendiere che ha il potere di fornire a chi si affida a lui la soluzione ai problemi di cui si soffre, chiedendo però in cambio ai ‘bisognosi’ di portare a termine compiti ben precisi, che in molti casi si traducono in azioni orrende da compiere. Vi sembra una storia assurda? Infatti lo è. Paolo Genovese si era distinto recentemente con Perfetti sconosciuti, un film che deve la sua fortuna a un'intuizione narrativa grazie alla quale lo spettatore era portato a confrontarsi con situazioni fuori dagli schermi rispetto alle solite dinamiche del cinema italiano per il grande pubblico. Il regista vorrebbe riproporre la stessa formula attraverso un nuovo intreccio spiazzante (tratto peraltro dalla serie The Booth at the End), ma questa volta il contenuto è carente: i personaggi, le storie che essi si portano dietro, i loro dialoghi sono banali e non riescono a stare al passo dell’ambizione di raccontare le zone d’ombra dell’animo umano (a cominciare dal protagonista la cui condizione di costrizione in uno spazio limitato richiama malamente alla mente quella del Titta Di Girolamo prigioniero di un confortevole hotel ne Le conseguenze dell’amore). Alla riuscita del film non giova nemmeno il sospetto che si sia calcata troppo la mano per rendere il film un prodotto da esportazione, con location, scelta delle musiche, fotografia che sembrano usciti da una produzione americana. Arriviamo ai titoli di coda attoniti, con la netta sensazione che il regista si sia dimenticato di dare un minimo di plausibilità a quello che racconta. (F.S.) La Vida y Nada Mas (Life & Nothing More), di Antonio Méndez Esparza (Spagna, Stati Uniti)
La Vida y Nada Mas (Life & Nothing More), di Antonio Méndez Esparza (Spagna, Stati Uniti)![]()
Il regista spagnolo Antonio Méndez Esparza, da alcuni anni trasferitosi in Florida dopo avere anche studiato negli States, dirige La Vida y Nada Mas presentato alla Festa del Cinema di Roma, dopo avere ottenuto premi e riconoscimenti al Festival di San Sebastian. La storia si coagula intorno ad una famiglia afroamericana della Florida e attraverso essa diventa il racconto di tutta una comunità, appunto quella dei neri d’America. Il protagonista è il giovane William, un quattordicenne che vive con la madre e la piccolissima sorella, il padre è in galera e di fatto non ha rapporti con la famiglia, sebbene il giovane soffra per la mancanza di una figura paterna. La madre lavora in un fast food e lui la aiuta nell’accudire la sorella, alternando queste attività a quelle pericolose che la strada offre. Quando un uomo si intrufola nella vita della famiglia stringendo una relazione con la madre, William reagisce nell’unica maniera possibile, iniziando un percorso duro per uscire dalla situazione in cui si trova. Film tra i più verbosi che si ricordino, La Vida y Nada Mas è girato in maniera realista, come un film a basso budget che si rispetti, ma al di là dei consueti luoghi comuni sulle comunità nere, l’esplorazione di un mondo che avverte il pericoloso ritorno delle tensioni razziali (non a caso il film è ambientato nei giorni delle ultime elezioni presidenziali) si infrange su una sceneggiatura troppo ricca di dialoghi fin troppo articolati, soprattutto se riferita al particolare contesto sociale e personale; in certi momenti sembra di essere di fronte al Woody Allen più logorroico, al di là dei temi trattati. L’impressione è quella che Méndez Esparza abbia tentato di celare la sua prospettiva da europeo e quindi più analitica senza però riuscirci, per non parlare di alcuni punti deboli della scrittura. Stavolta non possiamo parlare di lavaggio di coscienza della società americana per i motivi esposti, ma il risultato però non cambia. Per fortuna il finale riesce ad evitare con cura il trappolone finale, e questo è già qualcosa. (M.V.)
Tutti ne parlano Insyriated, di Philippe Van Leeuw (Belgio-Francia-Libano)
Insyriated, di Philippe Van Leeuw (Belgio-Francia-Libano)![]()
Una giornata come tante di una delle tante famiglie che subiscono gli effetti di una delle guerre più assurde che si siano mai svolte nella storia dell’Umanità: all’interno di un appartamento di una città siriana una famiglia vive il suo dramma della sopravvivenza. La porta sprangata dall’interno è l’immagine che quasi ossessivamente viene rimandata sullo schermo, quasi a delimitare il mondo. Insieme alla famiglia di chiara estrazione borghese c’è anche una giovane coppia con neonato che viveva al piano di sopra prima che la loro casa fosse semidistrutta: i due progettano la fuga in Libano e quando l’uomo esce di casa per mettere a punto gli ultimi dettagli un cecchino gli spara alle spalle. Solo la domestica di casa vede la scena ed informa subito l’austera e pragmatica padrona di casa: recuperare il corpo è impossibile, per il momento meglio tacere. Su questo ‘non detto’ si sviluppa buona parte del film che per il resto ci rende più che le immagini i suoni della guerra: colpi di mitra, esplosioni lontane e vicine, l’energia elettrica che va e viene, l’acqua che scarseggia. Il regista belga Philippe Van Leeuw, alla sua opera seconda, con grande efficacia muove la macchina da presa negli angusti spazi dell’appartamento trasformando il racconto in un dramma da camera dai forti connotati. Nella sua parte centrale la comparsa di due loschi individui che si muovono come autentici banditi di fronte ai quali la giovane madre si comporta attingendo al puro spirito di sopravvivenza, cerca di far virare il film immettendo una bella dose di tensione, operazione che francamente appare persino superflua e che impedisce al film di assurgere a livelli eccellenti. Meglio sarebbe stato insistere sul ‘non detto’ e sulle sottili dinamiche che si creano nei gruppi che si trovano a spartire di necessità spazi angusti. Insyriated comunque è un buon film che ha il pregio di raccontare la guerra e la deriva psicologica della popolazione in maniera anticonvenzionale, facendo ricorso solo ai suoni e al terrore che monta nei personaggi di tutte le età, che nonostante tutto cercano di vivere una esistenza dignitosa. Lo sguardo nel vuoto del vecchio patriarca della famiglia che chiude il film è il commento silenzioso di chi pensa che ormai là fuori non c’è più nulla che valga la pena di essere vissuto. (M.V.) Hostages, di Rezo Gigineishvili (Georgia, Polonia, Russia)
Hostages, di Rezo Gigineishvili (Georgia, Polonia, Russia)![]()
Ispirato ad un fatto di cronaca realmente avvenuto in Georgia nel 1983, all’epoca ancora sotto il dominio sovietico, Hostages del regista Rezo Gigineishvili è lavoro che oscilla in maniera continua tra il racconto di cronaca e lo studio sociologico e politico di una epoca che presentava i primi fermenti che avrebbero portato qualche anno dopo al dissolvimento dell’Unione Sovietica. I protagonisti dei fatti narrati sono alcuni giovani appartenenti a famiglie dell’elite georgiana: medici, attori artisti, insomma quello che avrebbe dovuto essere il futuro della repubblica ex sovietica. Comprano sigarette americane di contrabbando, si procurano al mercato nero i dischi dei Beatles, sognano una vita lontano dall’opprimente società sovietica nel tanto agognato Occidente nonostante i richiami austeri dei genitori. “Non capisco cosa vi manca” è la frase che più spesso sentiamo proferire nel film: ai giovani manca la libertà e la possibilità di determinare le sorti della propria vita. Per tale motivo subito dopo il matrimonio dell’attore del gruppo, pianificano una fuga in Turchia e quindi in Occidente; per fare ciò decidono di dirottare un aereo della compagnia di bandiera sovietica. Il fallimento del piano si trasformerà in un episodio sanguinoso che causerà diverse vittime, anche tra i passeggeri dell’aereo, e metterà fine alle speranze dei giovani. Proprio nella indecisione su come trattare il fatto, oscillando tra ricostruzione storica e indagine socio-politica, sta il lato oscuro del film: i personaggi sono tratteggiati sommariamente, quel tanto che basta a giustificarne le azioni, i rapporti con i genitori sembrano esser quelli di qualsiasi giovane un po’ troppo esuberante, il giudizio del regista sembra rimanere a metà strada, né eroi della libertà, né pazzi sconsiderati, e il tratteggio storico sembra affidarsi troppo spesso ai soliti arcigni agenti del KGB in impermeabile di pelle nera. Nonostante ciò il lavoro di Reze Gigineishvili ha qualche pregio, soprattutto quello di squarciare un velo su una pagina storica ancora ben poco chiara di una delle repubbliche ex-sovietiche più riottose a sottomettersi al potere comunista. (M.V.) A Prayer Before Dawn, di Jean-Stéphane Sauvaire (Francia, Regno Unito, Cambogia, Stati Uniti, Cina)
A Prayer Before Dawn, di Jean-Stéphane Sauvaire (Francia, Regno Unito, Cambogia, Stati Uniti, Cina)![]()
Il secondo lungometraggio di Jean-Stéphane Sauvaire che fa seguito alla sua opera prima Johnny Mad Dog che nove anni or sono ricevette un riconoscimento al Festival di Cannes, trae ispirazione dalla autobiografia di Billy Moore, che visse per 15 anni nelle prigioni thailandesi dove fu imprigionato per possesso e consumo di droga. Il giovane protagonista vive a Bangkok tra un incontro di boxe e l’uso di eroina finché non viene arrestato e condotto nel più famigerato carcere della capitale thailandese, dove l’inferno sembra essere sceso sulla terra senza possibilità di evitarlo. Combattuto tra la dipendenza e la volontà di uscire dal tunnel, Billy trova nella boxe thai un'ancora di salvezza che gli permette se non altro di vivere in maniera appena più decente la sua detenzione. L’incontro con un ladyboy e l’orrore del carcere lo spingono a cercare nella boxe, che appare la sua unica ragione di vita, un modo per tentare un riscatto soprattutto con se stesso. Il racconto che costruisce il regista francese si basa tutto sulla prospettiva del giovane: le violenze, i soprusi aberranti, le regole non scritte del carcere che sembra una terra di nessuno, gli impongono di contenere e controllare la sua rabbia violenta che cova dentro, portandolo a girare lo sguardo quando serve e a difendersi quando non ne può fare a meno. Il ritratto che Sauvaire fa del carcere è violento, durissimo, sebbene si compiaccia un po’ su tutta una serie di luoghi comuni che accompagnano qualsiasi discorso che riguardi il paese dell’estremo oriente: soprattutto all’inizio si mescola la droga e la boxe, i ladyboys e la violenza, la protervia dei poliziotti e le condizioni dei carcerati. Insomma, in questa carrellata manca solo la presenza di qualche fantasma. Quando però il regista mette al centro della storia la figura di Billy, a dire il vero colpevolmente lasciata priva di background (cosa ci fa uno di Liverpool a Bangkok e in quelle condizioni poi…), il tono di A Prayer Before Dawn cambia decisamente focalizzandosi sui demoni che agitano l’animo del protagonista. Mostrando un feticismo ossessivo per il corpo per lo più tatuato, Sauvaire racconta la deriva violenta e priva di regole cui i carcerati vanno incontro, evitando con cura il filone della denuncia, soffermandosi invece sulla descrizione dei limiti della sopraffazione e della violenza che può raggiungere e superare l’uomo. Peccato per quel finale che ci mostra il vero Billy Moore: perché sottolineare con la sua foto che tutto si riferisce a fatti realmente accaduti? (M.V.)
Alice nella città
 Blue My Mind, di Lisa Bruhlmann (Svizzera)
Blue My Mind, di Lisa Bruhlmann (Svizzera)![]()
Scritto e diretto dalla attrice svizzera Lisa Bruhlmann alle prese con la sua opera prima, Blue My Mind giunge alla Festa del Cinema di Roma dopo aver ricevuto un paio di importanti riconoscimenti al Festival di Zurigo. Attraverso il racconto della giovane protagonista Mia, il film è un’attenta indagine su un disagio adolescenziale che nel suo percorso assume connotati quasi soprannaturali. La ragazza va a vivere alla periferia di Zurigo con la sua famiglia, il suo inserimento e adattamento alla nuova realtà è tutt’altro che semplice anche perché i genitori da buoni svizzeri pensano al lavoro e ai loro impegni. A scuola, dopo un’iniziale avversione reciproca, Mia stringe amicizia con le ragazze più spigliate, interessate solo a divertirsi. L’integrazione però per Mia non può che passare attraverso delle tappe che prevedono situazioni per lei estranee: il sesso sfrenato, i furti nei centri commerciali, gli atteggiamenti da Lolita; parallelamente a questo processo di crescita tumultuosa, qualcosa si sveglia dal più profondo del suo essere, come una mutazione genetica che fa di lei un essere in via di trasformazione. La mutazione corporea cui va incontro Mia è la metafora della sua fuga dal mondo ‘normale’, da quel mondo in cui ormai lei è un piccolo segmento dal quale è impossibile uscire. Più che film di denuncia sociale sui giovani riottosi e facinorosi e sulle famiglia insensibili, Blue My Mind è il racconto intimo di una profonda inadeguatezza, di una sofferenza a vivere la quotidianità che pesa come un macigno. E se non fosse per l’evoluzione della metafora che si concretizza fin troppo compiutamente in maniera inutile, il lavoro della Bruhlmann potrebbe assurgere ai maggiori livelli del genere, anche grazie alla scelta tecnica utilizzata dalla regista che attraverso immagini e colori quasi tranquillizzanti, riesce ad evitare i fastidiosi luoghi comuni sulla adolescenza inquieta, nichilista, sporca e cattiva. Da sottolineare la notevole prova della giovane Luna Wedler che regala al personaggio di Mia le giuste sfaccettature. (M.V.)