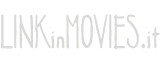Titoli di coda per il London Film Festival 2017: vincitori e panoramica di tutti i film visionati
- Scritto da Adriana Rosati
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Commenta per primo!
 Il London Film Festival 2017 ha chiuso i battenti con il trionfo di Loveless di Andrey Zvyangintsev: dai film vincitori ai titoli visionati, ripercorriamo i dodici giorni di cinema della rassegna inglese
Il London Film Festival 2017 ha chiuso i battenti con il trionfo di Loveless di Andrey Zvyangintsev: dai film vincitori ai titoli visionati, ripercorriamo i dodici giorni di cinema della rassegna inglese
Siamo giunti alla fine del 61esimo BFI London Film Festival. Il Closing Gala si è svolto domenica sera a Leicester Square e a chiudere in bellezza è stato il bel film del britannico Martin McDonagh, Three Billboards Ouside Ebbing, Missouri.
Nel pomeriggio invece, in una cerimonia presentata dall’attore nord-irlandese James Nesbitt, sono stati assegnati i premi ai vincitori di questa edizione.
Vediamoli:
- Miglior Film: LOVELESS, di Andrey Zvyagintsev (Russia, Francia, Germania, Belgio)
- Migliore Opera Prima: THE WOUND, di John Trengove (Sud Africa)
- Migliore Documentario: KINGDOM OF US, di Lucy Cohen (Regno Unito)
- Migliore Cortometraggio: THE RABBIT HUNT, di Patrick Bresnan (USA)
È decisamente una scelta che ci soddisfa quella per il titolo di miglior film a Loveless. È la seconda volta che Zvyagintsev viene premiato a Londra, la prima era stata nel 2014 con Leviathan. La giuria, presieduta dal regista Babak Anvari, ha inoltre dato una menzione speciale al film israeliano Wajib.
Per la migliore Opera Prima The Wound, la giuria ha sottolineato la fresca originalità con cui il film affronta la sessualità e il concetto di mascolinità. Menzione speciale a Summer 1993 e alla sua regista Simon, come talento da tenere d’occhio.
Nella sezione documentari invece è stata lodata la capacità di Lucy Cohen di cogliere l’intimità nel toccante Kingdom of Us, dove la regista racconta la ripresa di una famiglia dopo il suicidio del padre. Il film, girato in tre anni, è prodotto da Netflix ed è già disponibile per lo screening.
Infine il cortometraggio-documentario The Rabbit Hunt ha conquistato la giuria con il suo sguardo realistico e non moralista su una famiglia che caccia conigli nei campi di canna da zucchero in Florida, durante il raccolto.
È sempre con una sensazione di non aver visto abbastanza film che si arriva alla fine del London Film Festival. È una grande festa del cinema e, concorso a parte, è una imperdibile occasione di veder film che forse non arriveranno mai nelle sale europee ed è anche un’occasione per tanti film fuori concorso che non hanno ancora trovato distribuzione in Europa (circa il 50%) per esporsi e farsi notare e auguriamo una buona riuscita a tutti loro. Con 243 titoli a disposizione è certamente impossibile vederli tutti e scriverne, ma ecco un assaggio di una parte dei film visti quest’anno.
 Beast, di Michael Pearce (Regno Unito) - In concorso
Beast, di Michael Pearce (Regno Unito) - In concorso
![]()
Thriller del regista britannico Michael Pearce, Beast compete nella sezione Opera Prima. Moll è una giovane ragazza che vive con la famiglia sull’Isola di Wight e ha un passato turbolento di reazioni violente al bullismo. Per questo motivo è sorvegliata a vista dall’arcigna madre. Durante la sua festa di compleanno, annoiata, scappa e passa la notte in discoteca. All’alba incontra Pascal, un bel giovanotto locale dall’aria misteriosa e sexy: tra di loro nasce un interesse che si trasformerà ben presto in una vera e propria storia d’amore. Ma il paese nel frattempo è scosso da una serie di delitti. C’è un serial killer a piede libero e i sospetti rimbalzano qui e lì finendo sempre a puntare chi vive ai bordi dell’ordine costituito. Pearce fa un buon lavoro nel far salire la tensione e nel tratteggiare una comunità claustrofobica e bigotta, ma questa tensione sfocia fin troppo velocemente in un epilogo con dei twist che sono troppo repentini per essere credibili. La bilancia sostanza/forma pesa un po’ dalla parte della forma. Tutto molto stiloso, a cominciare dai vestitini anni ’50 di Moll, che nessuna ventenne indosserebbe ora. La brava e giovane Jessie Buckley (già vista in Taboo) è decisamente una da tenere d’occhio e il musicista Johnnny Flynn, nella parte di Pascal, fa la sua bella figura con il suo fascino da bello e dannato.
 The Cakemaker, di Ofir Raul Grazier (Germania, Israele) - In concorso
The Cakemaker, di Ofir Raul Grazier (Germania, Israele) - In concorso
![]()
The Cakemaker è l’opera prima del regista israelianano Ofir Raul Grazier. Il film, delicato e malinconico, comincia in un caffè pasticceria di Berlino gestito dal giovane Thomas. Uno dei client regolari di Thomas è Oren, un ingegnere israeliano che una volta al mese passa qualche giorno a Berlino per lavoro. Tra i due inizia una relazione che va avanti per un anno ma senza ulteriori sviluppi pratici, perché Oren in realtà ha una moglie e un figlio a Gerusalemme che non vuole lasciare. Quando Oren rimane vittima di un incidente in Israele, Thomas è l’ultimo a saperlo, in modo triste e impersonale, perché, in fondo lui, come amante clandestino, è un 'nessuno' nella vita ufficiale di Oren. In questo frustrante processo di lutto, il ragazzo mette in pausa la sua vita berlinese e si reca a Gerusalemme, nel tentativo più di pancia che di testa, di cercare le tracce del suo amante e di avvicinarsi a lui nel modo meno opportuno forse, ma più diretto, cioè attraverso la sua famiglia e sua moglie (la brava Sarah Adler di Foxtrot). Il film è una riflessione su amore, desiderio e lutto, fatta in modo molto garbato che, pure con tematiche LGBT, non punta a provare nulla e semmai è un po’ indebolito da questa volontà di non pestare i piedi a nessuno e piacere a tutti. Grazie al cielo (!) il film si tiene bene alla larga dalla formula “I dolci confortano e avvicinano gli animi” e dal food porn, come il titolo potrebbe suggerire.
 Ingrid Goes West, di Matt Spicer (USA)
Ingrid Goes West, di Matt Spicer (USA)
![]()
Il film è quasi una versione aggiornata 2.0 di Single White Female, ovvero lo stalkeraggio ai tempi di Instagram. Ingrid (Aubrey Plaza) è una ragazza che ha appena perso la madre e che ha la tendenza a ossessionarsi con la vita apparentemente felice e spensierata dei suoi coetanei sui social media e a dare troppo peso a qualche 'like' di meno o di troppo. Dopo aver compiuto un goffo gesto di rabbia nei confronti di una bella 'socialite', viene spedita a fare un periodo di riabilitazione che però non previene un’ulteriore infatuazione di Ingrid per la californiana e star di Instagram Taylor Sloane. A questo punto Ingrid che non ha più niente da perdere parte per la California, determinata a diventare amica del suo idolo. Ne segue una commedia piuttosto prevedibile ma obiettivamente divertente, specialmente nella prima metà. Peccato che il combustibile si vada esaurendo lungo la strada lasciandoci quasi a terra alla fine. L’epilogo mi ha lasciata basita, se voleva essere ironico, non ne ha l’energia, se non voleva esserlo, peggio ancora. Le parodie dei tipici instagrammer sono ben delineate e pungenti e il film è ben recitato, la brava Aubrey Plaza è l’elemento che tiene insieme la pellicola, ma manca qualsiasi accenno di analisi della compulsione di Ingrid e di conseguenza, come il soggetto di cui tratta, persiste nella memoria solo per il tempo di un click.
 Wajib, di Annemarie Jacir (Palestina, Francia) - In concorso
Wajib, di Annemarie Jacir (Palestina, Francia) - In concorso
![]()
La regista Annemarie Jacir mette in scena un road movie di pochi chilometri per parlare di modi vecchi e nuovi di essere palestinesi. È usanza in Palestina consegnare gli inviti di matrimonio a mano, porta a porta ad amici e parenti e Abu Shadi, un insegnante sessantenne divorziato, si appresta a rispettare la tradizione, aiutato dal figlio Shadi, architetto che vive e lavora all’estero ed è appena rientrato in occasione del matrimonio della sorella. I due cominciano la giornata con il giro di consegne, e le visite di dovere (wajib, appunto) diventano spunto per confrontare due punti di vista molto diversi sul vivere in Palestina. Il padre ama la sua città e la sua comunità di amici e conoscenti ed è disposto a qualche compromesso per quieto vivere e per rispetto delle tradizioni. Il figlio invece rappresenta 'quelli che se ne sono andati' e il cui punto di vista rimane critico e intransigente. Il tono però resta leggero, da commedia e i due attori fanno un buon lavoro, considerando che quasi tutto il film si svolge nell’abitacolo della macchina o sorseggiando caffè da parenti, grazie a una buona chimica, forse aiutata dal fatto che sono padre e figlio anche nella realtà! Il film è la proposta palestinese per l’Oscar per il miglior film straniero.
 King of Peking, di Sam Voutas (Cina, USA, Australia)
King of Peking, di Sam Voutas (Cina, USA, Australia)
![]()
La storia di un proiezionista e di un bambino, amanti dei classici di Hollywood che si trovano disoccupati con l’avvento del digitale, è francamente ri-improponibile e quindi perché non ambientarla in Cina, dove Hollywood era una grande avventura esotica? Wong e Wong sono un padre divorziato e suo figlio con l’argento vivo addosso che insieme organizzano allegre proiezioni “pop-up” di filmoni americani nelle piazze, finché per malasorte Wong senior si ritrova a dover lavorare come uomo delle pulizie in un grande cinema della città. Pressato dall’incombenza degli alimenti mensili alla moglie, si ingegna e mette in piedi un’impresa di pirataggio di film con l’aiuto di Wong junior. Commedia leggera e 'piaciona', con un pizzico di Nuovo Cinema Paradiso, che gioca con i temi evergreen e che accontenta tutti i nostalgici dei cinematografi di una volta (sic) e del simpatico nerdismo Anni ’90. Molto carine le illustrazioni naïf a imitazione delle locandine originali, ma la colonna sonora fatta di cover di temi di film suonati con strumenti cinesi (e che i due protagonisti fanno a gara a riconoscere) dopo un po’ manda al manicomio. Buono per un pomeriggio di pioggia, in casa con i bambini.
 Bad Genius, di Nattawut Poonpiriya (Thailandia)
Bad Genius, di Nattawut Poonpiriya (Thailandia)
![]()
Bad Genius è un ottimo thriller thailandese che unisce i popolari temi delle marachelle al liceo e del 'colpo grosso' creando un film di genere a sé, pieno di suspense e divertimento. Non a caso ha sbancato il botteghino in Thailandia e si appresta a conquistare il mercato asiatico. Lyn è una brillante studentessa di liceo dotata di una grande intuizione matematica che l’ha portata ad avere una borsa di studio ed essere accolta in una costosa scuola dove non avrebbe potuto altrimenti iscriversi. Lyn infatti vive una vita modesta con il padre, un dignitoso insegnante e, come lei, anche l’altro unico borsista della scuola, Bank, genio matematico e figlio di una lavandaia. Il resto degli scolari sono ricchi rampolli con poca voglia di studiare ma denaro a sufficienza per pagare qualunque servizio. Lyn comincia per amicizia ad aiutare un paio di suoi compagni di classe durante le revisioni, ma presto tutto ciò diventa un fruttuoso business. Non contenti, Lyn e i due amici Grace e Pat vogliono portare il tutto ad un livello superiore, concentrandosi sul temuto esame STIC, per l’ammissione alle università straniere, che si svolge in contemporanea in tutto il mondo. Complice sarà il fuso orario, ma bisogna anche trovare il modo di coinvolgere il riluttante Bank che ha dato prova di essere non solo un secchione, ma anche uno spione. Scandito perfettamente con il passo da Grande Rapina, Bad Genius mi ha ridotto sull’orlo della sedia a mangiarmi le unghie. Bravi attori giovanissimi, soprattutto Lyn, una modella al suo primo ruolo cinematografico. Grande intrattenimento con buttati lì anche una critica sociale e una morale giusta.
 Una Mujer Fantastica (Una donna fantastica), di Sebastian Lelio (Cile, Germania, Spagna, USA)
Una Mujer Fantastica (Una donna fantastica), di Sebastian Lelio (Cile, Germania, Spagna, USA)
![]()
Lelio, dopo il successo di Gloria del 2015 e spalleggiato in questa impresa da Pablo Larrain nelle vesti di produttore, racconta la storia di una donna alle prese con le avversità, come illustra la didascalica locandina italiana (sic). Marina è una giovane cantante che sta lavorando sulla sua carriera e ha una tenera e appassionata relazione con Orlando, un uomo divorziato e più grande di lei. Marina è anche in procinto di trasferirsi e vivere con il suo uomo ma, una notte, un improvviso aneurisma si porta via Orlando lasciando la giovane sola a confrontarsi non solo con il suo dolore ma anche con l’aspra reazione della famiglia e delle autorità che sembrano dare per scontato che Marina sia in qualche modo responsabile della disgrazia. Già, perché Marina è una donna transgender e tanto basta per sottintendere ogni sorta di perversione. Gran parte del tempo lo schermo è invaso da intensi primi piani di Marina che ha sulle spalle tutto il film e l’attrice-cantante transgender Daniela Vega lo porta con dignità e impegno. Non aspettatevi battaglie legali o risarcimenti o vendette: solo una storia di resilienza di una donna che, a dispetto delle avversità, si rimette in piedi, concentrata sulle sue forze, su un percorso di ricostruzione verso la scoperta di se stessa, come le ultime scene suggeriscono. Qualche caduta di ritmo e mordente si fanno perdonare da una storia che doveva essere raccontata.
 Les Gardiennes, di Xavier Beauvois (Francia, Svizzera) - In concorso
Les Gardiennes, di Xavier Beauvois (Francia, Svizzera) - In concorso
![]()
Presentato al Toronto International Film Festival (TIFF) Les Gardiennes è l’ultima fatica del regista Xavier Beauvois che con Uomini di Dio aveva fatto incetta di premi e nomination, compreso il Gran Prix a Cannes. Le guardiane del titolo sono le donne durante la Prima Guerra Mondiale. Guardiane della terra, del lavoro, della casa e soprattutto della salute mentale, in un periodo in cui la pazzia di una guerra assurda aveva strappato gli uomini dalla terra e, se non uccisi, li avrebbe cambiati per sempre. Il film ripercorre gli anni finali del conflitto e i primi anni seguenti. Le donne della famiglia Paridier, Hortense e sua figlia Solange, portano avanti con tenacia e dedizione la loro impresa agricola, i campi, gli animali. I figli di Hortense e il marito di Solange sono al fronte e le due assumono come aiutante una giovane orfana, Francine. La ragazza lavora con vigore quasi mascolino, si fa apprezzare e ben volere e fa innamorare il figlio più giovane di Hortense nelle sue sporadiche visite dal fronte. Ma la ragazza è pur sempre un’estranea e il giovane soldato è fortemente traumatizzato e insicuro. Questo è un film sulla guerra dove la guerra non si vede mai, la sua ombra è ovunque, riflessa nella vita di tutti i giorni di queste donne. È una storia di resilienza di quelle donne coraggiose e forti e Francine ne è il simbolo di rinascita. Il film indugia molto su scene agresti e contadine molto belle anche perché la produzione, musica, costumi e fotografia sono eccellenti, ma il passo è a volte molto lento. Francine è interpretata da Iris Bry al suo primo lavoro e la ragazza è un vero fenomeno oltre a possedere una splendente bellezza d’altri tempi.
 The Nile Hilton Incident, di Tarik Saleh (Svezia, Danimarca, Germania, Francia)
The Nile Hilton Incident, di Tarik Saleh (Svezia, Danimarca, Germania, Francia)
![]()
Questo thriller che ha esordito al Sundance Festival dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, è un’interessante operazione, essendo un film scandinavo ma dall’apparenza, luogo, lingua e attori egiziani. È stato scritto e diretto da Saleh, anche lui svedese di discendenza egiziana. Ambientato al Cairo nei giorni che precedono la rivoluzione del 2011 che finirà per deporre il presidente Mubarak e quindi un periodo turbolento ed esplosivo, il film segue il comandante di polizia del Cairo Noredin (interpretato dal popolarissimo attore svedese di origine libanese Fares Fares) alle prese con il caso di omicidio di una bella cantante locale, trovata morta nella stanza di un lussuoso albergo. In una città dove i testimoni muoiono come mosche e l’unico motore di informazione sono rotoli di banconote, l’impresa di Noredin sembra impossibile. Noredin stesso non è uno stinco di santo e anche lui ragiona a mazzette, ma quando il caso porta verso dei personaggi dell’elite intoccabile e il conto dei morti aumenta, l’ufficiale comincia a chiedersi da che parte stare. Questo è un noir intenso che ammicca sia ai classici di genere, che ai classici thriller scandinavi, nichilisti e cupi dalla tensione continua, dove nessuno si salva, specialmente chi prova ad agire secondo una morale 'umana'. Noredin è il classico eroe noir, dorme male, fuma tanto, ha alle spalle un brutto trauma e guida nella notte in una città sporca che si sta sgretolando sotto i suoi occhi come il Paese di cui è la testa, e che è resa spettrale e affascinante da una doccia costante di luce azzurra. Un’ambientazione desueta per un film classico che ne beneficia, senza sfruttarla solo come mero espediente.
 Wrath of Silence (Bao lie wu sheng), di Xin Yukun (Cina)
Wrath of Silence (Bao lie wu sheng), di Xin Yukun (Cina)
![]()
Secondo film per il trentenne regista cinese Xin Yukun, dopo The Coffin in the Mountain e premier internazionale al London Film Festival 2017. Freschissima, tra l’altro, la notizia che la Cina ha sospeso, per ragioni non specificate, il lancio del film che era programmato per questo periodo festivo e che in Cina è considerato il periodo d’oro al botteghino, penalizzandone quindi notevolmente il rientro economico. Baomin (Song Yang) è un giovane minatore muto con un turbolento e litigioso passato che per questo motivo lavora lontano da casa, dove ha lasciato la moglie e il figlio Lei a badare alle pecore. Ma la notizia che Lei è inspiegabilmente sparito lo riporta al villaggio e la ricerca del figlio si tramuterà in qualcosa di più grosso e che sfugge alla comprensione di Baomin. Nel frattempo un altro bambino è sparito, ma quest’ultimo ha un 'valore di mercato' ben più alto. Grandi performance di Song Yang e di Jiang Wu (A Touch of Sin) che interpreta un ricco e potente imprenditore minerario del Nordest della Cina, dove il film è ambientato. Un thriller raggelante ad atmosferico dalla tensione crescente, Wrath of Silence è anche un potente exposé della corruzione e dell’individualismo che fanno da tessuto connettivo della società attuale cinese. Girato in una penetrante alta definizione che dona un effetto iperrealista ed inquietante, è la fotografia di una terra sventrata nel fisico e nell'etica da un’incurabile cupidigia.
 L’Amant Double, di Françoise Ozon (Francia, Belgio)
L’Amant Double, di Françoise Ozon (Francia, Belgio)
![]()
Ozon torna con un misto di thriller, erotismo ed eccentrico senso dell’umorismo, in un film molto diverso dal delicato Frantz dello scorso anno. Il problema fisico di una donna diventa un viaggio psicologico alla ricerca di se stessa. Chloé (Marine Vatch di Young and Beautiful) è afflitta da dolori addominali che sembrano di natura psicosomatica. Si rivolge quindi a uno psicanalista, Paul (Jérémie Renier), con cui dopo non molto inizia una storia d’amore. Chloe però scopre che Paul ha dei segreti nel suo passato e un fratello gemello che le ha tenuto nascosto, Louis, anch’esso psicanalista. Chloé è attratta da questo mistero e decide di incontrare segretamente e anonimamente il gemello, i cui inusuali metodi di psicanalisi guideranno la donna in un percorso alla scoperta di se stessa che passa per desiderio, erotismo, colpa, dominazione, morte e rinascita. Elegante e pieno di caramelle per gli occhi, a partire dai due protagonisti, e di gustosi colpi di genio come le opere del museo di arte moderna dove Chloé lavora, che cambiano rispecchiando quello che succede nella mente della donna. È un film che ammicca molto ai noir soft-porno degli Anni ‘80/’90, nell’estetica e nelle dinamiche velatamente sadomaso. L’intreccio psicologico rischia di deludere un po’ perché tutto sommato è piuttosto prevedibile. Ma va preso con quel senso di leggerezza tutta francese e con l’intento di gustarsi il viaggio piuttosto che la destinazione.
 Memoir of a Murderer, di Won Shin-yeon (Corea del Sud)
Memoir of a Murderer, di Won Shin-yeon (Corea del Sud)
![]()
Come in quasi ogni thriller coreano che si rispetti, anche qui c’è un serial killer, anzi, ce ne sono due. Byung-su è un serial killer in pensione, non uccide più da quando ha avuto un incidente stradale dopo il quale si è dedicato esclusivamente al suo lavoro di veterinario ed a crescere la figlia da papà single. A Byung-su però hanno appena diagnosticato l’Alzheimer, forse accelerato dal vecchio incidente, e sta perdendo la memoria, ma alla notizia di un’altra serie di omicidi in città, comincia a dubitare del poco che ricorda e a chiedersi se i nuovi delitti siano suoi o di un 'collega'. Comincia quindi a scrivere le sue memorie per cercare di raccapezzarsi e quando la malattia peggiora prova anche a usare un dittafono. Quando crede di aver capito chi sia il nuovo killer però, tutto si fa più intricato perché l’uomo che lui sospetta comincia a frequentare la figlia. Il tempo stringe e Byung-su deve cercare di proteggere la ragazza e smascherare il killer che sapendo della demenza del vecchio lo costringe ad un gioco di gatto e topo. Il film ha delle premesse e un’idea interessante ed è strutturato a schegge e frantumi di memoria, di sogno, di realtà, ricreando la confusione che invade il protagonista ed è molto coinvolgente fino a quando comincia un po’ ad incartarsi nella sua stessa matassa e a perdersi. Iconicamente il film inizia all’uscita di un tunnel, richiamando alla memoria (perdonate il gioco di parole) Memories of Murder, un film dal titolo quasi uguale, ma le cui similitudini si fermano lì. Sul Kyung-gu nel ruolo del protagonista è indubbiamente bravo, ma si comincia a sentire un po’ di stanchezza di genere per questi thriller coreani molto simili fra di loro.
 Antonio Lopez 1970: Sex, Fashion & Disco, di James Crump (USA)
Antonio Lopez 1970: Sex, Fashion & Disco, di James Crump (USA)
![]()
Per chi non lo conosce, Antonio Lopez è un illustratore che ha lavorato quasi esclusivamente nel campo della moda. Non un fashion designer, ma un vero e proprio illustratore i cui disegni, eccezionalmente vividi e innovativi, hanno contribuito a delineare un decennio, gli Anni ’70, e a introdurre il seguente. Questo documentario è un tributo a Lopez come persona e, come il titolo suggerisce, allo stile di vita che negli Anni ‘70 a New York era imprescindibile dal lavoro artistico professionale. Tanti amici e compagni di baldoria di Lopez lo ricordano raccontando un'epoca in cui tutto era nuovo e tutto era permesso. Tra di loro il fotografo Bill Cunningham, l’attrice Jessica Lange e Grace Coddington, direttore creativo di Vogue USA. Purtroppo il documentario sorvola quasi completamente gli Anni ’80 che pure furono molto importanti nella sua carriera. Antonio Lopez è uno degli artisti che ha contribuito a formare il mio gusto e il mio interesse professionale come grafica e indubbiamente questo film incontra le mie aspettative, ma sarà anche molto godibile per chi non è interessato particolarmente al suo lavoro o alla moda perché è un ritratto frizzante di un periodo in cui tutto era nuovo e c’era una grande spensieratezza e voracità nella sperimentazione sia artistica che sessuale, prima del triste capitolo dell’AIDS. Il film si conclude piuttosto all’improvviso e c’è solo un brevissimo accenno alla malattia e alla sua morte che avvenne nel 1987 per complicazioni dovute all’AIDS. Ma forse vuole rispecchiare la sua vita che è stata un lungo party interrotto bruscamente dalla morte.
 The Florida Project, di Sean Baker (USA)
The Florida Project, di Sean Baker (USA)
![]()
Nuovo e attesissimo lavoro per Sean Baker, dopo il successo enorme lo scorso anno del suo Tangerine, film girato con uno smartphone. The Florida Project ha un budget più alto e una mega-star (Willem Dafoe in un bellissimo ruolo, umano e compassionevole) ma la storia è di una semplicità estrema. In realtà non c’è storia, il film segue le avventure banali e quotidiane di Moonee (Brooklyn Prince) e i suoi amici Scootie e Jancey, tre bambini sui sei anni che vivono in un motel in Orlando, Florida. Siamo alla periferia di Disney World, in senso sia fisico che metaforico. Un motel di bassa categoria dal nome di Magic Kingdom, vicino al parco dei divertimenti più famoso del mondo: oltre alle funzioni di albergo, offre residenza a persone come Halley (Brie Vinaite), la madre di Moonee, che ha perso il lavoro e non ha soldi per affittare un vero e proprio appartamento, un paio di gradini sopra la definizione di senza tetto. Moonee è in giro tutto il giorno a fare con entusiasmo quello che fanno i bambini, esplora, gioca, fa danni a cui deve correre ai ripari Bobby (Dafoe), il manager del motel. Spesso i pasti sono scroccati al fast food dove lavora un’amica della madre e a volte Moonee segue la madre mentre cerca di guadagnare qualcosa vendendo profumi davanti agli alberghi lussuosi di Orlando. Non c’è alcun romanticismo nel ritratto di questi bambini maleducati e allegri, ma un estremo naturalismo, giorno dopo giorno, storie di povertà in USA, sullo sfondo a colori pastello di sogni in vetroresina. La mia esperienza personale è stata quasi catartica. Sono passata dall’indecisione se avrei voluto prendere a schiaffi prima la madre o la figlia per arrivare alla fine della narrazione totalmente risucchiata nella vita dei personaggi. Un bel film, un bel talento. (Il motel e il servizio che offre ai suoi residenti rispecchiano la realtà).
 You Were Never Really Here, Lynne Ramsay (Regno Unito, Francia, USA)
You Were Never Really Here, Lynne Ramsay (Regno Unito, Francia, USA)
![]()
Questo lavoro è un’interpretazione umorale ed eccezionalmente nera del cosiddetto “Man on a Mission”, con un’aura molto autoriale. Prodotto, fra gli altri, da Film4 e Amazon, il film è diretto dalla britannica Lynne Ramsay che arricchisce di profonda vulnerabilità e introspezione psicologica quello che sarebbe altrimenti un ennesimo noir di brutale vendetta. Joe (Joaquin Phoenix) è un ex militare, ora specializzato in missioni particolari che devono rimanere segrete, come per esempio riportare indietro bambini e adolescenti scomparsi o scappati, a ricchi genitori. Tormentato dalla propria infanzia di abusi e orrendo autolesionismo, Joe procede in uno stato allucinatorio, indotto da pillole e costellato di flashback da incubo. La sua ultima missione è quella di recuperare la figlia di un senatore, rapita da qualche gruppo di trafficanti di minorenni a scopo sessuale: all'uomo è stata data carta bianca sui metodi e sull’entità della furia che vorrà usare. Joe non si risparmia in questo, sempre motivato dalla propria rabbia e dolore, e una volta recuperata Nina (Ekaterina Samsonov) si appresta a riportarla al padre. Ma qualcosa va storto. Molto storto. Il tema musicale stridente di Jonny Greenwood dei Radiohead accompagna il trance paranoico di Joe, che Phoenix interpreta con realismo impressionante, e la regista tralascia lo 'spiegone' del complotto che si cela dietro gli eventi, per concentrasi sui due personaggi, ridotti entrambi ai confini della sanità mentale da abuso e violenza. Inquietante e originale, dividerà le opinioni.
 Brawl in Cell Block 99, di S. Craig Zahler (USA)
Brawl in Cell Block 99, di S. Craig Zahler (USA)
![]()
Il regista S. Craig Zahler, che nel 2015 era saltato all’attenzione dei festival con il western/horror Bone Tomahawk, ha fatto con il suo nuovo film un’operazione alla Tarantino, rispolverando il tipico grindhouse movie, una sorta di B-movie, e insufflandoci nuova vita con tecnica, creatività e una grande performance di Vince Vaughn. Bradley (Vaughn) è un ex pugile con un 'fisique' che incute paura, è anche un uomo razionale che non ama usare violenza quando non serve, ma quando serve… Meglio non trovarsi nelle sue vicinanze. Nel prologo del film lo vediamo perdere il lavoro e scoprire che la moglie lo tradisce, ma Bradley ha un piano per aggiustare la situazione. Un anno dopo lo ritroviamo come ricco impiegato di un druglord, con una bella casa e in attesa di una figlia. Qualcosa va storto però e finisce in prigione con una condanna di sette anni. Bradley prende la reclusione come un effetto collaterale del suo lavoro, ma in carcere riceve una visita inaspettata. Sua moglie è stata rapita e se Bradley non si farà trasferire nel carcere di massima sicurezza Red Leaf, per uccidere un detenuto scomodo, delle cose tremende succederanno alla bambina che sta per nascere. Bradley ora deve trovare il modo di farsi trasferire in quel carcere e portare a termine la sua missione. Vaughn è al centro di questo film, con un personaggio molto diverso dai suoi soliti e la sua interpretazione robotica di un uomo compassato, con una sua personale etica, che cerca di fare sempre del suo meglio anche nel peggio, è esilarante e coinvolgente. Non è un film per un pubblico facilmente impressionabile, non ha nessun commento musicale ma tanto rumore di ossa rotte.
 The Cured, di David Freyne (Irlanda)
The Cured, di David Freyne (Irlanda)
![]()
In questo film irlandese, fatto con un piccolo budget, si esplora un aspetto dell’epidemia zombie che raramente viene preso in analisi e che, considerata la gran quantità di opere su questo soggetto, lo rende abbastanza originale. Siamo in un futuro molto vicino e una violenta epidemia di virus Maze che rende gli uomini degli zombie affamati, ha decimato l’Europa, ma è appena stata debellata. Si è trovata una cura, un vaccino che nel 75% dei casi funziona e le persone colpite ritornano a una certa 'normalità', anche se la loro vita non potrà mai tornare com’era, tormentati dai ricordi delle loro efferate azioni e perseguitati dagli 'altri', quelli che hanno scampato il contagio ma hanno perso i loro cari per mano dei malati del virus Maze. Il film segue Senan (Sam Keeley) inserito in un programma di riabilitazione che offre degli umili lavori ai convalescenti. Senan è fortunato perché, al contrario di tanti, è potuto tornare a vivere in famiglia, con la cognata (Ellen Page, anche produttrice del film) che ha perso il marito per mano di uno zombie ed è rimasta sola con il figlio di pochi anni. Senan viene contattato da un suo compagno dei 'tempi zombie', un ex notaio e politico, ora costretto a fare lo spazzino, che vuole mettere insieme un gruppo di contro-resistenza. Moltissime le tematiche che questa metafora vuole affrontare: colpa, castigo, riabilitazione, integrazione, AIDS, estremismo, terrorismo, repressione, con inevitabile eco del passato irlandese con l’IRA. Forse un po’ troppi temi che si perdonano per i buoni intenti politici e sociali, ma anche troppi effetti da 'salto sulla sedia indotto'.

Adriana Rosati
Segnata a vita da cinemini di parrocchia e dosi massicce di popcorn, oggi come da bambina, quando si spengono le luci in sala mi preparo a viaggiare.