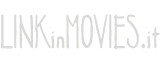Venezia 74: la nostra guida con i giudizi ai film
- Scritto da Francesco Siciliano, Davide Parpinel, Fabio Canessa, Massimo Volpe
- Pubblicato in Extra
- Stampa
- Commenta per primo!
 I giudizi a tutti i film visionati dai nostri inviati nelle varie sezioni della Mostra del Cinema di Venezia 2017. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 11 giorni. A cura di Francesco Siciliano, Davide Parpinel, Simone Tricarico, Fabio Canessa, Massimo Volpe
I giudizi a tutti i film visionati dai nostri inviati nelle varie sezioni della Mostra del Cinema di Venezia 2017. Appunti critici di un'avventura dello sguardo lunga 11 giorni. A cura di Francesco Siciliano, Davide Parpinel, Simone Tricarico, Fabio Canessa, Massimo Volpe
Venezia 74 - In concorso
 Downsizing, di Alexander Payne (Stati Uniti - Canada)
Downsizing, di Alexander Payne (Stati Uniti - Canada) ![]()
Alexander Payne apre la 74esima Mostra del Cinema di Venezia con una satira sociale sul futuro dell’umanità che ha lasciato un po' freddi i giornalisti accreditati (timidi gli applausi in sala a fine proiezione). Il regista, coadiuvato dal fido sceneggiatore Jim Taylor, immagina un mondo in cui il problema del sovrappopolamento della Terra e il conseguente eccessivo sfruttamento delle sue risorse viene risolto dalla scienza attraverso la scoperta di un trattamento per rimpicciolire le persone a un’altezza di una decina di centimetri. Umani che diventano più piccoli ma più felici, perché la vita da ‘rimpiccioliti’ comporta numerosi vantaggi economici. Nascono le prime comunità in miniatura, dove tutto (case, alimenti, autovetture) è più piccolo e costa meno rispetto al mondo a dimensione naturale. Una coppia di coniughi stressati dall’impossibilità di acquistare una casa si fa allettare dall’idea di sottoporsi al trattamento di rimpicciolimento che dovrebbe regalargli una vita più agiata, ma le cose non vanno come avevano previsto… Downsizing vive sullo schermo di felici intuizioni futuristiche (a cominciare da come prendono vita le comunità in miniatura), di ottimi dialoghi che scatenano più di una risata, di una buona alchimia (come ormai ci ha abituato il cinema di Payne) tra le componenti drammatiche e quelle più ridanciane della storia, ma la sua critica ironica e sottile alla società dei consumi si esaurisce nella prima parte, smarrendo poi il bandolo della matassa tra scorciatoie emotive e troppi temi appena abbozzati. Da Payne ci aspettavamo qualcosa in più. (Francesco Siciliano)
Leggi la nostra recensione: qui.
 First Reformed, di Paul Schrader (USA)
First Reformed, di Paul Schrader (USA)![]()
Paul Schrader al suo meglio. Ritiratosi in una piccola e antica chiesa frequentata ormai più da turisti che da fedeli Toller, un pastore ex cappellano militare, trascorre le giornate cercando di affrontare dissidi spirituali e demoni familiari legati alla morte del figlio, di cui si sente responsabile, e al successivo abbandono della moglie. L’incontro con un giovane attivista, un ambientalista radicale che vorrebbe far abortire la moglie nella convinzione che non ci sia un futuro per l’uomo sulla Terra, scatena in Toller una crisi ancora maggiore che lo spinge a compiere un gesto estremo come ribellione all’indifferenza della chiesa di fronte ai mali del mondo. First Reformed ripropone alcuni elementi ricorrenti del cinema di Schrader (in primis i personaggi alla ricerca di una redenzione in un mondo condannato all’autodistruzione e una visione pessimistica dell’umanità) ma con un impatto emotivo e visivo che non avevano gli ultimi lavori del regista americano. Il gusto geometrico delle inquadrature di Schrader è la cosa più bella del film: disegna splendidamente un perimetro opprimente invisibile che rappresenta la condizione in cui vive il protagonista e di riflesso la Chiesa, incapace di confrontarsi con le grandi sfide del mondo moderno (inquinamento, incomunicabilità dei giovani, crisi della Fede). Intenso e disturbante, con un finale al cardiopalmo. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui. The Shape of Water, di Guillermo del Toro (USA)
The Shape of Water, di Guillermo del Toro (USA)![]()
Calorosa accoglienza dei giornalisti per il debutto di Guillermo del Toro sugli schermi del Lido, ma il suo nuovo film, ad essere sinceri, ci ha lasciato piuttosto ‘indifferenti’. Sulla base di una sorta di reinvenzione in chiave fantasy-romantica del mito de la Bella e la Bestia, il regista messicano ricama una love story, ambientata durante la Guerra Fredda, tra una donna muta e un mostro anfibio prigioniero nelle mani di un’equipe di scienziati che lo sottopongono a cruenti esperimenti per capirne la natura. The Shape of Water è un inno all’amore che cancella le differenze, raccontato con il solito gusto post-moderno di del Toro: la messa in scena stilizzata è una compilation di riferimenti ai classici del passato, il racconto si reinventa di continuo grazie a un frullato di generi disparati (musical, spy-movie, horror, fantastico) che sprigionano adrenalina, il grande schermo sembra diventare uno spazio immaginifico di evasione collettiva come erano una volta le sale cinematografiche. Ma del Toro non ha il tocco magico di un Tim Burton e neanche l’estro di un Quentin Tarantino, due registi che superano i modelli di un cinema post-moderno semplicemente ammiccante. La confezione è impeccabile: quello che però manca è la poesia oltre l’artificio tecnico. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui. The Insult, di Ziad Doueiri (Libano-Francia)
The Insult, di Ziad Doueiri (Libano-Francia)
![]()
Le tensioni sociali e religiose nel Medio Oriente in un film ambientato a Beirut, con protagonisti due uomini, uno un libanese cristiano, l’altro un palestinese rifugiato, nemici in tribunale per una querela dopo che il primo ha rivolto un insulto che lede la dignità del secondo durante un litigio. “Ariel Sharon avrebbe dovuto sterminarvi tutti” è la frase incriminata: ne segue un lungo dibattito che dalle aule dei tribunali si sposta piano piano nelle strade, sui giornali, tra le mura domestiche delle abitazioni, scatenando un rancore mai sopito tra cristiani e arabi che si tramuta ben presto in atti violenti. Ziad Doueiri si ritrova tra le mani una sceneggiatura ben calibrata nel mettere a fuoco i pregiudizi che affondano le loro radici in un passato storico in cui il ruolo di vittima e carnefice dei molteplici scontri etnici in Medio Oriente non è sempre ben chiaro: ognuno sembra avere il suo carico di responsabilità, è il messaggio nella bottiglia. Lo stile è grezzo e di derivazione televisiva (le immagini e il commento sonoro bombardano lo spettatore di ‘emozioni indotte’ anziché accompagnarlo in un percorso di comprensione), ma su tutto prevale la capacità del film di mettere in discussione le nostre certezze nel ginepraio di accuse reciproche che domina la vita pubblica delle varie appartenenze nel Medio Oriente. Quando si dice: il fine giustifica i mezzi. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui. Human Flow, di Ai Weiwei (Germania)
Human Flow, di Ai Weiwei (Germania)
![]()
Era uno dei film più attesi alla Mostra del Cinema: per la firma del regista (un nome importante nel cinema documentaristico oltre che nell’arte) ma soprattutto per il tema che tratta, ovvero il fenomeno dei flussi migratori ormai al centro delle cronache quotidiane. Aspettative non deluse: girato in 23 Paesi nel corso di un anno, il film mostra la condizione dei profughi nei loro spostamenti, in particolare dall’Africa e dal Medio Oriente verso l’Europa, evitando accuratamente di scadere nel classico sensazionalismo e patetismo che questo tipo di storie richiamano. Ai Weiwei si affida a un registro estremamente realistico (spesso utilizzando gli smartphone per le riprese), forse stilisticamente non appariscente ma molto incisivo, con riprese che ritraggono la quotidianità dei rifugiati nei respingimenti alla frontiera, negli sbarchi clandestini, nelle giornate nei campi profughi, nei viaggi della speranza dall’Europa del Sud a quella del Nord. Interviste a politici, operatori umanitari e migranti in viaggio e numeri sul fenomeno sovraimpressi alle immagini arricchiscono ulteriormente l’esperienza della visione di un documentario d’impegno civile che, senza tesi preconcette, mette lo spettatore di fronte a una realtà, spingendolo a interrogarsi su essa. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
![]()
Charley è un quattordicenne giunto da poco a Portland. Non ha una vita da adolescente come i suoi coetanei: la madre lo ha abbandonato, il padre è un donnaiolo impenitente e girovago senza un lavoro stabile, a casa il cibo scarseggia e la scuola non è tra le sue attività quotidiane. Dopo che il padre muore a causa di un’aggressione per mano del marito della sua ultima fiamma, il ragazzino intraprende un viaggio da solo per raggiungere l’unica persona che potrebbe aiutarlo a evitare l’affidamento ai servizi sociali: una zia che vive nel Wyoming. Ad accompagnare Charley c’è Lean on Pete, un cavallo a cui il giovane si è affezionato mentre lavorava in nero per conto di un vecchio allevatore di cavalli. Andrew Haigh porta sullo schermo la realtà di una vita ai margini di un’adolescenza senza punti di riferimento, abbandonata a se stessa, con un film a tema impeccabile nel suo svolgimento tanto quanto avaro di emozioni. Cinema di scrittura più che di immagini: un bel compitino, svolto con mestiere, privo però di un guizzo cinematografico in grado di dare profondità alle emozioni. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui. Foxtrot, di Samuel Maoz (Israele-Francia-Germania-Svizzera)
Foxtrot, di Samuel Maoz (Israele-Francia-Germania-Svizzera)![]()
A otto anni dal Leone d’oro per Lebanon, Samuel Maoz torna a Venezia con il suo secondo film. Michael e Dafna ricevono la notizia che il loro figlio Jonathan, un giovane soldato dell’esercito israeliano, è deceduto. Dopo lo shock iniziale, i due genitori scoprono che in realtà c’è stato uno scambio di persona e che il loro figlio è ancora vivo. Infuriato per l’accaduto, Michael trova il modo di far richiamare Jonathan a casa per essere sicuro che stia veramente bene. Una decisione che avrà esiti imprevisti. Nel cinema di Maoz ancora soldati, ancora conflitti, ancora drammi legati al perenne stato di allerta in cui vive il popolo israeliano, ma questa volta l’attenzione del regista si sposta in uno spazio di analisi più privato e intimo, in cui prende forma una riflessione tragica sul concetto di destino e sui suoi imprevedibili sviluppi provocati dalle circostanze e dalle persone che ci circondano. Una visione fatalista colma di pessimismo quella di Maoz, che a momenti di surreale ironia alterna frangenti di forte impatto drammatico, nell’affannosa ricerca di un equilibrio non sempre ben calibrato. Seppur imperfetto e lontano dalla dirompenza di Lebanon, Foxtrot ha dalla sua qualità di scrittura e di messa in scena che catturano lo spettatore. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
![]()
Uno dei punti più bassi del concorso della Mostra del Cinema di Venezia. Un film irritante, inverosimile, ombelicale. Tre fratelli si riuniscono dopo che il padre viene colpito da un ictus nella sua casa in una piccola baia vicino Marsiglia. L’occasione diventa per i tre un momento per tracciare un bilancio dei rapporti familiari, per riflettere sulle proprie vite e per riavvicinarsi ai luoghi dell’infanzia in una comunità in cui aleggiava uno spirito comunitario che la modernità ha cancellato. Tra lunghe chiacchierate a tavola sorseggiando vino rosso, aforismi sull’arte, la politica e la società dispensati nei momenti di routine quotidiana, amori passionali che nascono e muoiono con disinvoltura, La villa è l’espressione radical-chic di un cinema francese anacronistico e programmatico: con i suoi personaggi stereotipati che parlano come un libro stampato (il culmine è il personaggio di un giovane pescatore che recita i versi di Claudel, sic!) e con le sue implicazioni politiche che forzano le dinamiche narrative (vedi la tentazione di raccontare verso la fine il dramma dei rifugiati che mal si amalgama con quello vissuto dai personaggi), il lavoro di Guédiguian risulta sterile e artificiale, lontano un miglio da quella realtà attorno a noi che vorrebbe tanto raccontare. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
![]() Suburbicon, di George Clooney (USA)
Suburbicon, di George Clooney (USA)![]()
Anni Cinquanta. La quiete della comunità di Suburbicon, una piccola e idilliaca cittadina degli Stati Uniti, fatta di confortevoli villette a schiera, prati ben curati, grandi centri commerciali, viene sconvolta dall’arrivo di una famiglia di colore, contro cui i residenti scagliano un odio razziale che si tramuta ben presto in atti violenti. La presenza dei nuovi arrivati oscura la tragedia che si sta consumando a pochi passi dalla loro casa, nell’abitazione della famiglia Lodge, dove l’uccisione misteriosa di una donna paralizzata dà il via a una serie di eventi sanguinosi… Passo falso per George Clooney. Il film vorrebbe essere una commedia nera sullo strabismo bigotto di una società che guarda ai suoi problemi nella direzione sbagliata. Il risultato finale, però, sembra in tutto e per tutto una brutta copia di una pellicola dei fratelli Coen (che non a caso sono gli autori della sceneggiatura): stessi personaggi, stesse atmosfere, stesso gusto dell’assurdo, ma poca personalità di Clooney nel fare sua una storia che non è nelle sue corde. Rivogliamo il regista di Good Night, and Good Luck e Le idi di marzo. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
 The Leisure Seeker (Ella & John), di Paolo Virzì (Italia)
The Leisure Seeker (Ella & John), di Paolo Virzì (Italia) ![]()
Esordio in lingua inglese per il nostrano Paolo Virzì: un road movie con protagonisti una coppia di coniugi, un uomo affetto da Alzheimer e una donna colpita da un tumore i quali, per fuggire alle cure mediche che li avrebbero costretti a separarsi, decidono di compiere un viaggio in camper. Una storia che celebra un amore coniugale, nulla di più: Virzì si concentra sugli affetti, troppo, stringendo la macchina da presa sui corpi e i volti dei personaggi fino ad escludere tutto il resto. Monocorde nello svolgimento, non sempre calibrato bene nei tempi comici, incapace di sfruttare appieno l’apporto dei paesaggi (come ci si aspetterebbe da ogni road movie che si rispetti), il film mette in scena buoni sentimenti senza particolari peculiarità. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
![]()
Darren Aronofsky torna per la quarta volta a Venezia e il pubblico della Mostra del Cinema si ritrova spiazzato da un film estremo, provocatorio e coraggioso. Una coppia di coniugi vive nella quiete di una vecchia casa di campagna circondata dal verde: lui è un famoso scrittore di mezza età in crisi d’ispirazione, lei una giovane ragazza che si prende cura del marito per aiutarlo a recuperare la verve artistica. Un giorno un uomo misterioso in cerca di un alloggio bussa alla porta della loro abitazione: lo scrittore, incuriosito dalla visita, lo invita a fermarsi per la notte nella sua casa. Da quel momento le cose precipiteranno in una spirale drammatica che sconvolgerà gli equilibri della coppia. mother! è un sogno allucinato, delirante e metaforico che riporta il cinema di Aronofsky a una forma radicale e respingente, più vicina a quella immaginifica di The Fountain che a quella crepuscolare di The Wrestler, dopo alcuni progetti con cui si è riguadagnato la fiducia degli studios americani. Un Aronofsky primordiale e furente, come piace a noi. Attraverso un piccolo microcosmo domestico devastato da uno squilibrio tra l’ambizione artistica di un uomo che antepone se stesso agli altri e l’amore prima coniugale e poi materno di una donna che dà tutta se stessa senza ricevere nulla in cambio, il regista affronta le pulsioni più profonde e distruttive dell’uomo, come il narcisismo, l’avidità, la brama del successo, con una storia dai risvolti inaspettati che si presta a varie chiavi di letture e un gigantismo visionario che scuote lo spettatore. Spiace che i critici abbiano accolto con fischi e ‘buu’ i titoli di coda del film (come ai tempi di The Fountain), straniati da un lavoro indecifrabile che chiede allo spettatore solo di innalzare il livello di sospensione dell’incredulità, cosa che ad alcuni registi viene concessa senza remore qui alla Mostra (il pensierio va al sopravvalutato del Toro) mentre ad altri no. Chissà perché poi… Noi ci teniamo stretto Aronofsky e lasciamo che gli altri si godano le fiabe per adulti trite e ritrite di del Toro. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
![]()
Nella galleria delle istituzioni pubbliche e private ritratte da Frederick Wiseman si aggiunge un nuovo tassello: la New York Public Library. Il regista americano entra nel perimetro della storica biblioteca per raccontarne non solo il valore culturale di centro del sapere ma soprattutto sociale di luogo di accoglienza e apprendimento per varie classi sociali. Scrutando come in un dietro le quinte le persone e le storie che popolano ogni giorno la biblioteca (attraverso i volti e le parole di dirigenti, lavoratori, semplici fruitori, oltre a quelli di accademici e artisti che la scelgono per i loro eventi), la macchina da presa ci immerge in quello che è a tutti gli effetti un centro comunitario che offre non solo libri, ma anche i più svariati servizi per i cittadini. Ne viene fuori un bel ritratto in filigrana di New York e dei suoi abitanti in cui Wiseman riduce al minimo ogni ingerenza del mezzo tecnico. Documentario puro nella forma e semplice nelle intenzioni cui si può contestare solo una certa prolissità e ripetitività di alcune situazioni. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.

![]()
Grande curiosità per Hirokazu Koreeda, che sbarca a Venezia ventidue anni dopo Maborosi (che vinse un premio tecnico alla 52esima Mostra) con il suo primo ‘film di genere’, un legal thriller che però affonda le sue radici nelle problematiche famigliari, da sempre spazio privilegiato di analisi del regista. Se la vicenda raccontata sembra seguire un canovaccio apparentemente classico (un team di avvocati deve evitare che un tribunale condanni a morte un loro assistito, un uomo accusato di aver commesso un brutale omicidio), tutt’altro si può dire degli spunti di riflessioni riversati nella sceneggiatura, sviscerati con mano sicura da una regia che dosa sapientemente un senso di continuo confronto con una ricerca della verità che fatica a emergere. Koreeda si interroga su temi complessi come i confini labili che separano giustizia e giustizialismo, mettendo lo spettatore di fronte a una storia in cui regna l’ambiguità e si moltiplicano i punti di vista sulla reale o meno colpevolezza dell’accusato. The Third Murder finisce così per essere un film complesso e sfaccettato, difficile da inquadrare con una sola visione, ma solido nella scrittura e nella regia. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh (Regno Unito)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh (Regno Unito)![]()
Atteso ed applaudito con forza, desiderato che fosse così com’è e assaporato con gioia in ogni suo istante. Questa è stata la reazione del pubblico della Mostra alla visione del nuovo film del talentuoso regista inglese Martin McDonagh, intitolato Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Il titolo dice già molto identificando una precisa parte della società americana, bonacciona e credulona, per raccontare una storia di ricerca della verità e false apparenze. La protagonista è Mildred, una sempre entusiasmante Frances McDormand, la quale un giorno affigge tre manifesti fuori dalla città di Ebbing in cui chiede allo sceriffo locale di proseguire le indagini prematuramente interrotte sulla morte per stupro della figlia. La comunità è piccola e non accetta benevolmente il gesto della donna. Quando lo sceriffo muore, anzi si suicida perché malato terminale, qualcosa cambia in tutti e il crescere della violenza che poteva innescare questa morte, perché venuto a mancare il perno della società, lo sceriffo, si spezza subito, perché un altro sentimento prende spazio, l'amore. McDonagh è sapiente nel condurre chi guarda dentro questo mondo, proponendo una struttura narrativa che ricalca l'animo umano: rabbioso e compassionevole, divertente e sarcastico, ironico e divertito, perché è mutevole come la natura. (Davide Parpinel)
Leggi la nostra recensione: qui.
 Una famiglia, di Sebastiano Riso (Italia)
Una famiglia, di Sebastiano Riso (Italia)![]()
Secondo film italiano presentato nel concorso della Mostra 2017 e opera seconda per il regista siciliano di Più buio di mezzanotte, Sebastiano Riso. La storia di Una famiglia si concentra su Maria e Vincenzo e la famiglia che non potranno mai avere. L'uomo infatti vende clandestinamente i figli da loro avuti. Per Maria la situazione così com’è non può andare avanti per molto e chiede, quindi, disperatamente al suo compagno di avere una loro famiglia e, così, essere una madre vera. Vincenzo non la ascolta e la gravidanza va avanti. Al suo termine, però, la contrattazione con la coppia affidataria non va come dovrebbe a causa di alcuni problemi del nascituro. L'animo da madre di Maria, quindi, prende finalmente il sopravvento. Arrivare a questa ricostruzione della storia non è facile, in quanto il regista fornisce pochissimi indizi per la sua definizione. Ciò su cui si focalizza Riso è il pianto di Maria, l'espressione sempre contrita in una possibile esplosione di lacrima a cui Micaela Ramazzotti, interprete della donna, aggiunge una finta smorfia di tristezza. Il film inizia e finisce qui. Non c'è analisi del personaggio, non c'è descrizione della sua storia o del motivo per cui sia costretta a vivere così, non c'è nemmeno la speranza di una risoluzione. Solo un lento seguire distaccatamente la vita quotidiana di una donna che vive sempre chiusa in casa. (D.P.)
Leggi la nostra recensione: qui. Jia Nian Hua (Angels Wear White), di Vivian Qu (Cina-Francia)
Jia Nian Hua (Angels Wear White), di Vivian Qu (Cina-Francia)![]()
In una cittadina di mare nel Sud della Cina due adolescenti vengono adescate da un uomo di mezza età con cui consumano un rapporto sessuale nella stanza di un hotel. La perdita della verginità delle due ragazzine non passa inosservata ai rispettivi genitori, che si rivolgono alla polizia per far luce sull’accaduto. L’unica persona che potrebbe chiarire se l’uomo ha abusato delle ragazzine è una sedicenne che quel giorno era di turno alla reception dell’albergo. La ricerca della verità si scontrerà ben presto con interessi personali ed economici che prevalgono sulla sete di giustizia. Regista, sceneggiatrice e produttrice, figura centrale della nuova generazione di autori in Cina (ha partecipato alla realizzazione di Fuochi d’artificio in pieno giorno di Diao Yi’nan, Orso d’oro alla Berlinale 2014), Vivian Qu firma un’opera seconda che, come altri lavori del cinema indipendente cinese contemporaneo, si sviluppa come un film di denuncia sotto le mentite spoglie di una storia che sembra uscita dalle pagine della cronaca. Molti film cinesi hanno già ampiamente raccontato come il denaro abbia corroso i rapporti umani. Il film della Qu fa però un passo in avanti, mettendo in scena in tutta la sua crudezza un’agghiacciante voracità che non si ferma più alla rincorsa all’arricchimento e alla conquista di beni di lusso: una voracità che va oltre finendo per comprare il ‘possesso’ delle persone, della loro volontà (alla fine i genitori di una delle due ragazzine rinunceranno a denunciare l’uomo accusato in cambio della promessa di quest’ultimo di pagare gli studi alla loro figlia), perfino della verginità di adolescenti o di quella di giovani donne tentate di sacrificarla per esaudire i desideri di uomini pronti a ricoprirle di soldi. Angels Wear White ha dalla sua uno sguardo carico di umanità ma allo stesso tempo lucido e distaccato che fotografa la condizione di un campionario intergenerazionale di individui di una società che plasma i valori secondo bisogni indotti o false percezioni. (F.S.)
Leggi la nostra recensione: qui.
 Mektoub, My Love: Canto uno, di Abdellatif Kechiche (Francia-Italia-Tunisia)
Mektoub, My Love: Canto uno, di Abdellatif Kechiche (Francia-Italia-Tunisia)![]()
Primo capitolo di una trilogia ancora in corso d’opera, il nuovo film di Abdellatif Kechiche segna una inaspettata battuta d’arresto per un regista che soli pochi anni fa aveva vinto una Palma d’oro a Cannes. Ambientato in piena estate nei primi anni Novanta in una imprecisata e ridente località balneare nel Sud della Francia, è la storia di un gruppo di giovani di origine magrebina, ragazzi belli e impossibili e fanciulle disinibite e conturbanti alla ricerca di facili amori e avventure poco galanti, in una sfrenata e orgiastica dolce vita tra spiagge, ristoranti, discoteche, pub. È indubbio il talento di Kechiche nel trascinare lo spettatore al centro della scena, con una fluidità e naturalezza che pochi altri registi possono vantare, grazie all’uso di una macchina da presa a mano che rende palpitante ogni dialogo e ogni situazione. Quello che questa volta non ci convince è che cotanto dispendio di padronanza del mezzo tecnico si traduce in un voyeurismo fine a se stesso, più vicino al feticismo erotico di silhouette femminili di Russ Meyer che a quella leggerezza rohmeriana a cui vorrebbe ambire. Lo sguardo dello spettatore viene calamitato da un tripudio di corpi dalla sensualità esuberante (abbondano dettagli anatomici di tette, culi e dorsi maschili scoperti), una carnalità attraverso cui Kechiche vorrebbe trasmettere un senso di libertà come espressione più profonda della vita. Peccato che il tutto risulti vacuo e inconcludente a causa di una lunga sequela di situazioni, dialoghi e azioni che non sembrano avere una briciola di giustificazione narrativa. (F.S.)
Fuori Concorso

![]()
Non vogliamo peccare di lesa maestà nei confronti di uno dei mostri sacri del cinema se diciamo che il suo ultimo lavoro più che un documentario sembra un contenuto extra di una prossima riedizione de L’esorcista. Sì, perché The Devil and Father Amorth, che riprende il tema degli esorcismi di uno dei cult della storia del cinema facendoci ritornare anche sui luoghi in cui il film era stato girato, pecca un po' di inconsistenza nonostante le intenzioni del regista siano quelle di farne una indagine sulla natura delle cosiddette possessioni. Al di là della testimonianza diretta di un esorcismo praticato a Roma da Padre Amorth (considerato il decano degli esorcisti, morto lo scorso anno), il documentario offre poco altro per chi non è un nostalgico del film del 1973, ma qualche brivido lungo la schiena è assicurato. (F.S.)
Orizzonti

![]()
Se il cinema iraniano si è fatto conoscere in passato soprattutto per film con ambientazione rurale, negli ultimi anni si è posto all'attenzione internazionale invece per lungometraggi urbani e con protagonista la nuova borghesia cittadina del Paese. L'esempio più alto è quello rappresentato dalle storie scritte e dirette da Asghar Fahradi. In questo filone si inserisce il film di Vahid Jalilvand, tanto da ricordare subito l'opera del maestro del cinema iraniano contemporaneo. Grande attenzione alla scrittura, allo sviluppo del racconto, alla credibilità della recitazione, alle relazioni tra i personaggi. Il tutto al servizio di una storia che riflette con grande interesse su senso di responsabilità e morale (il protagonista, un medico, provoca un incidente stradale che potrebbe essere la causa della morte, successiva, di un bambino anche se la prima autopsia parla di avvelenamento da botulino), descrivendo più in generale la trasformazione di un Paese dove anche le donne ricoprono ruoli importanti nella società e si dimostrano spesso più forti degli uomini. (Fabio Canessa)

![]()
Scoprendo che il regista è stato assistente di Asghar Farhadi ti aspetti di ritrovare nel film qualche elemento del cinema del grande autore iraniano. Niente di tutto questo. Anzi, si potrebbe dire che il lavoro di Alireza Khatami sta gli antipodi rispetto alla rappresentazione della realtà portata sullo schermo da Farhadi con sceneggiature che sviluppano trame in modo perfetto. Khatami al contrario non punta tanto sulla scrittura, ma lavora soprattutto sulle immagini e il simbolismo per raccontare la storia con protagonista l'anziano custode di un cimitero che ricorda qualsiasi cosa, eccetto i nomi. Tra i Paesi di questa coproduzione internazionale figura anche il Cile e i riferimenti ai desaparecidos riportano al suo triste, recente passato. La riflessione su abusi del potere e memoria, però, si può sicuramente allargare a tanti Paesi e non solo del Sudamerica. E diventa così universale. Ammantato di realismo magico, con simbolismi non sempre facili da decifrare, risulta anche per questo non molto organico nel suo sviluppo. Ma sicuramente affascinante nella sua costruzione, con curate inquadrature fisse. (F.C.) Krieg, di Rick Ostermann (Germania)
Krieg, di Rick Ostermann (Germania)![]()
Il racconto di Krieg, opera seconda del regista tedesco Rick Ostermann, già passato sugli schermi della rassegna Orizzonti nel 2013, si svolge su un duplice piano temporale parallelo: un presente in cui vediamo il protagonista che giunge in una baita di montagna isolata e un passato molto prossimo nel quale lo vediamo nella sua casa di città con la sua famiglia: la decisione del figlio di arruolarsi e partire per la guerra in Oriente cozza con gli ideali pacifisti della famiglia e quando il ragazzo ci lascia le penne, il protagonista decide di isolarsi dal mondo insieme al suo cane nell’eremo innevato tra le montagne dove però dovrà affrontare un misterioso nemico che non lesina le azioni violente. La tematica della guerra e dei suoi effetti è sviluppata in modo stantio e per nulla convincente, quella dell’eremita che si isola per espiare qualche colpa interiore scontrandosi con un nemico invisibile, metaforica proiezione della sua rabbia e del suo rimorso, è fin troppo sfacciata e la riflessione conclusiva che la violenza governa il mondo non solo nei teatri di guerra ma anche tra le nevi immacolate di un posto fiabesco e soprattutto dentro sé stessi appare troppo debole. Nonostante i tentativi del regista anche la suspense e il disagio che vorrebbe creare sono esilissimi e alla fine quello che rimane di Krieg è la bellezza mozzafiato dei paesaggi montani e pochissimo altro. (Massimo Volpe) La nuit ou j'ai nage (The Night I Swam), di Damien Manivel e Kohei Igarashi (Giappone-Francia)
La nuit ou j'ai nage (The Night I Swam), di Damien Manivel e Kohei Igarashi (Giappone-Francia)![]()
Frutto di un curioso binomio franco-nipponico composto da due registi (Damien Manivel e Kohei Igarashi), entrambi con un buon esordio alle spalle, La nuit ou j'ai nage (The Night I Swam) è un piccolo lavoro intriso di minimalismo ermetico che galleggia ai confini del cinema di sperimentazione. Lungo gli ottanta minuti che costruiscono il film viene raccontata una giornata particolare del nostro piccolo eroe, un ragazzino di sei anni, che inizia la sua giornata come sempre, origliando il padre che si sveglia presto per andare al lavoro e prosegue con una fuga dal mondo di tutti i giorni attraverso un paesaggio dominato dal bianco della neve, Per un giorno il piccoletto si comporta da grande vagando per i campi coperti di neve, salendo su un treno che si fa strada nella neve, girovagando per una città sepolta dalla neve e trovando rifugio in una macchina sotto un cumulo di neve. L’infanzia che cerca i suoi confini ed il legame silenzioso con la figura paterna fanno da tessuto connettivo al racconto che si snoda senza alcun dialogo ma ben sostenuto da un efficace sonoro, nel quale la figura del piccolo Tamara Kogawa riesce a colorarsi di tinte quasi eroiche. Lavoro originale che proprio nel suo minimalismo narrativo trova la forza di tenersi in piedi regalando comunque qualcosa sia visivamente che a livello di racconto. (M.V.) Disappearance, di Ali Asgari (Iran-Qatar)
Disappearance, di Ali Asgari (Iran-Qatar)![]()
L’opera prima del regista iraniano Ali Asgari è il racconto di una piccola odissea notturna di due giovani fidanzati tra gli ospedali di Teheran: i rapporti sessuali prima del matrimonio non solo sono contrari alla morale e alla tradizione, ma sono anche perseguiti dalla legge coranica, motivo per il quale la giovane protagonista, che soffre di una emorragia dopo aver perso la verginità, si ritrova a vagare cercando una soluzione al problema senza che ciò comporti problemi con la famiglia e con la legge. I due prima inventano uno stupro, poi si spacciano come novelli sposi, alla fine neppure la verità raccontata ai medici porta a una risoluzione del problema. Il film è uno spaccato dell’universo giovanile iraniano e della sua incapacità a relazionarsi con le rigide regole che governano la società: non bastano gli i-Phone né la musica rock a regalare ai giovani la loro piena libertà che rischia di sfociare nella ribellione. Nel suo nucleo narrativo il film è interessante, il suo svolgimento però ben presto si adagia su toni monocordi e ripetitivi. Il regista sembra abbracciare lo stile che si impronta sull’uso quasi esasperato della macchina da presa che bracca da vicino i protagonisti. Ali Asgari sembra avere stoffa, ma aspettiamo il suo prossimo lavoro per capirne appieno le capacità e il talento. (M.V.)
Giornate degli Autori - Venice Days

![]()
Un’attrice di soap opera vuole liberarsi del marito impotente, famoso artista francese che la costringe a subire le avance di un santone a capo di un’ambigua setta religiosa a cui è legato. Decide così di ingaggiare un uomo per far uccidere e sparire il marito, ma il piano non va a buon fine. La donna fugge, ma il capo della setta si mette sulle sue tracce, deciso a non volersi separare da lei... Pen-ek Ratanaruang gioca con le atmosfere del thriller con lo sguardo puntato sulla condizione femminile in una società dominata dalle figure maschili. Come da tradizione, il regista thailandese condisce la storia di elementi carichi di mistero, con personaggi che mutano sembianze, altri che spariscono di colpo, e di atmosfere gelide sottilmente ‘inquietanti’, ma se lo stile non si discute, altrettanto non si può dire dell’impianto narrativo che appare pretestuoso, troppo piegato alle logiche della metafora. (F.S.)

![]()
Una donna divorziata appartenente alla minoranza Dai fa ritorno al suo villaggio natio in una zona rurale della Cina in cui la modernità non sembra ancora arrivata. Lo scopo del viaggio è riconciliarsi con la figlia, una tredicenne di cui vorrebbe prendersi cura dopo averla lasciata in affidamento al nonno per andare a lavorare in città. La ragazzina non ha mai accettato l’abbandono della madre e ha un carattere un po' ribelle: non sarà facile per la donna ricostruire un rapporto con lei. Pengfei aveva piacevolmente sorpreso con il suo debutto Underground Fragrance, un film incentrato sulle difficili condizioni di vita di chi sceglie di trasferirsi dalla campagna alla città. Con The Taste of Rice Flower, il regista segue invece le vicissitudini di chi compie il percorso inverso, dalla grande città alla campagna, in una sorta di controcampo del lavoro precedente che conferma le sue doti di attento osservatore dei nuovi spazi di mutamento della Cina. Il faticoso percorso di riavvicinamento della protagonista a una realtà e a una dimensione familiare da cui era fuggita si trasforma in un film poetico che ha i suoi punti di forza nella scoperta di una comunità ancorata alle proprie tradizioni e nei non detti dei personaggi. (F.S.)
Biennale College
![]()
Leggi nella presentazione “outback australiano”, “mondo folle” e il pensiero corre immediatamente a Wake in Fright. Con il film cult firmato da Ted Kotcheff agli inizi degli anni Settanta, il lungometraggio diretto dalla giovane Alena Lodkina condivide in realtà poco e niente. E anche l’ambientazione è più quella del bush, con la sua vegetazione arbustiva, che vero outback desertico. Qui la protagonista trova una piccola comunità di minatori che cercano di sfruttare i giacimenti di opale. Tra questi c’è il padre che la ragazza è venuta a trovare, dopo tanto tempo, perché l’uomo si è ammalato. Prima di morire quest’ultimo sembra voler riallacciare il rapporto con la figlia, ma la distanza che li separa forse è incolmabile. La preoccupazione maggiore della regista sembra essere la misura. Tutto è contenuto. Dalla recitazione ai movimenti di macchina fino all’accompagnamento sonoro. Le stesse emozioni dei personaggi sono trattenute, si specchiano disperdendosi in quel territorio inospitale quanto affascinante. Da ultima frontiera. Alla fine tutto scivola in modo troppo monocorde per lasciare il segno, ma considerando che si tratta di un’opera prima la visione spinge a tenere d’occhio il futuro della regista. (F.C.)
- Mostra del Cinema di Venezia 2017
- Downsizing
- First Reformed
- The Devil and Father Amorth
- The Insult
- Human Flow
- The Shape of Water
- Samui Song
- Strange Colours
- Lean on Pete
- Foxtrot
- La villa
- The Leisure Seeker
- Suburbicon
- The Taste of Rice Flower
- mother!
- Los versors del olvido
- No Date, No Signature
- Una famiglia
- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
- The Third Murder
- EX LIBRIS The New York Public Library
- Angels Wear White
- Mektoub, My Love: Canto uno
- Krieg
- La nuit ou j'ai nage
- Disappearance
Articoli correlati (da tag)
- Strange Colours - Recensione (Venezia 74 - Biennale College)
- Mi Hua Zhi Wei (The Taste of Rice Flower) - Recensione (Venezia 74 - Giornate degli Autori)
- Mai Mee Samui Samrab Ter (Samui Song) - Recensione (Venezia 74 - Giornate degli Autori)
- Disappearance - Recensione (Venezia 74 - Orizzonti)
- Takara - La nuit où j'ai nagé (The Night I Swam) - Recensione (Venezia 74 - Orizzonti)